|
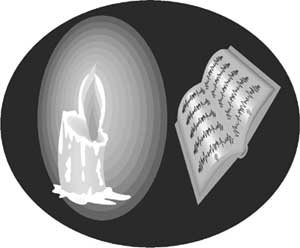
“Tutto nel mondo sta dando risposte,
quel che tarda è il tempo delle domande.”
José Saramago
 La necessaria
essenzialità di un semplice “no”
La necessaria
essenzialità di un semplice “no”
C’eravamo abituati al fatto che i premi Nobel per la
letteratura fossero il coronamento di un percorso, contrassegnato
da lampi e folgori in un cielo plumbeo, dove lo scrittore era
stato capace di squarciare indelebilmente l’opaca atmosfera
quotidiana dell’usuale. Ugualmente avevamo assistito all’ineluttabile
tramonto di chi – giunto alla sommità – si
concedeva il meritato riposo, attorniato da studiati commiati
e referenziali applausi.
Fortuna vuole che l’opera di José Saramago (unico
scrittore di lingua portoghese insignito del premio Nobel per
la letteratura, nel 1998) abbia sparigliato ancora una volta
le carte, ripercorrendo a ritroso la strada fin qui intrapresa.
Una strada contrassegnata da continui e ripetuti “no”;
quei “no” che lo stesso autore in un’intervista
afferma di aver ribadito “molte volte, forse troppe, perché
in quel momento non ne valeva la pena e forse non convinceva
nessuno”, ma che rappresentano in definitiva le uniche
parole necessarie, le sole parole essenziali, capaci di affermare
la propria distanza dalle belanti voci del coro.
Coerente ad un simile proposito, Saramago si è sempre
mostrato refrattario alle lusinghe di una notorietà conquistata
faticosamente, cogliendo ogni momento del suo scrivere per creare
stadi d’inquietudine nei lettori e fastidi in una critica
abituata ad officiare tributi a chi non è più
ciò che voleva essere.
Così, alla veneranda età di ottantadue anni, il
poeta lusitano, dando alle stampe il suo nuovo “Saggio”,
si è regalato il lusso di un ulteriore “no”
sbattuto in faccia alla forma più rispettata, acclamata,
reclamizzata dal potere: la democrazia. Nel farlo è stato
però molto attento a porre la sua critica sociale in
continuità letteraria con ciò che ha sempre caratterizzato
la sua poetica comunicativa, composta di parabole atte a rendere
comprensibile la realtà, celata dietro l’abitudine
di trovare risposte pronte pur di non porsi domande inquietanti.
Ensaio sobre a Lucidez (“Saggio sulla lucidità”),
espressamente si richiama ad uno dei precedenti capolavori,
Ensaio sobre a Cegueira (pubblicato nel 1995 e tradotto
in italiano nel 1996 col titolo abbreviato in “Cecità”)
–, dove la ricerca di elaborare una poesia critica ai
tanti problemi del vivere umano si coniuga con una feroce accusa
nei confronti dei meccanismi di controllo, consenso, repressione
del sistema dominante. Ed è proprio nel cercar di seguire
il percorso narrativo intrecciato fra queste due opere, che
vorremmo osservare lo spessore stilistico e la profondità
analitica caratterizzanti l’agire poetico/filosofico del
Premio Nobel lusitano.
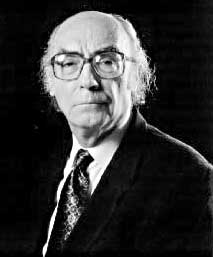 José
Saramago José
Saramago
 Romanzo come
saggio, trattato, memoriale, storia
Romanzo come
saggio, trattato, memoriale, storia
Occorre innanzitutto comprendere che le opere di José
Saramago confessano l’impegno nel giustificare la letteratura
al pari di un viaggio, da percorrere in compagnia del lettore,
verso un luogo la cui conoscenza descrittiva non è di
per sé bastante. L’indagine, l’analisi, il
commento, appaiono infatti essere gli elementi caratterizzanti
il linguaggio poetico del lusitano, che ricerca nel lettore
il complice del farsi narrativo, non nella veste di chi assiste
all’evento descritto, ma di correo dell’evento stesso.
Alcuni dei suoi più significativi romanzi assumono –
sin dal titolo – l’austera e grave dicitura di “trattato”,
“memoriale”, “storia”, “saggio”,
volendo in tal modo sottolineare che la letteratura non è
un semplice divertissement, un accontentarsi di raccontare
– come direbbe Fernando Pessoa per bocca dell’eteronimo
Ricardo Reis – “lo spettacolo del mondo”.
Perché Saramago è sì un grande, straordinario,
inventore di “storie”, però è soprattutto
un creatore di “parabole” per comprendere l’essere
umano nella sua cruda essenzialità.
Come la critica letteraria ha ampiamente documentato (e ci riferiamo
in particolar modo agli studi di Luciana Stegagno Picchio e
Paolo Collo, cui queste note sono in parte fortemente debitrici)
la produzione poetica di José Saramago è caratterizzata
da trasformazioni stilistiche che precisano sempre più
radicalmente il suo rapporto ostile, estraneo, indifferente,
con una “letteratura” – come l’autore
stesso si espresse in un’intervista – che non sia
“parte della Vita, del Tempo, della Cultura, della Società”.
Sarebbe però limitante considerare tutto ciò una
riedizione della “letteratura d’impegno”,
è piuttosto un impegno che la letteratura si assume nell’affrontare
la realtà sociale come materiale critico a cui fornire
forma stilistica.
La letteratura diviene così una forma stilistica in grado
di riappropriarsi della realtà in quanto può meglio
osservarla – addirittura sentirla – in
profondità, e nel far ciò supera la sua essenza
descrittiva di superficie, per divenire “storia”,
“saggio”. Non più soltanto un “romanzo”.
Ma del romanzo conserva l’armoniosa virtù di un
sapere narrato a più voci: quella dell’autore,
dei personaggi, dei lettori.
 Linguaggio
scritto per l’orecchio
Linguaggio
scritto per l’orecchio
Proprio lo “stile orale”, a più voci, caratterizza
la prosa letteraria di José Saramago che si impone prepotentemente
con la pubblicazione di Levantado do Chão (“Alzato
dal suolo”, tradotto in italiano col titolo “Una
terra chiamata Alentejo”), romanzo del 1980. In quell’occasione
si osservava la profonda trasformazione stilistica dell’autore
rispetto alle prime poesie, cronache, racconti e testi teatrali,
preoccupati principalmente dell’elaborazione di un linguaggio
di stretta osservanza logico-cartesiana, dove il prevalere dell’impegno
giornalistico aveva condotto Saramago ad una prosa asciutta,
essenziale e descrittiva, nonostante fosse ammorbidita da quel
“realismo fantastico” in grado di dar vita e pensiero
persino agli oggetti. Si pensi – per esempio – ai
sei racconti della raccolta Objecto Quase (“Oggetti
o quasi”, 1978), in cui si può leggere lo splendido
Cadeira (“Sedia”) che descrive, anticipandola,
la caduta per consunzione del regime di Salazar, attraverso
la reale caduta del vecchio dittatore dalla sedia di mogano
che un provvido tarlo, in anni e anni di silenzioso lavoro,
aveva intaccato in una gamba fino all’ultimo morso capitolare.
È questo un linguaggio di fine intensità poetica
(espresso in un ermetismo depistante per sfuggire alla censura
del regime fascista prolungatosi per oltre quarant’anni)
nel quale l’autore riesce ad esprimere la propria critica
sociale, sebbene rimanga impigliato in una logica soggettiva,
in un corpo a corpo che Saramago ingaggia con la dittatura di
Salazar dalle pagine dei giornali in cui scrive e attraverso
le poesie e i racconti che pubblica. Il passaggio ad un linguaggio/azione
corale avverrà, appunto, con la stesura di un romanzo
proletario, Levantado do Chão, affresco collettivo
che racconta la dura e sofferta lotta dei contadini contro il
feudalesimo medievale dei grandi proprietari terrieri dell’Alentejo
– una delle regioni agricole più povere del Portogallo
–, in cui Saramago riuscirà, per la prima volta,
ad esprimersi nel suo inconfondibile stile autodiegetico.
Infatti Levantado do Chão, oltre ad essere il
romanzo della notorietà, è soprattutto l’opera
che afferma l’inconfondibile “stile orale”
del poeta lusitano, il cui carattere barocco è teso a
registrare l’atmosfera di un insieme di suoni variopinti
di chi ama raccontare, perdendosi nelle pieghe dei dettagli
per poi ritrovarsi ricostituito e compatto in un discorso narrativo
privo d’interruzione, poiché corale. La stessa
visione tipografica della pagina per la sua voluta mancanza
di interpunzione – che non siano le rispettose e umili
virgole e punti – rafforza, ingigantendola, la compattezza
della scrittura sino a farla uscire dalla materialità
bianca della pagina, dandole consistenza vocale.
La particolarità di questa scrittura orale, ricorda le
pagine celiniane (in particolar modo del Voyage au bout
de la nuit e di Mort à credit), dove l’aposiopesi
– la reticenza nel parlare tradotta su pagina grazie alla
sospensione dei puntini (…) – riesce a ricostruire
perfettamente i tempi propri di un discorso narrato, così
come l’incalzante repentinità delle virgole nel
testo saramaghiano, consente di non dar respiro ad una raccontare
frenetico ed emozionante. Con una profonda diversità,
però. In Celine la vocalità del discorso scritto
è soggettiva e in gran parte introspettiva; in Saramago
non solo è corale, ma addirittura polifonica, poiché
vi confluiscono tutti i suoni dell’atmosfera creatasi
da una determinata situazione, che esige, impone, una scrittura
orale perché pensata e costruita per essere letta, meglio:
raccontata. Infatti, è ascoltandola che la prosa di Saramago
crea quella coralità in grado di far sentire al lettore
il suono polifonico – ancor prima delle immagini –
delle parole dei protagonisti del racconto; parole
che si sovrappongono inseguendosi senza tregua, pur nel nitore
di ogni loro timbrica atmosfera.
Linguaggio scritto per l’orecchio e non solo per gli occhi,
la prosa dello scrittore lusitano doveva necessariamente oltrepassare
la bravura descrittiva della forma, per sentirne il suono al
suo interno; come se la capacità mostrata fin qui nell’osservare
la realtà sociale del suo Paese gli imponesse di scavare
in profondità sino a raggiungere l’essenza universale
di quella stessa realtà sociale, che – ovunque
e in ogni luogo – è sentita in quanto dolore sordo,
cupo, inquietante.
Era dunque giunto a maturazione il tempo perché Saramago
scrivesse un “saggio” sulla cecità. Un saggio
– come egli stesso dichiarò nella sua oratoria
di saggezza per il conferimento del Premio Nobel – “per
ricordare ai lettori che usiamo in modo perverso la ragione
quando umiliamo la vita, che la dignità dell’essere
umano è insultata tutti i giorni dai potenti del nostro
mondo, che la menzogna universale ha preso il posto delle verità
plurali, che l’uomo ha smesso di rispettarsi quando ha
perduto il rispetto che doveva al suo simile.”
 Entrare
nella pietra
Entrare
nella pietra
Ensaio sobre a Cegueira è il perfezionamento
dello stile corale della scrittura di Saramago, sviluppato e
proiettato all’interno dell’elemento descrittivo
della narrazione. Se finora l’autore con i suoi precedenti
romanzi – da “Memoriale del convento” (1982),
a “L’anno della morte di Ricardo Reis” (1984),
a “La zattera di pietra (1986), a “Storia dell’assedio
di Lisbona” (1989) – aveva saputo descrivere la
“statua”, ora sentiva il bisogno di far vivere la
“pietra”. Come se – racconterà il poeta
lusitano in occasione del conferimento della laurea honoris
causa attribuitagli dall’Università di Torino
nel 1987 – “mentre componevo tutti quei libri mi
fossi dedicato a descrivere una statua. Ora, che cos’è
una statua? È la superficie della pietra, il risultato
di quanto è stato tolto dalla pietra.”
La pietra – si sa – è ciò che rende
possibile la statua. È la sostanza che racchiude in sé
l’essere materia liberatasi nella forma. Descrivere la
forma (la statua) significa anzitutto conoscere la materia (la
pietra) che l’ha resa libera: ciò che è
la statua ancor prima di svelarsi ai nostri occhi. Ed è
questa la tesi espressa da Saramago con il romanzo “Cecità”,
quando, fin dall’incipit narrativo (la repentina ed inesplicabile
cecità che aveva contagiato un intero Paese), sottopone
il lettore all’inquietante considerazione secondo cui
“Il problema non sta nel fatto che tutti quanti diventino
ciechi, quanto nel fatto che già tutti lo siamo.”
L’azione del romanzo, a detta dell’autore, “si
svolge in una società o in un mondo o in una capitale
del mondo o dovunque vivano gli esseri umani. È un’epidemia
di cecità che copre e oscura tutti gli esseri umani”.
Non è dato capirne il perché, la causa; basti
riflettere sulle conseguenze per comprendere – ci suggerisce
Saramago – che la cecità senza i ciechi, è
una parola priva di senso: non esiste. L’importante è
scoprire che quella cosa che chiamiamo cecità, quella
cosa è dentro di noi… “è quella cosa
è ciò che siamo.”
Non a caso fin dalla descrizione che ne fa il “primo cieco”
colpito dall’epidemia ( e come lui “la moglie del
primo cieco”, “il medico”, “la ragazza
dagli occhiali scuri”, “il vecchio dalla benda nera”…
perché i ciechi “non hanno bisogno del nome”)
siamo informati che la cecità non è una luce che
si spegne, ma si accende. Una luce illuminante il baratro delle
nostre passioni costantemente contrite e trasformate dalla possibilità/impossibilità
di soddisfare i nostri bisogni, le nostre furie. Una luce bianca,
come un mare lattiginoso, allappante, che sommerge indistintamente
tutti, rendendoci simili gli uni agli altri: “Ciechi che
vedono, Ciechi che, pur vedendo, non vedono.”
Come tutte le tragedie, però, anche questa ha una sua
catarsi che anticipa la riacquistata e definitiva possibilità
di vedere, ritornando a vivere come un tempo, quando le immagini
del mondo costituivano l’unica possibile esperienza in
un mondo di sole immagini.
Anzi, sembra che la fine dell’incubo non sia tanto nel
progressivo, ineludibile ed altrettanto inspiegabile ritorno
al mondo delle immagini in seguito alla scomparsa della cecità
dagli occhi di tutti, quanto piuttosto nel misterioso e impenetrabile
prodigio che ha consentito ad una sola persona, la “moglie
del medico”, di salvarsi dall’epidemia: gli unici
occhi che non hanno mai smesso di vedere, quando tutti gli occhi
del mondo – perfino gli occhi di dio – erano diventati
ciechi.
Si sa, “in terra di ciechi l’orbo è re.”
Vedere ciò che nessun altro può, rende sicuri,
forti, potenti. Ma anche schiavi. Schiavi di chi non può
vedere… di chi ha bisogno degli occhi di un’altra
persona per vedere…di chi s’illude di vedere…
di chi si nasconde pur di non vedere…. Tutto ciò
diviene insopportabile, non per chi si adatta alla condizione
di cieco, ma per chi si ostina ancora a vedere, accorgendosi
che se non vi sarà nessuno che vorrà/potrà
vedere, a sua volta egli stesso diverrà cieco. A poco
a poco, com’è successo agli altri: “diverrò
sempre più cieca di giorno in giorno – farà
dire Saramago alla “moglie del medico” – perché
non avrò più nessuno che mi veda.”
Il dramma di chi è costretto a fingersi cieco pur continuando
a vedere – il dramma della “moglie del medico”
– è il dramma di chi ha fatto esperienza di che
cos’è la cecità del mondo: la perdita di
una ragione non più in grado di vedere, sentendola
come propria, la sofferenza, il dolore, l’umiliazione
che l’uomo infligge all’altro uomo.
Con crudeltà. Una cieca crudeltà per la conquista
del potere. Pure – è la fiduciosa speranza di Saramago
che, infine, affida al “saggio” sulla cecità
– l’umanità si salverà per salvare
chi l’ha aiutata a salvarsi: la “moglie del medico”,
che ha avuto il coraggio di vedere quando tutti erano ciechi,
fingendosi cieca. Per amore del suo uomo. Per amore degli uomini.
Che siano quello che siano.

Serata
di lettura e audizione del romanzo Cecità di
José Saramago, svoltosi lo scorso 14 gennaio al Liceo
Classico di Ischia
 Dalla
cecità alla lucidità dell’umanità
Dalla
cecità alla lucidità dell’umanità
Proprio questa umanità che si è salvata dalla
cecità, è protagonista dell’ultimo romanzo
di Saramago: Ensaio sobre a Lucidez (“Saggio
sulla lucidità”). Con un’unica differenza:
è un’umanità maggioritaria, non più
generale. Infatti, se la “cecità” è
una condizione che riguarda tutti, perché colpisce tutti,
la “lucidità” interessa i più e conduce
alla preoccupazione, all’inquietudine, i pochi. Quei pochi
– la maggioranza di una minoranza – ancora impegnati
nell’esercizio del potere: far credere di essere necessari
per l’ordine, la sicurezza, la tranquillità, della
società umana.
L’andamento musicale – i tempi, i ritmi diegetici
– di quest’ultimo romanzo saramaghiano sono speculari
al precedente saggio. Analizzando, ad esempio l’incipit,
si può osservare quanto l’azione coinvolga non
più una sola persona (“il primo cieco”) per
poi estendersi alla totalità, bensì la maggioranza
dei cittadini che – chiamati al voto – pongono nell’urna
elettorale la scheda bianca, invece di esprimersi a favore di
uno dei partiti in lizza per le elezioni politiche, al punto
da inquietare il Governo democratico e indirizzarlo alla ricerca
del capro espiatorio di una simile e inspiegabile “cecità”.
Di più: se in Ensaio sobre a Cegueira l’epidemia
– a seguito del suo progredire esponenziale, prima, e
del suo regredire definitivo, poi – segnerà uno
sprofondare nell’abisso dei comportamenti umani da cui
infine riemergere ancora una volta colmi di speranza, in Ensaio
sobre a Lucidez la speranza che qualcosa di nuovo sia accaduto,
al punto che nulla potrà esser più come prima,
accompagna fin dall’inizio il raccontarsi dell’evento
– assumendo marcati e travolgenti effetti comici, (riassumibili,
qui e per brevità, nell’aggettivo “biancoso”
con il quale il governo appella chi si è permesso di
votare scheda bianca in quantità “così eccessiva”
da diventare sovversivo) – ma finirà per spegnersi
drammaticamente quando la necessità di individuare il
responsabile di un simile atto sovversivo che ha saputo organizzare
la maggioranza dei cittadini nel non fare un “uso prudente”
del voto, travolge ogni logica e inonda mortalmente l’intera
umanità, colpendo la “moglie del medico”,
l’unica a vederci allora, al tempo dell’epidemia
di cecità bianca che coinvolse l’intera popolazione
e, pertanto, tutt’ora l’unica rea dell’attuale
cecità che ha condotto la maggioranza a votare scheda
bianca.
Nel ricollegare questo nuovo “saggio” con il precedente,
è stata preoccupazione di Saramago sondare in profondità
i meccanismi di riproduzione dell’esercizio del potere,
cogliendo diversità e differenze fra il potere dei “ciechi
malvagi”, affermatosi mediante l’utilizzo della
forza della violenza, e il potere del “governo democratico”
che, del tutto sorpreso a seguito dell’uso inappropriato
del voto da parte dei cittadini della capitale, riafferma il
proprio controllo attraverso la pratica violenta della propria
forza.
Se, infatti, sono i bastoni, ma soprattutto la pistola in mano
al capo dei “ciechi malvagi” ad acclarare il potere
di vita e di morte sulla comunità reclusa nell’ex
manicomio durante il diffondersi – quattro anni prima
– dell’epidemia bianca, ciò che ora assicura
al “governo democratico” il controllo sulla cittadina
posta in stato d’assedio è l’uso violento
della forza messo in atto attraverso l’infiltrazione,
la manipolazione, la repressione, per convincere i suoi cittadini
di esser stati nuovamente contaminati dalla cecità.
Non per nulla – crediamo – le pagine dei due saggi
saramaghiani su questo tema si cercano reciprocamente, sviluppandosi
in maniera antitetica, grazie a un serrato contrappunto armonico
di fine espressività poetica, tale da dettare una sequenza
temporale dal “serio”, al “grave”, al
“sereno” per quanto concerne Ensaio sobre a
Cegueira, mentre per Ensaio sobre a Lucidez dallo
“scherzo”, al “sereno”, al “tragico”.
Così, se il percorso narrativo di “Cecità”
giunge agli estremi con una descrizione orrida e orripilante
della presa del potere da parte dei “ciechi malvagi”
che dominano la situazione a suon di minacce, soprusi, violenze,
fino al punto in cui la “moglie del medico” saprà
fare giustizia, l’ultimo romanzo di Saramago percorre
stanze narrative in cui da situazioni burlesche – che
descrivono la difficoltà del “governo democratico”
nel riorganizzarsi per riprendere il controllo di una realtà
sociale ormai autonoma e in grado di autogestirsi – si
perviene a situazioni tragiche dove la necessità di porre
ordine ad uno stato di tranquilla armonia presente all’interno
della cittadina “ribelle”, condurrà il “governo
democratico” ad organizzare il disordine mediante un attentato
terroristico pur di riaffermare il bisogno del proprio ordine.
Ed è proprio la dicotomia fra la tranquilla quotidianità
di una cittadinanza che semplicemente ha detto “no”
a chi esercita il potere – proseguendo imperturbabilmente
il proprio tran-tran giornaliero, sebbene lo stato d’assedio
prima, l’atto terroristico poi, l’aggressione psicologica
dei media sempre, cerchino in tutti i modi e con tutti i mezzi
di inquietarla ed impaurirla – e la spasmodica preoccupazione
di un governo, seppur democratico, di impedire il diffondersi
della possibilità di esautorare (utilizzando i medesimi
meccanismi elettorali) il sistema rappresentativo dei partiti,
a tessere la narrazione della storia di un substrato analitico
in grado di chiarire i molti lati oscuri, ciechi, del potere.
Lati oscuri, ciechi, che soltanto la lucidità squarcia
dall’interno per far emergere quanto non possano esistere
“poteri buoni”.
Per questo Ensaio sobre a Lucidez – come si cerca
e si vuole far credere da parte di una critica disorientata
e da un’editoria allarmata – non è “un
avvincente ‘giallo politico’ in cui ritornano gli
indimenticabili protagonisti di ‘Cecità’”.
È molto di più.
È un saggio critico sul potere democratico attraverso
l’analisi dei meccanismi che inducono all’obbedienza
e alla rassegnazione partecipative. È un’accusa
– tradotta all’istante in dura condanna –
nei confronti della democrazia in quanto potere proiettato ad
autolegittimarsi come unica, sola, organizzazione sociale che
non accetta nessuna critica, sia pure quella democratica.
Perché – e José Saramago non può
essere più esplicito, quando per bocca del “commissario”
accusa la “moglie del medico” di aver tramato contro
la democrazia, votando e facendo votare scheda bianca –
“chiunque deve capire che si tratta di una semplice questione
di gerarchia di valori e di senso comune, in primo luogo ci
sono i voti espliciti, poi vengono le schede bianche, poi le
nulle, infine le astensioni, […] la democrazia si troverebbe
in pericolo se una di queste categorie secondarie passasse in
testa alla principale, se i voti ci sono è perché
se ne faccia un uso prudente.”
 …altrimenti
ci arrabbiamo!
…altrimenti
ci arrabbiamo!
Ora si può comprendere il crimine di cui è
accusato Saramago, quello che l’ha spinto – come
tutti i criminali – a ritornare sulla scena del
delitto: non esser diventato cieco in un mondo dove tutti lo
sono. Di più: aver svelato le cause della cecità
nella rappresentazione di un potere rappresentativo –
la democrazia – che obnubila la ragione e la prostra dinnanzi
ad un’autorità totalmente priva di autorevolezza,
poiché cooptata all’interno di una maggioranza
composta dalla minoranza degli eletti, preoccupati di autolegittimarsi
unici rappresentanti del potere democratico, senza alcun’altra
qualità se non quella di rigenerarsi continuamente attraverso
il suffragio elettorale.
Infatti, poco importa il risultato delle elezioni, ciò
che conta è votare chi bisogna votare. Ma soprattutto
evitare un uso abusivo – seppur legale – del voto.
Altrimenti… altrimenti ci arrabbiamo!
Tuttavia non è facile liquidare il caso Saramago, limitandosi
ad asserire quanto egli sia sempre stato – nella sua vita
quanto nel suo lavoro – privo di politically-correct,
al punto da essere sospettato un sovversivo, un terrorista,
ponendo così fine a qualsiasi discussione. Perché
trovare un nome a ciò che ci inquieta non serve
a calmarci, come se chiamare morte la morte fosse sufficiente
per non temerla più.
E poi, Saramago stesso, in più interviste, ha finito
per rivelare il suo sentirsi comunista causato da un fattore
ormonale: “Oltre all’ipofisi, io ho nel cervello
una ghiandola che secerne ragioni affinché io sia stato
e continui a essere comunista. Quelle ragioni le ho trovate,
un giorno, condensate in un motto de “La Sacra Famiglia”
di Marx e Engels: “Se l’uomo è formato dalle
circostanze, bisogna formare le circostanze umanamente. Le circostanze
non le ha formate umanamente il socialismo pervertito, e tanto
meno le formerà mai il capitalismo, che è pervertito
per definizione. Dunque, il mio cervello continua a secernere
ormoni ...”.
Certo, grazie alla mappatura del genoma, si potrebbe intervenire
con terapia genica, anche se – come sosterrebbe Lewontine
– risulta difficile in campo biotecnologico individuare
il gene portatore di una simile devianza, pena dover classificare
l’intera specie umana…come dire… di natura
comunista. E allora? Allora, forse, non rimane che osservare
quanto Saramago nel suo ultimo “saggio” ha voluto
porre in chiara evidenza: se la cecità può
colpire tutti – in quanto ciechi “già tutti
lo siamo” – allo stesso modo la lucidità
può colpire i più. Perfino i più insospettabili.
Addirittura il “ministro della giustizia” –
come apprendiamo, sorpresi, in Ensaio sobre a Lucidez
–, che, in pieno consiglio del governo, pose in dubbio
se aver votato scheda bianca da parte della maggioranza dei
cittadini, fosse una manifestazione di cecità o di lucidità.
“Come osa, pronunciare una simile barbarità antidemocratica,
dovrebbe vergognarsi, non sembra neanche un ministro della giustizia,
sbottò quello della difesa, Mi domando se sono mai stato
tanto ministro della giustizia o di giustizia, come in questo
momento, Ancora qualcosina e mi farà credere che ha votato
scheda bianca, osservò il ministro dell’interno
ironicamente, No, non ho votato scheda bianca, ma ci penserò
alla prossima occasione.”
Inquietante? No, saramaghiano.  Gianfranco Marelli
Gianfranco Marelli
|

