|  Ricordando Giovanni Raboni
Ricordando Giovanni Raboni
Cara redazione,
forse non ci crederete (e anch’io mi sono sorpreso nel
pensarlo), ma proprio ieri nella mia quotidiana ricerca poetica,
avevo nuovamente letto alcune poesie di quegli autori che la
critica italiana ha sentenziato essere i “poeti della
vita quotidiana”. Fra questi – oltre a Majorino,
Neri, Cesarano, Rossi – Giovanni Raboni.
Lo conobbi personalmente quattro anni fa, in un bar sotto casa
sua, in occasione di un lungo colloquio su Giorgio Cesarano,
il poeta-rivoluzionario per cui allora stavo preparando l’introduzione
alla riedizione del libro “Manuale di sopravvivenza”,
richiestomi dalla Bollati Boringhieri. Fu il primo – e
l’unico – incontro che avemmo (anche se ci promettemmo
di reincontrarci, per il fatto che Raboni rimase sorpreso dal
fatto che non gli avessi minimamente proposto – ogni volta
che avevo occasione di telefonargli – di prestare attenzione
alle mie poesie), tuttavia ricordo la profonda curiosità
e rispetto nei confronti del pensiero libertario e anarchico,
che lui ben conosceva, e che per l’occasione ebbi modo
di parlarne, facendogli conoscere la rivista “ApARTe°”
(allora appena edita) ed il libro di Catanuto e Schirone su
“Canti anarchici”.
Giovanni
Raboni
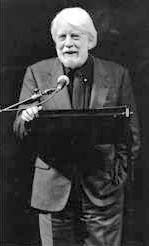
Naturalmente il nostro unico incontro era finalizzato a comprendere
come Cesarano si era progressivamente staccato dalla produzione
poetica, abbracciando la critica radicale, e quali erano stati
i loro rapporti amicali e professionali, dal momento che Raboni
aveva in più occasioni collaborato assieme a Cesarano
scrivendo sceneggiati per la RAI (un inciso: la “Freccia
nera”, lo sceneggiato che tanto scandalizzò il
Vaticano per il costume discinto della Goggi, vide all’opera
lo stesso Cesarano che nel ritradurre dall’inglese il
racconto, lo migliorò in alcune sue parti, finendo per
comporne l’omonima canzone).
Da sempre amici, Raboni e Cesarano, condividevano in più
la passione sfrenata per il calcio; il primo interista, mentre
l’altro milanista, puntualmente ad ogni derby con i rispettivi
figli andavano a San Siro e lì nasceva una lunga tenzone
che proseguiva con interminabili sfottò. Ma era la poesia
il campo in cui si ritrovavano per riflettere sull’evolversi
di una situazione sociale che dopo il ’68 li aveva visti
prendere posizioni differenti. Con Majorino avevano dato vita
alla rubrica “Questioni di poesia” sulla rivista
“Paragone”, e da allora la loro produzione poetica
era diventata uno strumento per scandagliare la quotidianità.
Poi, la rottura di Cesarano con l’establishment intellettuale
milanese, uscendo dalla Rizzoli e da tutte le parallele attività.
Con Raboni i contatti continuarono; anzi, Raboni stesso affittò
un casale toscano proprio vicino a quello che Cesarano aveva
acquistato a Pieve di Compito. Entrambi proseguirono, però,
per la propria strada, anche se nell’ultimo periodo (poco
giorni prima del suicidio) Cesarano aveva ripreso con la poesia.
Non per nulla la sua opera poetica fu pubblicata postuma da
Raboni per conto dei “Quaderni della Fenice” dell’editrice
Guanda.
Di Giovanni Raboni serberò sempre una sua osservazione,
che contribuì a cambiare il mio approccio con la produzione
poetica, nel voler richiedere alla poesia una “riconoscibilità
formale” per ricominciare ad esistere, oltre che nelle
menti e nella volontà dei poeti, anche “nella mente
e nell’orecchio dei lettori”.
Vi chiedo scusa, per questa lunga “spataffiata”,
ma volevo comunicarvi la mia tristezza per la morte di un poeta.
Un abbraccio,
 Gianfranco
“Joe” Marelli Gianfranco
“Joe” Marelli
 La tristissima storia della timbratrice
La tristissima storia della timbratrice
Chi ama le poesiole per l’infanzia d’altri tempi
senz’altro conosce una raccolta di versi intitolata “Pierino
Porcospino”. Narra la storia di un bambino, Pierino porcospino
appunto, che compare nell’esordio – oh che schifo
quel bambino, Pierino il porcospino – e che poi nel prosieguo
viene sostituito da numerosi alter ego, accomunati da una vocazione
all’indisciplina e da una irresistibile attrazione verso
la trasgressione delle regole, cosa che li porta, nel breve
volger di qualche strofa, a fare una brutta fine. Così
Corrado che si succhia il pollice viene punito da un sarto mostruoso
che, comparso all’improvviso, gli trancia via di netto
i pollici criminali con il forbicione e il cattivo Federigo,
tormentatore di bestie e nutrice, si becca un gran castigo.
Ma la sorte peggiore tocca all’incauta Paolinetta che,
lasciata in casa da sola, non sta buonina, come le ha raccomandato
la mamma: si mette a giocare con gli zolfanelli, da vera sventata
qual è. Finisce così: un po’ di cenere e
due scarpini/caro ricordo dei suoi piedini/è quel che
resta/non c’è più nulla/di quell’indocile,
vispa, fanciulla.
Non è poco, come punizione. Insomma “Pierino porcospino”
è una sorta di teatro della crudeltà per bimbetti,
frutto di una pedagogia d’altri tempi, che non temeva
di agitare orrendi babau di fronte agli occhi sgranati dei pargoli
da educare. Tant’è che una volta, volendone io
acquistare una copia in una libreria per ragazzi della mia città
mi sentii rispondere con sdegno che loro, quella cosa lì
non la tenevano. Rinunciai a spiegare alla commessa che le povere
rimette non erano poi tanto pericolose e pensai che a lei era
precluso uno dei molti piaceri che questa valle di lacrime ci
offre – e cioè sentir recitare da Paolo Poli “La
tristissima storia degli zolfanelli”. Non è che
tutto questo abbia molto a che fare con la timbratrice che rileva
le presenze dei ragazzi a scuola, dirà chi legge. E invece
sì, perché anche la timbratrice è un mostro
come le forbici del sartore che punisce esemplarmente il povero
Corrado. Ed è un mostro ugualmente il “patto formativo”
che dovrebbe regolare i rapporti tra studenti e insegnanti;
sono mostruosi il POF e il formalismo burocratico, è
mostruoso il “progetto qualità” e il tentativo
di trasformare la scuola in una azienda che piazza il suo prodotto
sul mercato.
Ma ogni ragazzino, per quanto impressionabile, sarà anche
pronto a ridere del sartore, e capirà che la punizione
per chi si succhia i pollici non può essere proprio quella,
così esagerata.
Mentre lo studente che si accinge ad entrare in classe per verificare
se il primo ad infrangere il patto formativo sarà lui
stesso o il suo insegnante, di fronte alla timbratrice rimarrà
impassibile e serio, perché così deve essere nella
scuola dell’autonomia, che è una scuola seria in
cui nessuno ride perché non c’è niente da
ridere. O forse quello studente cederà alla tentazione
ed invece di far passare il codice a barre del suo libretto
delle assenze proporrà al lettore ottico il codice a
barre del detersivo – tanto per sabotare con un’umana
monelleria la scuola-azienda e l’istruzione-merce. E magari
per farsi due risate con il compagno di banco – che quello
ancora non è stato monitorato, non è stato abolito
dalla riforma Moratti e si chiama ancora così, compagno
di banco.
 Giovanna Lo Presti
Giovanna Lo Presti
delegata RSU CUB Scuola Itis Peano Torino
 L’ironia di Luigi
L’ironia di Luigi
Poco dopo il ’68 e prima dell’epoca degli anni di
piombo, ci fu un periodo nel quale il movimento anarchico, colpito
dalla repressione nel ’69, oltre a fare la campagna per
la verità contro la mistificazione ed i complotti, sviluppava
un intenso dibattito interno proiettato verso un rinnovamento
culturale e organizzativo.
L’obiettivo era la ripresa del suo posto nella società,
dal quale era stato estromesso dal fascismo. Insieme quindi
l’impegno antistragista e contro la repressione, l’entusiasmo
e l’energia della militanza volta a creare un mondo migliore.
Furono anche rivolti a temi specifici.
A Roma il punto di aggregazione era in quell’epoca la
redazione di “Umanità Nova”, in via dei Taurini:
un piccolo appartamento nello stabile in cui venivano stampati
“Paese Sera” e “l’Unità”.
Per la sede del mitico giornale fondato da Malatesta passavano
torrenti di compagni e compagne e vi era un continuo ricircolo
di idee e di discussioni, nonché di tentativi di analisi
volti al superamento della fase involutiva che era iniziata
con la strage del ’69.
Una sera tra il ’71 ed il ’72 il compagno Luigi
Carlizza venne ad una seduta della redazione collegiale. Saputo
che egli era il medico/compagno con il quale volevo iniziare
un discorso per affrontare in modo anarchico la medicina, gli
chiesi di partecipare al gruppo che si impegnava all’Acquedotto
Felice e di installare un ambulatorio medico. Noi eravamo un
piccolo gruppo di studenti anarchici di Medicina, in progressiva
espulsione da parte del collettivo di Medicina del Manifesto.
Con i suoi occhi pieni di bonomia e di serietà Carlizza
ci parlò con scetticismo, sostenendo che non era quello
il modo di militare, che invece avremmo dovuto trasformare la
Medicina dall’interno, relazionandoci alla riforma sanitaria
per la quale i lavoratori più avvertiti si battevano
da tempo in una ottica di larghe masse. Naturalmente le parole
non furono queste, ma sicuramente il concetto.
Esauritasi la fase del collettivo il Manifesto, nel quale non
c’era ovviamente posto per gli anarchici e terminata la
fase del volontarismo presso l’Acquedotto Felice (che
non è da sottovalutare perché rappresentò
un embrione di intervento popolare), iniziò un dialogo
con Luigi per “rivitalizzare” (così ci si
esprimeva allora) l’anarchismo attraverso lo studio del
sistema sanitario , la pubblicazione di articoli sul tema e
la formulazione di proposte da portare nei gruppi della FAI
per l’azione militante.
Tra chi si batteva da anni per la riforma sanitaria e per il
superamento del sistema mutualistico e chi invece voleva far
incidere le sue idee anche nella futura professione, si sviluppò
un impegnativo dibattito i cui risultati apparenti furono davvero
pochini, se si fa riferimento a qualche articolo comparso su
“Umanità Nova” e su altra stampa, ma la cui
sostanza fu davvero fondamentale.
Forse neppure se ne rendeva conto, tanto era il suo rigore,
che si faceva scudo di una certa ritrosia di carattere e che
lo faceva ripetere di scrivere chiaro, semplice come Malatesta
aveva scritto Al Caffè. Obiettivo abbastanza difficile
sia per la assoluta sproporzione tra il Maestro e noi giovani
militanti sia perché allora imperava il sinistrese, dal
quale tutti (chi più chi meno) eravamo affetti. Ne conseguivano
stroncature terrificanti agli articoli che gli proponevo e continue
riscritture e rielaborazione dei concetti per raggiungere quella
massima chiarezza e limpidezza che era il suo ideale di pubblicistica
anarchica.
Ma insieme alle discussioni sui temi sanitari si parlava del
gradualismo malatestiano, quale originale tentativo di “tenere
assieme” la tensione rivoluzionaria con una pratica non
ingessata dall’ideologia; del Congresso di Carrara del
1965, che aveva portato alla scissione dalla Federazione Anarchica
Italiana (FAI) dei Gruppi d’Iniziativa Anarchica (GIA)
che ne contestavano le scelte organizzative); dell’esperienza
“neomarxista” dei Gruppi Anarchici d’Azione
Proletaria (GAAP) alla quale aveva partecipato quasi una ventina
di anni prima.
Mi ricordo che Luigi mi regalò l’opuscolo degli
atti del Congresso di Pontedecimo. quello che nel 1951 aveva
segnato il passaggio dai Gruppi Anarchici di Azione Proletaria
al leninismo di Lotta Comunista).
Sull’opera costruttiva della Rivoluzione Spagnola era
uscito in quei tempi il libro di Gaston Leval, che trattava
anche delle straordinarie esperienze degli anarcosindacalisti
spagnoli nel campo della sanità. Io ne fui entusiasta,
Luigi meno, perché probabilmente le riteneva improponibili
in Italia in quell’epoca storica. Io e la mia compagna
abbiamo avuto l’inestimabile esperienza di percepire dall’interno
l’esperienza ed il vissuto di tanti anni di anarchismo
dal secondo dopoguerra in avanti.
Una sola volta lo vidi veramente abbattuto e profondamente arrabbiato
e fu quando ci giunse la notizia che il nostro compagno Franco
Serantini era stato barbaramente ucciso, a Pisa. Era l’inizio
di maggio del 1972. Sapeva tuttavia nascondere la sofferenza
ed il dolore e, a parte quella sera terribile e tenebrosa, non
ne parlò più.
Luigi non credeva che il fascismo fosse il principale problema,
temeva molto di più l’avvento ed il consolidamento
della tecnoburocrazia rossa. Perciò stimava molto i compagni
di Milano raccolti intorno ad “A” (e successivamente
anche al Centro studi libertari “Pinelli”) che per
primi avevano iniziato ad affrontare lo studio di questa nuova
classe a partire dalle geniali diagnosi e profezie bakuniniane.
Luigi mi prestava da leggere il Bipartitismo imperfetto
di Giorgio Galli, un libro sul socialismo libertario di Andrea
Caffi edito da Azione Comune, testi sulla riforma sanitaria
e sulla mortalità infantile. A testimonianza di quanto
fosse vasto e innovatore il suo pensiero.
Fui accolto con cordialità e con affetto nella sua famiglia
e vidi crescere i suoi figli in quel profondo calore che si
irradiava da una vita malatestianamente vissuta, un valore che
si è sedimentato negli anni e che ha dato i suoi frutti
di resistenza quando il declino sociale degli anni ’80
sembrava negare qualsiasi possibilità di rinascita dell’anarchismo
sociale.
Un calore umano ed una profonda umanità la sua, una spontaneità
vivacissima dei suoi figli, una cordialità profonda dei
suoi famigliari, che nel ricordo assumono i caratteri mitici
di un’epoca nella quale stava rinascendo l’anarchismo
politico ed umano come testimonianza di vita.
Oggi che l’anarchismo ha conquistato nella società
riconoscimento culturale e politico, che viene considerato come
uno dei tanti filoni del movimento operaio e popolare del 900,
che non lascia indifferenti e che non suscita più diffidenza
o superficiale antipatia, è difficile ritornare con la
mente a quei tempi e capire come allora l’anarchismo non
disponesse che di pochi militanti seri e consapevoli che avevano
ben chiare le differenze ontologiche con il marxismo, come non
attraesse gli intellettuali, come in una parola si fosse suo
malgrado allontanato dalla società.
Forse per questo Luigi ci teneva a dire che ci si batteva per
la rivoluzione sociale attraverso il gradualismo, che per lui
implicava la partecipazione alla nascita ed allo sviluppo della
riforma sanitaria.
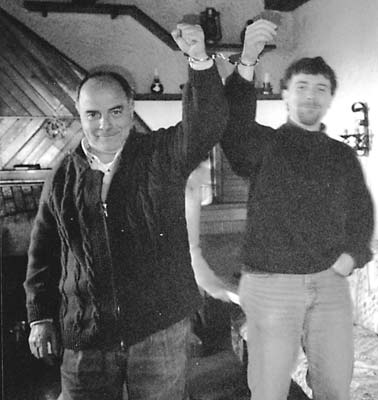
Luigi
Carlizza, “ammanettato” al figlio Francesco “Fricche”
Per quanto riguarda il dibattito teorico all’interno
del movimento anarchico, Luigi – che aveva vissuto in
prima persona e con passione l’esperienza “marxista”
e ultra-organizzatrice dei GAAP vent’anni prima –
era fortemente polemico con l’archinovismo e
il piattaformismo, cioè con quella tendenza
verso un movimento tendenzialmente omogeneo e rigidamente strutturato.
Proprio in quegli anni Luigi tornò alla militanza attiva,
attraverso la creazione e lo sviluppo con altri compagni (alcuni
della sua età) del gruppo Roma Centro, attraverso la
comunanza ideale con alcuni suoi compagni di gioventù
(come Pier Carlo Masini).
Alcune sere d’estate, quando la canicola scemava temporaneamente,
ci vedevamo talvolta con Luigi e con Ugo Scattoni, il fratello
di Umberto Scattoni (compagno di Bandiera Rossa trucidato alle
Fosse Ardeatine); discutevamo con molta partecipazione emotiva
e con impegno della Spagna, del sindacalismo, del movimento
anarchico del dopoguerra, dell’esperienza neomarxista
dei GAAP cui avevano dato origine Luigi, Ugo Scattoni, Pier
Carlo Masini ed altri ancora.
Furono anni di intensi confronti tra la sua critica radicale
al piattaformismo e la mia maggiore attenzione nel
cogliere le ragioni di fondo del piattaformismo, quale
risposta al fallimento dell’anarchismo in Russia, pur
senza aderirvi. Convenimmo che il Programma dell’Unione
Anarchica Italiana scritto da Malatesta nel 1920 fosse
il migliore e che dovesse essere calato nella concretezza della
realtà, che certo non presentava il momento rivoluzionario
nel cui contesto quel Programma era nato.
Questo impegno noi lo cercammo, come dicevo, anche nella ricerca
della definizione di un’organizzazione sanitaria popolare,
da dibattere all’interno del movimento e da portare avanti
come tesi e proposte operative nei gruppi. Frequentavo almeno
una volta alla settimana la sua famiglia e ho visto crescere
i suoi figli. Ricordo che durante il movimento del ’77
raccomandai ad uno di loro di stare attento ai pericoli insiti
in un impegno personale troppo intenso: temevo per la sua stessa
vita.
Questo impegno Luigi lo cercò nel gruppo Roma Centro
ed a quell’epoca, negli anni ’80, il nostro sodalizio
politico, salvo che per qualche incontro, si interruppe, mentre
non si interruppe il senso della nostra profonda amicizia. La
ricerca del lavoro e il lavoro in quanto tale mi presero molto
e quando mi giunse la notizia della sua morte provai un grande
dolore: dolore che in parte fu attenuato successivamente dalla
lettura degli articoli su “Umanità Nova”
di suo figlio Francesco (noto come “Fricche”), nei
quali ho ritrovato l’ironia di Luigi. È comparso
anche un bellissimo articolo su Luigi nel volume che venne pubblicato
a Carrara in occasione del monumento a Bresci e riscontrai con
piacere che a Luigi venivano attribuite quelle qualità
che io avevo rilevato.
 Enrico Calandri
Enrico Calandri
|

