|
 La provocazione permanente di
Serge Gainsbourg
La provocazione permanente di
Serge Gainsbourg
Prima parte – La tela di Penelope (1958-1978)
Serge Gainsbourg fu forse il più grande provocatore della
canzone francese, uno spirito critico finissimo, un talento
melodico eccezionale, un versificatore di grande preziosismo.
Affrontiamo però con lui, per la prima volta in questi
nostri ritrattini, un personaggio assolutamente indifferente,
anche se certo non ostile, alle rivendicazioni sociali che ci
sono care.
Le parole sono usurate
Ci si vede attraverso
E l’ombra degli anni morti
Ghermisce il vocabolario
Portami per mano fuori dai luoghi comuni
E allontanami dall’idea
Che non puoi esprimerti
Che per clichés. (Le parole inutili, 1955)
Gainsbourg fu un convincente dandy del secondo novecento
e la sua provocazione si situa tutta nella forma e non certo
nei contenuti. Un esteta stravolto e terribilmente critico,
un seminatore di equivoci demistificanti, forse l’unico
geniale teologo e officiante di una pop-art musicale, che è
– di suo – una critica alla caducità dei
linguaggi, alle mode effimere che passano per l’etere
radiofonico, al vuoto di sostanza che tutto inghiotte in questo
breve spazio, impastato di moltissimo fumo e pochissimo arrosto,
che noi attraversiamo con la burbanza dei conquistatori del
tempo e del mondo. Attenzione però: se si parla di spirito
critico in Gainsbourg non è certo per sottolineare la
presunzione di un “qualcosa di meglio” da cercare,
in cui certamente lui non confidava sotto nessun punto di vista.
Con i mezzi che ebbe a disposizione, coi talenti che possedeva
copiosi, fece e disfece costantemente la tela di Penolepe su
cui i suoi contemporanei si affannavano a proiettare rutilanti
scene di varietà, proprio perché, alla fine, tutta
l’angoscia non solo evocata, ma proprio costantemente
esplorata, tutto travolgesse, sé per primo.
Le mie illusioni affacciano sul cortile
Ho messo una croce sui miei amori
E quand’ho finito le mie otto ore
Non mi restano per sognare
Che i fiori orribili della carta da parati. (L’alcol,
1958)
Serge
Gainsbourg 
Lucien, detto Serge, Ginzburg nacque da genitori
ebrei russi fuggiti dalla rivoluzione, il padre era un pianista
di formazione classica, costretto, nelle ristrettezze dell’emigrazione,
a doversi riconvertire in fantasista della tastiera, ne serbò
per sempre una frustrazione alla quale reagì educando
solidamente i figli alla grande scuola del virtuosismo rachmaninoviano.
Serge però all’inizio pareva più interessato
alla pittura che alla musica, e fu solo per sbarcare il lunario
che cominciò a fare il pianista nei night. La vita prende
volentieri strade proprie e così sempre più egli
accantonò il sognato destino di pittore per avvicinarsi
a quello di cantautore.
Vedo i miei occhi riflessi nei tuoi occhi, che fortuna
per te!
Ti danno dei bagliori di intelligenza
Che importa il tempo
Che porta via il vento
Meglio la tua assenza
Della tua incoerenza. (Indifferente, 1959)
“Su, lettori all’ascolto, sempre pronti ad abbaiare
contro, contro le false canzoni e i falsi della canzone, tirate
fuori due sacchi dalle tasche e correte a compararvi questo
disco (…). È il primo 33 giri di uno strano individuo
che si chiama Gainsbourg Serge ed è nato a Parigi il
2 aprile 1928.” così comincia il grande attestato
di stima che il nostro ricevette all’uscita del suo primo
disco nel 1958, e lo firmava nientepopodimeno che Boris Vian!
Il nostro caro disertore, proprio sul finire della
sua breve vita, prese infatti una cotta tremenda per
quest’esordiente impeccabilmente jazzoso e dalle
rime raffinatissime, che popolava il suo mondo di controllori
del metrò che sognavano il suicidio per evadere dal proprio
“cielo di piastrelle/dove non vedo brillare che le corrispondenze”,
da “ragazza di strada” che “masticano il chewing
gum durante l’amore”, e da canzoni d’amore
singolari come quella che esordisce “questa noia mortale/che
mi prende quando sono con te” e che prosegue “certo
non c’è bisogno di dire niente in orizzontale/ma
non si trova niente da dirsi in verticale/allora per ammazzare
il tempo/fra l’amore e l’amore/prendo il giornale
e la penna/e riempio le A e le O”.
Se consideriamo che a casa nostra proprio quell’anno
cominciava la rivoluzione di Modugno col suo Volare,
ci rendiamo conto di quale diverso livello di modernità
e audacia potesse rappresentare l’elaborazione di tale
linguaggio e temi.
Meglio non pensare a niente
Che non pensare affatto
Niente è già
Niente è già parecchio
Ci si ricorda di niente
E dal momento che si dimentica tutto
Niente è molto meglio che tutto. (I piccoli niente,
1964)
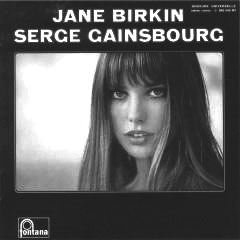
Sin da questi primi colpi che mette a segno Gainsbourg non
si abbandona a nessuna retorica, nemmeno a quella dei perdenti,
non vi è nessuna vena protestataria: la sua sconfitta
si situa a priori: essere è un male per cui la redenzione
non è contemplata in alcuna maniera.
L’erotomania da cui l’autore è perennemente
squassato non è nemmeno lei il barlume di una presunta
forza vitale residua, ma un ballo di San Vito, un’agitazione
senza scopo, che non dà alcuna possibilità
di affermazione esistenziale “l’amour physique est
sans issue” (“l’amore fisico è senza
speranza”) dirà dieci anni dopo nel suo pezzo più
conosciuto in Italia, quel Je t’aime, moi non plus
(1968) che vendette molti milioni di copie anche nel nostro
Paese, e che, assurdamente considerato un pezzo eccitante, è
in realtà un inno alla ripetitiva vacuità dell’atto
sessuale.
Una notte che ero
Ad annoiarmi
In qualche pub inglese
Del cuore di Londra
Scorrendo “l’amore mostro”
Di Pauwels
Ebbi una visione
Nell’acqua di selz. (Initials B.B., 1968)
Gli anni intanto passavano, gli attributi di stima crescevano,
ma le vendite dei suoi dischi rimanevano risibili, giusto qualche
successo glielo concedevano interpreti quali ad esempio Juliette
Greco con Accordéon.
Fu a metà dei sessanta che Serge ebbe l’intuizione
di cominciare a scrivere per i cantanti ye-ye, proprio quelli
che stavano decretando la crisi della grande stagione della
canzone poetica in Francia, lui, fedele alla consegna di distruggere
con eleganza, cominciò una carriera di autore di successi
per l’estate di cui fino alla morte sarebbe stato
il più generoso dispensatore. “Queste canzonette
mistificatrici sono bombe a scoppio ritardato, e il pubblico,
prendendoci finalmente gusto, permette al loro autore di continuare
a distillare il suo veleno. (…) Il suo tentativo è
mistificatorio e demistificante al contempo, tanto più
originale perché si situa al livello della materia prima:
la canzone stessa e non quel che dice. Egli spezza le strutture
linguistiche, le ristruttura, fa breccia nei muri che separano
i generi musicali (…) usa le parole per strappar loro
la maschera… Il suo messaggio è un anti-messaggio,
l’amore è sempre e solo erotismo. Dietro la maschera,
il vuoto. Così la sensibilità dell’autore
ai feticci delle mode è al contempo causa e effetto dell’efficacia
delle sue opere. Anglismi, misoginia e culto della donna-oggetto,
jazz e ritmi alla moda lo trasportano. Solo il suo rapporto
fondamentalmente sensuale con la lingua lo mantiene in uno status
di vitalità, per il resto non si può sperare in
alcuna sintesi” (così il grande studioso di canzone
J. C. Calvet).
Il sole è raro
E la felicità pure
L’amore si perde
Lontano dalla vita. (Valse de Melody, 1971)
Serge
Gainsbourg 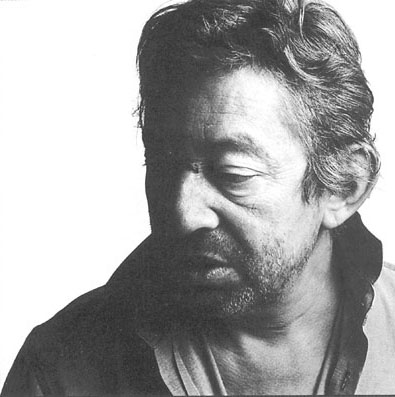
Mentre dunque le varie Fance Gall (la Rita Pavone
francese), Petula Clark, Régine, nutrivano il suo principesco
conto in banca, sbancando al botteghino, Serge scriveva per
sé opere formalmente rivoluzionarie e artisticamente
strepitose quali L’Histoire de Melodie Nelson
e L’homme à la tete de choux, due veri
romanzi discografici, che percorrono fra momenti narrativi e
lirici, una storia precisa, anche se molto tinta di un surrealismo
decadente, o anche Vu de l’exterieur, album a
tema sulla donna oggetto, quintessenza del dandismo sadico dell’autore.
Uno dei suoi lavori più indecifrabili resta però
Rock around the bunker, un intero album sul nazismo
e la persecuzione antiebraica; ribadiamo che Serge era di famiglia
ebrea piuttosto praticante, anche se personalmente ateo; durante
l’occupazione nazista aveva una dozzina d’anni e
aveva personalmente portato la stella gialla cucita addosso,
la sua famiglia e lui avevano dunque sfiorato la morte, eppure
neanche i ricordi personali gli evitano di licenziare uno strano
disco dove dei testi di un humour nero devastante si accompagnano
a un sound che cita filologicamente il rock anni cinquanta,
quello di Bill Haley e del primo Elvis, forse la forma più
volutamente leggera e inconsistente, la musica antintellettuale
per antonomasia. Ancora una volta, e sul tema più pesante
di vergogna e di sangue per definizione, Gainsbourg offre una
percezione totalmente straniante del reale, riduce in scioglilingua
alla ventiquattromila baci i più trucidi slogan nazisti,
agghiaccia l’ascoltatore, non lasciando spazio per alcuna
commozione liberatoria, quando mette in bocca a un bambino (che
poteva essere lui stesso): “ho vinto la yellow star/e
porto la yellow star/difficile per un ebreo/la legge dello struggle
for life”.
Il genio di Gainsbourg appare però, qui come nel resto
della sua opera, potentissimo perché dietro il paravento
di tutto questo nulla, di questa tragica sfiducia nelle possibilità
della comunicazione, nell’irrisione di ogni intenzione
di condividere un qualsivoglia sentimento, si intravedono i
fantasmi terribili che popolano la vita dell’autore.
Dio è un fumatore di avana
Vedo le sue nubi grigie
E so che fuma anche di notte
Come me, mia cara
Dio è un fumatore di avana
È lui stesso che m’ha detto
Che il fumo porta in paradiso
Lo so, mia cara. (Dio fumatore di avana, 1978)
Questi fantasmi prendevano sempre più piede, man mano
che andava avanti il suo alcolismo (la sua prima colazione era
composta da un cocktail di champagne e vodka), l’intossicazione
da nicotina (al ritmo di cinque pacchetti al giorno), la tragica
insonnia che lo portava a percorrere le strade della Parigi
notturna per parlare con gli spazzini, i commissariati di polizia
dove discuteva con la triste umanità di prostitute, ladruncoli
e spacciatori che li popola. Questi fantasmi che, dopo aver
dominato i deliranti anni che gli restavano da vivere, e di
cui parleremo il mese prossimo, se lo divorarono.
 Alessio
Lega Alessio
Lega
alessio.lega@fastwebnet.it
(la seconda parte sarà pubblicata
su “A” 301)
|

