| Quattro
dialoghi
Nel 1903, la polizia dello Zar segnalava Bogdanov e Lenin come
i due rivoluzionari “più pericolosi in assoluto”
(1). Insieme, uno in Russia e l’altro
dalla Svizzera, guidarono la neonata fazione dei bolscevichi
durante la Rivoluzione del 1905 – una rivoluzione fallita,
come è noto, ma importante per la formazione dei “soviet”.
Nel 1909, Lenin diede lo storico calcio al tavolo scrivendo
e pubblicando in tutta fretta Materialismo ed empiriocriticismo;
e, soprattutto, lasciando il compagno a meditare sull’ipotesi
di “suicidarsi, dopo essere stato escluso dai piu’
importanti comitati di partito” (2).
Bogdanov, che fu “lo scrittore di gran lunga più
produttivo e popolare della socialdemocrazia russa”, accanto
a Plechanov (3), continuò a
lavorare, deprecando la Rivoluzione d’Ottobre –
prima e dopo i fatti –, e subendo anche un arresto nel
1923 (4), fino alla morte –
che lo colpì, in modo non del tutto chiaro, quando aveva
cinquantacinque anni, nel 1928.
Sotto il regime di Stalin, di pari passo con la canonizzazione,
a massimo riferimento gnoseologico del marxismo, proprio della
summenzionata opera che Lenin aveva concepito e scritto contro
di lui, le sue opere furono “fatte sparire” dalla
circolazione (5).
Ben poco dei suoi scritti è oggi accessibile a chi, perlomeno,
non conosca il russo. Comunque, sul finire degli anni ’80,
Ernst von Glasersfeld si reca ad un convegno per parlare del
suo “costruttivismo radicale”, e, grazie a un collega
russo venuto in possesso di un volumetto sfuggito alla censura,
scopre che Bogdanov esprimeva, dice Glasersfeld, “con
chiarezza ed eleganza eccezionali, alcune riflessioni che sono
di fondamentale importanza nel costruttivismo” –
anticipando una serie di argomentazioni con cui i filosofi della
scienza “si sono spesso scontrati”, dagli anni ’50
in poi (6).
Il volume in tal modo fortunosamente recuperato e appena tradotto
in italiano, per la prima volta, a cura di Felice Accade (7),
è intitolato Quattro dialoghi su scienza e filosofia.
Fu pubblicato nel fatidico anno della rottura con Lenin, il
1909.
Ma più che rispondere direttamente a Lenin (8),
direi che forse questi dialoghi trasfigurano la loro vicenda
umana, oramai disperatamente in crisi, raccontando di due personaggi:
un “marxista funzionario del Partito” il primo,
chiamato A, e “un vecchio propagandista” il secondo,
chiamato B.
Il primo personaggio, una parodia che rovescia il Lenin che
improvvisamente si chiude nella biblioteca pubblica di Londra
(come già Marx) per ridurre il suo divario di erudizione
rispetto a Bogdanov e attaccarlo sul piano filosofico, si presenta
così:
 A: Mi scusi se l’importuno. Anche se non ci conosciamo
affatto, mi permetto di chiedere aiuto e consiglio a un competente
par suo. Mi piacerebbe studiare filosofia. Come devo cominciare?
A: Mi scusi se l’importuno. Anche se non ci conosciamo
affatto, mi permetto di chiedere aiuto e consiglio a un competente
par suo. Mi piacerebbe studiare filosofia. Come devo cominciare?
B, il personaggio a cui è affidato il sapere di Bogdanov,
acconsente al dialogo, che entra subito nel vivo dei tormenti
filosofici di A, che, in realtà, aveva già iniziato
a studiare:
 A: ammettiamo pure che esista un essere esterno, che esista
la conoscenza, che il soggetto e l’oggetto ne siano la
condizione... Ma perché tutto questo? E se la conoscenza
è necessaria, qual è il suo posto? E una volta
letto tutto quanto c’è da leggere, se si cerca
un riscontro, che rapporto c’è...
A: ammettiamo pure che esista un essere esterno, che esista
la conoscenza, che il soggetto e l’oggetto ne siano la
condizione... Ma perché tutto questo? E se la conoscenza
è necessaria, qual è il suo posto? E una volta
letto tutto quanto c’è da leggere, se si cerca
un riscontro, che rapporto c’è...
 B: Credo di aver capito. Siamo partiti con il piede sbagliato.
Per lei la filosofia è una questione di vita, non di
cose da leggere. Non potevo saperlo.
B: Credo di aver capito. Siamo partiti con il piede sbagliato.
Per lei la filosofia è una questione di vita, non di
cose da leggere. Non potevo saperlo.
B sottopone ad A domande su domande, come da tradizione platonica
– ma esse, a differenza di quelle del presunto Socrate,
sono finalizzate a confezionare la proposta di un “monismo
scientifico”; un punto di vista che, gradualmente, sarebbe
destinato a sostituire, paradossalmente, proprio quella “filosofia”
che A voleva studiare – e, soprattutto, “vivere”.
A, marxista e funzionario del Partito, rispondendo alle domande,
deve collocare la filosofia nella “sovrastruttura”
– come “coronamento dell’ideologia”;
mentre le “forze produttive” della società
si troverebbero nella sua “base”.
B passa a chiedergli, allora, se egli sa qualcosa della “capacità
di lavoro dell’uomo”: per arrivare, passando per
“tutta la struttura organizzata dell’uomo”,
alla “teoria della lingua” e “al problema
della sua nascita e della sua evoluzione”, su cui, ovviamente,
inchioda il suo interlocutore:
 B: Come lei sa, la parola è lo strumento della comunicazione
(...). E, in quanto marxista, lei sa bene che se un lavoratore
non padroneggia i suoi utensili saranno questi a padroneggiare
lui.
B: Come lei sa, la parola è lo strumento della comunicazione
(...). E, in quanto marxista, lei sa bene che se un lavoratore
non padroneggia i suoi utensili saranno questi a padroneggiare
lui.
Il primo dialogo si chiude con una battuta, da parte di A,
che messo di fronte alla propria ignoranza non si offende affatto,
mentre, al contrario – apprezza il suggerimento:
 A: e adesso mi metterò a studiare l’alfabeto...
delle forze produttive.
A: e adesso mi metterò a studiare l’alfabeto...
delle forze produttive.
Ernst von Glasersfeld trova una notevole “congruenza”
fra le tesi di Bogdanov e il suo “costruttivismo radicale”.
Soprattutto allorquando Bogdanov, “con riferimento all’esperienza”
che Glasersfeld considera “il concetto fondamentale del
suo pensiero”, afferma che non si devono considerarne
gli “elementi” come “indipendenti dall’essere
umano”. Per entrambi, in breve, “non ci sono elementi
a priori, visto che è l’uomo stesso a
determinarli e definirli, isolandoli nel flusso dell’esperienza”
(9).
Gli “elementi dell’esperienza” (parole di
Ernst Mach) sono sempre ulteriormente analizzabili, provenendo
dal “lavoro” (categoria fondamentale in Karl Marx),
sia individuale – di soggetti pensanti –, e sia
collettivo – di appartenenti a movimenti culturali e politici,
famiglie, comunità linguistiche, classi sociali e così
via.
Il concetto di “cultura proletaria”, proposto da
Bogdanov partendo dal Marx che faceva di ogni pratica (socializzata)
un criterio di “verità” e dal Mach che scomponeva
tutta l’esperienza in “elementi” e loro “combinazioni”,
era alla base della rivoluzione costruttivista-bolscevica che
non ci fu – stroncata dal dogmatismo di Lenin.
Per il “costruttivismo radicale” di Glasersfeld
come per Bogdanov, in conclusione, è cruciale la lotta
degli atteggiamenti sensati – solitamente propri della
vita quotidiana – contro i misticismi-autoritarismi –
tutelati dagli pseudo-problemi della filosofia.
 Francesco Ranci
Francesco Ranci
Note:
- Massimo Stanzione, Selezione, organizzazione e metodo
scientifico in A.A. Bogdanov; in Quattro dialoghi
su scienza e filosofia di A.A. Bogdanov, Odradek, Roma,
2004, p. 63.
- Massimo Stanzione, cit., p. 63.
- Silvano Tagliagambe, Bogdanov tra costruttivismo e scienza
dell’organizzazione; in Quattro dialoghi,
cit., p. 95.
- Daniela Steila, Scienza e rivoluzione. La recezione
dell’empiriocriticismo nella cultura russa (1877-1910),
Le Lettere, Firenze, 1996.
- Ernst Von Glasersfeld, Prefazione a Quattro dialoghi,
cit., p. 7.
- Ernst Von Glasersfeld, Prefazione a Quattro dialoghi,
cit., pp. 7 e 10.
- A.A. Bogdanov, Quattro dialoghi su scienza e filosofia
– con scritti di Ernst von Glasersfeld, Massimo Stanzione
e Silvano Tagliagambe, Odradek, Roma, 2004. Con presentazione
del curatore, Felice Accame.
- A. Bogdanov (et al.), Fede e scienza, Einaudi,
Torino, 1982.
- cfr. Ernst Von Glasersfeld, Prefazione a Quattro dialoghi,
cit., p. 7.
Acrobati
Acrobati
di vita quotidiana senza applausi
fra eroiche guerre mai dichiarate
eppure sofferte in recinti prigioni
camuffate di pietose attenzioni.
Tortuosi
percorsi ginnici
liberi consigli mentali
propensi a correggere sbagli
e centrare possibili, vicini, bersagli.
Cacofoniche
immagini estetiche
prodotte da suoni scomposti
fra spine con rose coltivate
in pentagrammi di note stonate.
Nascondersi
vorrebbe Cyrano
all’amore il pronunciato naso
componendo amabili versi
ma passa parola a terzi.
Nasconderci
ci hanno provato
poi, comodo e appropriato, non più
guardarci lontano…diversamente
abili…che nome strano
Ma le parole
feriscono con un sorriso
più di uno storpio detto da cattivo
se la differenza è tra un noi e quelli là
quale
consiglio , allora, mi dà?
Lasciarci giocare la vita.
Siamo acrobati…tutto un hoplà!
16 settembre 2004
 Jules Élysard
Jules Élysard
Guerra, terrorismo
e Stato di polizia
Nulla è
pieno quanto l’assenza
tagliata da una luce caliginosa
sull’opaca, densa, superficie a specchio
la paura vi scivola lenta e minacciosa
rigandola con triste esperienza.
Neppure
il silenzio fa la sua parte
quando nessuno vi presta più orecchio,
quando il rumore cala spietato, ingombrante
su occhi smarriti che guardano il tetto
… dove andare?…cosa fare?
E tocca,
tocca ricordarle…strazianti
immagini indicibili di volti senza sorriso,
in fogli quotidiani distrattamente orribili
alla ricerca di un perché, di un motivo
per quegli urli, quei dolori, quei pianti.
Nomi, date,
luoghi, sofferta geografia
di una pietà ormai morta, di sentimenti
da tempo sepolti, giacché liberi orizzonti
mentali non erano rinchiusi altrimenti
tra guerra, terrorismo, e stato di polizia.
11 settembre 2004
 Jules Élysard
Jules Élysard
Prima edizione,
Prima Internazionale
Pubblichiamo uno stralcio dell’introduzione, scritta
da Giampietro “Nico” Berti, al libro di James Guillaume
L’Internazionale. Documenti e ricordi (1864-1878).
Edito dal Centro Studi Libertari Camillo Di Sciullo.
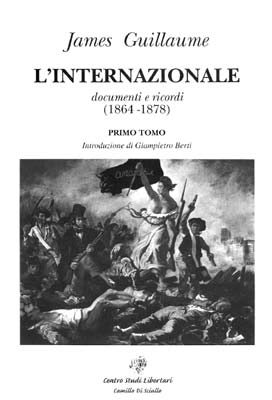 |
“La prima edizione dell’Internazionale
fu pubblicata a Parigi, in quattro volumi, tra il 1905 e il
1910.
Una seconda edizione ha visto la luce, sempre a Parigi, nel
1985. Quella che viene qui presentata è la prima versione
in lingua italiana, la quale, pertanto, sconta un secolo di
ritardo rispetto all’uscita originaria dell’opera.
Tuttavia il lavoro di Guillaume risulta ancora oggi fondamentale,
non certo sotto il profilo strettamente storiografico, dato
che la bibliografia sul tema annovera ormai un numero elevato
di ricerche importanti, ma perché costituisce una fonte
“classica”, e per certi versi insuperabile. Guillaume,
infatti, ha fuso insieme la documentazione archivistica e la
documentazione bibliografica (libri, opuscoli, memoriali di
vario genere), intrecciando i resoconti giornalistici e gli
articoli tratti dai periodici dell’epoca, brani di opere
e di testi ufficiali, lettere di vari personaggi e molti ricordi
personali e altrui.
Specialmente l’intreccio delle memorie rende l’opera
interessante perché l’insieme dei particolari e
degli aneddoti più curiosi e i più diversi ha
una grande capacità evocativa, offrendo una panoramica
assai “ravvicinata” degli uomini e degli eventi
del periodo. Il risultato di questo intreccio oggettivo-soggettivo,
steso volutamente con metodo il più possibile filologico
e descrittivo, è stato la delineazione di un quadro pressoché
completo di ciò che è avvenuto dal 1864 al 1878
(anche se buona parte della ricostruzione storica riguarda la
Svizzera).
Se scorriamo l’indice di quest’opera possiamo agevolmente
constatare come siano cronologicamente riportati tutti i principali
avvenimenti dell’associazione. Sono descritte le vicende
dei congressi internazionali svoltisi a Ginevra, Losanna, Bruxelles
e Basilea, la Conferenza di Londra del 1871 e il congresso dell’Aja
dell’anno successivo. Non sono tralasciati avvenimenti
“laterali” quali i congressi della Lega della pace
e della libertà, e fatti locali riguardanti soprattutto
l’ambito elvetico, peraltro importante, essendo di per
sé un ripetuto luogo di incontro fra i maggiori esponenti
internazionalisti…
Molte pagine sono dedicate alla guerra franco-prussiana e alla
Comune di Parigi perché costituiscono un momento decisivo
per la storia delle organizzazioni operaie e socialiste. Dopo
il congresso dell’Aja, che di fatto pone fine alla Prima
Internazionale, la ricostruzione di Guillaume si focalizza soprattutto
sulla nascita e sugli sviluppi del movimento anarchico, specialmente
per quanto riguarda l’Italia e la Spagna, due Paesi nei
quali l'anarchismo si esprime con vari tentativi insurrezionali
seguiti da inevitabili repressioni governative.
Complessivamente gli anni che vanno dal 1872 al 1878 trattano
della genesi anarchica riguardante l'aspetto ideologico e l'aspetto
organizzativo; una genesi che imprime quei caratteri fondamentali
che determineranno gran parte della storia futura del movimento.
Naturalmente con l’Internazionale Guillaume non ha avuto
la pretesa di presentare un'opera “obiettiva”, immune
da ogni forma di soggettività. Il solo fatto di darle
come sottotitolo Documenti e ricordi testimonia questa consapevolezza.
Ci troviamo infatti di fronte ad un'interpretazione che risente
della personale angolazione dell'autore, la quale è data
soprattutto dalla forte accentuazione anti-politica volta a
sottostimare il vero senso dello scontro tra marxismo e anarchismo,
così come esso è emerso dal 1864 al 1872. Sia
ben chiaro: lo scontro è ampiamente documentato (per
certi versi anche troppo), ma lo è entro un'ottica di
tipo “etico”, vale a dire che la contrapposizione
viene delineata rilevando i comportamenti scorretti da parte
di Marx e dei marxisti contro gli anarchici.
Al di là della evidente unilateralità di tale
impostazione – che comunque documenta fatti veri e sempre
taciuti da quasi tutta la storiografia marxista – va osservato
che Guillaume finisce per sottovalutare il ruolo leaderistico
e tutto “partitico” svolto da Bakunin e dallo stesso
Marx. Un ruolo, per l'appunto, che è stato eminentemente
politico e sul quale si sono giocate le sorti della Prima Internazionale.
La vera posta in gioco, infatti, era la determinazione politica
da imprimere all'organizzazione operaia, da parte di due concezioni,
quella marxista e quella anarchica, che non avevano alcuna possibilità
di mediazione.
La presente introduzione ruota attorno alla centralità
di questa contrapposizione, che peraltro costituisce l'interesse
maggiore dell'opera. Delineeremo quindi alcuni aspetti fondamentali,
analizzando soprattutto tre punti: 1) l’opposta interpretazione
delle fonti ideologiche originarie dell'associazione che dovevano
legittimarne l'esistenza, 2) l’opposta interpretazione
della guerra franco-prussiana e della Comune di Parigi; 3) l’opposta
interpretazione del ruolo che avrebbe dovuto assumere l’Internazionale
nella lotta del movimento operaio e socialista contro il capitalismo
e contro lo Stato”.
 Giampietro “Nico” Berti
Giampietro “Nico” Berti
Dal
catalogo delle edizioni del CSL Camillo Di Sciullo
Collana
Biblioteca del “Pensiero”
1) Francesca Piccioli, Virgilia D’Andrea,
storia di un’anarchica, pp. 192, € 10,00
2) Luigi Corvaglia, Psicopatologia della libertà,
pp. 208, € 10,00
3) Ugo Fedeli - Giorgio Sacchetti (a cura di), Congressi
e convegni della Federazione Anarchica Italiana (1944-1995),
pp. 560, € 18,00
4) Edoardo Puglielli, Abruzzo Rosso e Nero,
pp. 272, € 12,00
5) Leone Tolstoj, Per l’uccisione di re Umberto,
pp. 80, € 8,00
6) James Guillaume, L’Internazionale documenti
e ricordi (1864-1878), 4 tomi per complessive pp.
2160, € 80,00
7) Fabio Palombo, Camillo Di Sciullo, anarchico
e tipografo di Chieti, pp. 96, € 10,00
8) Luigi Balsamina, Antonio D’Alba, storia
di un mancato regicida, pp. 128, € 10,00
Collana
Quaderni dei CSL Camillo Di Sciullo
1) G.P. Maximoff, Gli anarcosindocalisti nella rivoluzione
russa
2) Kreszentia Mühsam, Il calvario di Erich
Mühsam
3) Luigi Compolonghi, Amilcare Cipriani.
4) Domenico De Simone, Banca del movimento
5) Pierre Ansart, Proudhon, il socialismo come autogestione
Per
richieste
CSL Camillo Di Sciullo C. P. 86, 66 100 Chieti
email: fab.pal@libero.it |
Chiavi
che
aprono il cuore
Riflessioni a margine di “Le chiavi di casa”,
il nuovo film di Gianni Amelio.
Eccoci dunque al cinema, sedute nel freddo della sala condizionata,
e sì che l’autunno incombe, ma tant’è,
l’aria condizionata oramai sembra più indispensabile
dell’aria stessa, attente e curiose dopo l’abboffata
di recensioni al buio, le ricche commozioni veneziane, i naufragati
pronostici degli inviati speciali.
Eccoci, io e mia figlia Maria Elena, insieme ad altri quattro
gatti, all’ultima proiezione in un sabato che, al solito,
consuma i propri fasti in pub sempre più zeppi e rumorosi,
nell’inarrestabile movida che persino la nostra
liberale sindachessa di Alleanza Nazionale incoraggia e promuove.
Ho appena consegnato le chiavi di casa ad un distratto spettatore
che le aveva abbandonate sul divano rosso della saletta d’attesa
e mi auguro per ricompensa un bel chiasmo con le metaforiche
chiavi di Amelio, sperando di non dovermi sorbire l’ennesimo
strabiliante idiot savant del cinema che lava le coscienze
e fa sentire tutti più buoni.
Altrochè! Queste chiavi, cari spettatori, son grimaldelli
che le scassinano le coscienze, che tengono a disagio sul bordo
della comoda poltrona di prima visione, che additano ed accusano
ogni indifferente e lagnosa normalità.
Queste chiavi aprono il cuore, sì, ma non consentono
di chiudere il cervello né di uscire dal cinema piagnucolosi
e rasserenati.
Intanto gli attori. Bravissimi, ancor più bravi perché
sono per la maggior parte del film solo in due, padre e figlio,
e tengono costantemente tempo, espressività e recitazione
a livelli altissimi. Il misuratissimo, spaventato, stranito
Kim Rossi Stuart (il padre), è bellissimo, e se ne impippa,
Andrea Rossi (il figlio) è stupefacentemente naturale,
ed io dico che se un ragazzino affetto da tetraplegia spastica,
e che con il cinema non ha mai avuto a che fare, riesce ad apparire
“vero” su di un set cinematografico, può
voler dire solo che è un bravo attore. Quanto a Charlotte
Rampling, meriterebbe l’oscar quale miglior attrice non
protagonista per avere, con la propria grandezza artistica,
donato dignità e visibilità a tutte le madri sconfitte
dalla crudeltà del caso, ed anche la corona di miss mondo
quale più bella ultracinquantenne che giammai fece iniettare
nel suo splendido volto una sola goccia di silicone!
E veniamo al film.
È uno splendido film triste e calmo, come occorre che
sia quando il tema trattato è quello di una diversità
difficile, dolorosa, faticosissima. Ragazzi, qua non siamo dalle
parti di Rain Man e neanche da quelle di Shine.
Qui non ci sono grandi talenti che riscattino l’handicap,
qua nessuno suona il pianoforte, nessuno fa straordinari calcoli
matematici, nessuno scopa o va a ballare. La sola abilità
del piccolo disabile è quella di pestare furiosamente
sul game boy!
C’è un bambino di 15 anni, Paolo, che cammina col
trespolo, e ci fa una fatica boia, c’è un padre,
Gianni, che è scappato per un tempo inaudito e forse
torna solo perché è riuscito a fare un altro figlio
“normale”, ad avere una vita normale (Gianni è
innamorato e felicemente sposato ed ha un bambino di otto mesi),
ma non saprà mai, il regista giustamente non glielo fa
sapere, se potrà recuperare il tempo smarrito e rimediare
alla passata vigliaccheria. A quest’uomo capita all’improvviso
di dover affrontare le proprie responsabilità, esattamente
come capita nella vita, e lo fa con un coraggio continuamente
interrotto dall’ansia e dall’incertezza, e con una
dolcezza che fa male al cuore.
Ci sono due esseri umani, ignoti l’uno all’altro,
che partono per un viaggio della speranza in una città
straniera, che si scoprono ed imparano ad amarsi (meravigliosamente
pregne di fisicità le scene in cui padre e figlio si
abbracciano, mangiano, fanno il bagno insieme): l’uno,
il bambino disabile, il debole, lo sfortunato, con una forza
che è la forza di chi prende la vita per quello che offre
e la percorre come una lunga strada sconosciuta e affascinante
(commovente l’impavida fuga di Paolo nella città
aliena, straordinario quel suo stare in piedi e assorto tra
le scosse dell’autobus); l’altro, l’adulto
sano, l’uomo bello e gentile, il padre che ha tradito
ma sa tornare, e rimanere, con la fragilità di ogni uomo
che si dibatte fra la necessità e la paura di amare.
Gianni Amelio è stato da sempre interessato alle realtà
difficili calate in un preciso contesto storico-sociale, e forse
per tale suo impegno può essere considerato in un certo
senso l’ultimo dei neorealisti (esemplare la scelta di
far recitare la parte del disabile ad un autentico disabile,
a tal proposito lo stesso Amelio ha dichiarato di non aver pensato
un solo momento di usare un vero attore “anche se sapevo
di andare incontro ad un possibile fallimento tecnico”),
non meno però che allo scandaglio del rapporto tra adulti
e bambini, tra genitori e figli (Il ladro di bambini,
Colpire al cuore), ed ogni volta ha saputo coniugare
egregiamente il dramma dell’esistenza quotidiana con quello
dell’incomunicabilità umana, ma questa volta tocca
a mio parere il suo punto più alto.
Si è detto che questo film è la storia del difficile
rapporto tra padre e figlio, tanto più difficile perché
il figlio è un diverso e non c’è nessuna
donna a mediare o a lenire (se si esclude la breve apparizione
della madre di un’altra disabile, impersonata dalla Rampling,
di per sé nient’affatto consolatoria), ma io ritengo
che sia altro e più.
Io penso che il tema centrale di questo film, il suo fondamentale
motivo ispiratore, sia proprio l’handicap e che Amelio
sia riuscito a far diventare la storia di Paolo, un diverso
come tanti che ci passano accanto, senza che noi “normali”
gli dedichiamo più che un fugace pensiero solidale, la
storia di tutti noi, e l’ha fatto attraverso il personaggio-simbolo
di Gianni, il padre indifferente per 15 anni, così come
indifferenti siamo noi rispetto al dolore ed alle difficoltà
degli altri. Gianni rappresenta proprio noi, gli spettatori
che alla fine del film se ne vanno nella vita vera, e, restando
dietro lo schermo, sembra avvertirci: attenti, è questa
la vita vera!
 Maria Teresa Crespini
Maria Teresa Crespini
(con la preziosa consulenza di Maria Elena Lega)
|

