|
Sogno d’amore
È una bella conferma questa di Angelo Toninelli. Dopo
il suo Luigi Regoli anarchico, che inaugurò
questa rubrica, è uscito ora il suo nuovo romanzo Un
sogno d’amore (Edizioni ETS, 2003) ambientato nella
Firenze operaia ed artigiana dei primi anni settanta dell’Ottocento,
quando, sulla spinta della Comune di Parigi, delle sue grandi
glorie e dei suoi immani drammi, cominciano a diffondersi anche
in Italia le idee di emancipazione sociale della Prima Internazionale.
E il sogno d’amore che dà il titolo all’opera
è, sì, quello che si concretizza nell’unione
fra il giovane falegname Andrea Savioli e Giulia, ma anche quello
che diventa il sentire comune di una intera generazione, la
prima generazione dell’Italia unita, che, sulla spinta
della nuova identità nazionale, ne trascende e ne supera
i contenuti facendosi internazionalista, rivoluzionaria, anarchica.
Toninelli ha scritto, indubbiamente, un romanzo storico nel
senso più pieno della parola, un romanzo, cioè,
nel quale si intrecciano indissolubilmente gli avvenimenti pubblici
e privati di quegli anni lontani. E, di conseguenza, anche la
piccola folla di personaggi che ne anima le pagine risulta una
felice mescolanza di figure di fantasia e figure in carne e
ossa. Di qua Giulia e Andrea, il pittore Riccardo Pampana e
Margherita, il carrettiere Franco e la fidanzata Francesca,
i popolani, i contadini, i cavatori e gli artigiani che avvicinano,
e si avvicinano, alle nuove idee di libertà e di uguaglianza;
di là i protagonisti storici del tumultuoso e avvincente
periodo di fermenti e speranze che prende l’avvio nel
1871. Ed ecco, allora, i “padri della patria” Garibaldi
e Mazzini, con i loro epigoni locali, Castellazzo, Socci, Stefanoni
e Martinati; e poi i nostri “padri”, Cafiero soprattutto,
mite e generoso, e Malatesta e Costa e Bakunin, e i loro primi
seguaci toscani, Francesco Natta, Gaetano Grassi, i coniugi
Pezzi, Lovari. E via via tutti gli altri. E accanto a loro,
a fare da contraltare nello schema narrativo come nella realtà
di quegli anni, questori e funzionari, giudici e avvocati, ministri
e regnanti, l’altra Italia, quella ufficiale, intenta
a rafforzare le deboli strutture del nuovo Stato e a cercare
di controllare, naturalmente per reprimere, tutto ciò
che si discostava dalla retorica della Nuova Nazione.
La vicenda, nel suo sviluppo narrativo, nel suo intreccio fra
vicende private e pubbliche, è quanto mai lineare. Andrea
Savioli, falegname figlio di falegnami con bottega nel quartiere
di Borgo Allegri, divenuto amico ed allievo del meccanico Francesco
Natta, instancabile organizzatore del movimento, si avvicina
alle idee dell’Internazionale, giunte in Italia, soprattutto
nelle Romagne e in Toscana, sull’esempio dei comunardi
parigini. Partecipa quindi attivamente alla costituzione della
prima sezione internazionalista fiorentina e ai momenti più
significativi di quel faticoso ma inarrestabile progredire dell’idea
anarchica, che per affermarsi dovette contrastare non solo la
scontata reazione dell’autorità, ma pure le lusinghe
strumentali e gli attacchi interessati dell’associazionismo
democratico borghese, guidato dagli accorti seguaci di Mazzini
e da quelli, più confusi, di Garibaldi. Divenuto presto
abile propagandista ed agitatore, Andrea divide la sua vita
fra l’amore e le attenzioni per Giulia, forte e affezionata
compagna di vita e di idee, e l’impegno politico e sociale,
fatto di continue trasferte nel contado e nei vicini paesi per
portarvi le nuove idee di libertà. Sono occasioni di
incontri, di discussioni e di nuove conoscenze, momenti resi
felici dal progressivo svilupparsi dell’organizzazione,
momenti resi difficili dalla necessità di conciliare
il proprio lavoro, provato dalla crisi seguita al trasferimento
della capitale a Roma, con l’impegno dovuto alla propaganda.
 |
Propaganda, congressi e scioperi
E lungo questo percorso sulla strada dell’emancipazione
e della ribellione, veniamo a incrociare, come dicevamo, i momenti
salienti della nascita dell’anarchismo in Italia, dagli
approcci propagandistici di Cafiero e Costa con gli ambienti
artigiani e proletari delle città ai congressi internazionalisti,
più o meno clandestini, di Rimini, Mirandola e Pisa,
dalla esperienza della Baronata, con la sua estroversa e a tratti
pittoresca compagine di frequentatori, ai primi scioperi operai,
dalle provocatorie mene questurinesche dei vari Terzaghi ai
tentativi insurrezionalisti del 1874, sfociati nei grandi processi
del 1875. È un succedersi di fatti e avvenimenti quali
possiamo ritrovare nei testi sul primo socialismo italiano (e
qui, infatti, riporto alcuni brani de Le origini del
socialismo a Firenze di Elio Conti, al quale si è
sicuramente ispirato Toninelli), talmente fitto e particolareggiato,
da sopraffare addirittura, soprattutto nei capitoli finali,
la storia personale di Giulia e Andrea. Ma anche se, per certi
aspetti, le vicende dei protagonisti passano in secondo piano
per cedere il passo ai “fatti” della storia, rimane
pur sempre la vividezza del ritratto appassionato di un ambiente
e di figure rese grandi dalla “grandiosità”
degli avvenimenti di cui furono partecipi. Ecco quindi, nei
capitoli finali, la fuga di Andrea per sottrarsi alle retate,
il riparare sui monti della Garfagnana dove trova le proprie
radici nell’accoglienza di una famiglia di lontani cugini,
i contatti con un altro mondo di proletari e lavoratori, i cavatori
delle Apuane, che autonomamente stanno dando corpo, anch’essi,
al loro sogno d’amore. Sono, queste della latitanza, pagine
intense e a tratti commoventi, per come riescono a restituirci
la comune e profonda semplicità del sentire di quei giovani
generosi e pronti al sacrificio.
Il racconto si conclude con il grande processo di Firenze del
giugno 1875, quando decine di internazionalisti toscani, tra
cui Andrea, sono accusati di aver ordito una cospirazione con
il fine della rivoluzione sociale. È il secondo processo
in Italia all’Internazionale e alle sue idee, quello che
avrebbe dovuto tagliare le ali al movimento sulla base di accuse
infamanti, e che invece vede completamente capovolti gli intenti
della pubblica accusa. Come ebbe a scrivere Masini, “il
processo divenne un clamoroso fatto di propaganda socialista
con l’autodifesa di Francesco Natta (che qui riporto quasi
integralmente nella coeva ricostruzione fatta dall’avv.
Bottero). Dopo aver posto ai giurati inquietanti quesiti non
sulla propria innocenza o colpevolezza ma sulle condizioni degli
operai italiani disoccupati, sfruttati, privi di assistenza,
di mezzi di vita e dei più elementari diritti”
il meccanico Natta (a cui dedico questo ritratto) “costringeva”
la Corte ad assolvere non solo i singoli imputati ingiustamente
accusati, ma pure la stessa Internazionale. A dimostrazione
che, in quegli anni, o la borghesia non aveva compreso il pericolo
che poteva derivare dalla diffusione delle idee libertarie e
socialiste, o le strutture del nuovo stato non erano ancora
adeguate alle mutate esigenze di controllo e repressione.
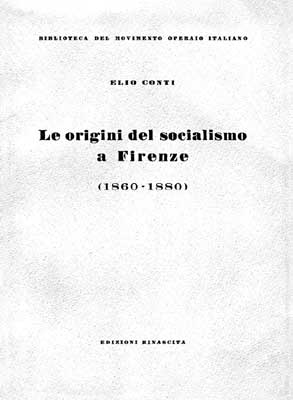 |
Sono molti i pregi di questo lavoro: una innamorata ricostruzione
della Firenze dei borghi e delle piccole vie che oggi non c’è
più, un affresco storico derivante da robuste letture,
tanto attento e particolareggiato da rischiare, addirittura,
di diventare invadente, una felice capacità di ricostruire
non solo i fatti ma anche la mentalità e il sentire di
quel piccolo mondo di popolani e artigiani che esprimevano,
nella loro semplicità, la grandezza di una “cultura”
altra e ostica alle banalizzazioni. Ma forse il suo pregio maggiore
sta proprio nell’avere colto questo aspetto così
peculiare delle comunità proletarie del passato, ossia
la loro capacità di creare una rete di relazioni nella
quale ogni individuo era anche la parte di un tutto, per cui
l’impegno sociale non era soltanto un “dovere”
sentito dalla parte più sensibile e generosa del proletariato,
ma un patrimonio comune del borgo o del quartiere. Era su queste
premesse che si innestavano le idee di libertà e le conseguenti
forme organizzative contro l’oppressione e lo sfruttamento,
era da queste premesse che nasceva, insopprimibile e meraviglioso,
il loro sogno d’amore.
 Massimo Ortalli
Massimo Ortalli
La camicia rossa
di Elio Conti
Nel contado fiorentino la propaganda era stata iniziata fin
dal 1872 ad opera del Fascio Operaio. L’anno seguente
la “Sezione di propaganda internazionale fra i contadini”
diffondeva diversi manifesti diretti ai “Fratelli della
Campagna”. Ma nell’indifferenza e nell’insensibilità
politica dei mezzadri le idee socialiste incontrarono un ostacolo
insuperabile. Maggiore fortuna incontrarono invece fra i braccianti
e gli artigiani dei piccoli centri che, come abbiamo visto,
costituivano una categoria miserabile ed irrequieta. Sezioni
dell’Internazionale si costituirono ben presto a Ponte
a Rifredi, a Ponte a Ema, a Sesto Fiorentino, a Rignano, a Prato,
a Fiesole. Il paese in cui la propaganda internazionalista assunse
proporzioni maggiori fu quello di Pontassieve, la cui Sezione
partecipò anche al Congresso regionale di Pisa del dicembre
1874.
Nei piccoli centri, dove non esistevano gruppi compatti di operai
e dove le idee politiche, inserendosi nelle lotte e nelle passioni
locali, subivano necessariamente una deformazione, l’Internazionalismo
assumeva una fisionomia particolare, paesana, per i pochi affiliati,
generalmente reclutati fra gli elementi più irrequieti,
le idee anarchiche costituivano uno stimolo alle più
strambe ed ingenue manifestazioni, come alle più audaci
ribalderie. I signorotti locali e le autorità avevano
interesse naturalmente a generalizzare questi episodi. Il delegato
di Pontassieve, tratteggiando, in un rapporto al questore, le
figure dei più noti internazionalisti del paese, si sforzava
di dipingerli come la peggiore e più pericolosa canaglia.
Un tintore veniva descritto come individuo “dedito al
vino e al gioco” già condannato per “ingiurie
e lesioni” e con “poca voglia di occuparsi della
sua professione”; un calzolaio, anch’esso condannato
per lesioni, era “dedito alle risse ed ai clamori notturni”,
un suo collega, che sapeva “appena leggere e scrivere”,
mostrava “pochissima voglia di lavorare essendo molto
dedito al gioco”; “al vizio del vino” pare
fosse dedito invece un cappellaio che “fa il sapiente
mentre non ha alcuna istruzione”; anche ad un contadino
piaceva “fare l’uomo sapiente ma – si affrettava
ad aggiungere il delegato – è di un’ignoranza
la più crassa”, e “legge i giornali solo
per chiacchierare”; un muratore era stato condannato per
frode, mentre un suo compagno pare avesse la debolezza di indossare
“per pompa nei giorni festivi la camicia rossa”.
Il piano
di Elio Conti
Nel frattempo si diffondevano in città voci allarmistiche
sull’arrivo di una banda romagnola nel Mugello: truppe
furono inviate dalle autorità a Borgo S. Lorenzo, Scarperia,
Marradi e numerose perlustrazioni vennero eseguite sui monti
dell’Appennino, ma delle “bande armate di tutto
punto” nessuna traccia.
Il giorno 12 il Natta spedì dall’Emilia la parola
d’ordine per l’inizio dell’insurrezione. Immediatamente
il Grassi ed il Lovari, componenti il Comitato rivoluzionario,
riunirono alcuni degli affiliati fuori la Porta a Prato, decidendo
di iniziare la sommossa alle ore 21 dello stesso giorno.
Il piano degli internazionalisti sembra fosse il seguente: al
segnale dato da un incendio provocato in un punto della città,
mentre il grosso degli internazionalisti si sarebbe riversato
nelle vie dei quartieri popolari per chiamare a raccolta gli
operai ed organizzarli, una banda armata avrebbe preso la via
di S. Casciano per impadronirsi dei fucili della guardia nazionale
depositati in quel comune; quindi, ingrossata da nuovi elementi,
si sarebbe data alla campagna per richiamare le truppe di presidio
in Firenze e distrarre l’attenzione delle autorità.
Allo stesso modo una banda armata si sarebbe formata in Pontassieve
per dirigersi a Firenze, interrompendo lungo la via le comunicazioni
telegrafiche e ferroviarie. In città gli insorti, organizzati
per squadre in ogni quartiere, avrebbero dato l’assalto
alle carceri per liberare tutti i detenuti, poi avrebbero attaccato,
col getto di materie incendiarie e al grido di “fuoco!”,
il Palazzo Vecchio, la prefettura, la questura, il gazometro
e le botteghe degli orefici sul Ponte Vecchio.
Brani tratti da: Elio Conti, Le origini del socialismo
a Firenze, Rinascita, 1950.
Uguaglianza assurda
di Alessandro Bottero
(Stralcio della requisitoria del Pubblico Ministero, N.d.R.).
Ora l’Internazionale prendendo il progresso a regresso
sopprime ogni libertà e proprietà individuale
per sostituirvi l’immane dispotismo collettivo ed in nome
d’un’uguaglianza assurda ed impossibile vuol parificare
il ricco al povero, l’abile all’inetto, il forte
al debole; il previdente al negligente, il probo al vizioso
disconoscendo che la maggiore o minore attività nel lavoro
è sorgente d’ineguaglianza, e che tale ineguaglianza
materiale è pegno di uguaglianza morale, conseguenza
del principio che ogni uomo deve essere retribuito a seconda
dell’opera sua e di quanto ha meritato.
Nell’ordine civile e giuridico si vuole l’emancipazione
assoluta della donna, l’abolizione del matrimonio la trasformazione
della famiglia e la distruzione in una parola di tutte quelle
istituzioni che sanzionate dalla legge, rappresentano perciò
il privilegio, e son quindi chiamate borghesi come
Borghesia l’insieme delle classi che di quelle
partecipano.
Avete udito la lettura dei documenti che si riferiscono alla
costituzione delle Sezioni di donne nell’Internazionale
italiana,– ivi sono scritte le nuove teorie sull’emancipazione
della donna.
Il Costa ed i pubblicisti della Lega così le riassumono:
“povera, abbietta, avvilita, condannata ad un lavoro insopportabile,
esposta, ai capricci brutali dell’uomo, la donna deve
scuotere il giogo secolare che la opprime per sollevarsi a libertà,
deve insorgere a domandare i suoi diritti, schierarsi con i
proletari onde combattere il privilegio e l’autorità,
deve alzare la fronte ed affermarsi, gridarsi non più
la soggetta ma la uguale dell'uomo, essa destinata a formare
la famiglia avvenire antitesi completa dell’attuale la
quale non è ché schiavitù e tirannia”.
La famiglia nuova infatti deve poggiarsi sulle basi della libertà
e dell’amore, quindi eliminazione del vincolo indissolubile
e legittimità del divorzio. Il libero amore senza legali
formalità è l’espressione semplice di una
legge immutabile di natura; quando l’uomo e la donna non
si amano il matrimonio è sciolto di fatto e nelle unioni
e nelle divisioni non possono né debbono entrare, per
i dettami di natura, calcoli egoisti, contratti notarili, benedizioni
di preti, articoli di codice civile e simili forme.
Il matrimonio attuale è la tomba dell’amore, è
la fonte dell'autorità maritale e paterna; il matrimonio
avvenire sarà quello dell’amore libero solo interprete
dei veri bisogni naturali non profanabile da alcun esercizio
di autorità.
Queste teorie, o Signori, basta esporle per giudicarle ed io
volentieri passo oltre.
Vittima del Capitalismo
di Alessandro Bottero
(Stralci dell’autodifesa di Francesco Natta, N.d.R.).
Voi o signori Giurati vi trovate di fronte un onesto operaio
accusato di cospirazione, contro lo Stato, per il solo fatto
di appartenere all’Internazionale.
Qualunque possa essere il Programma di detta Società,
io non prenderò a svolgerlo perché superiore assai
alle mie forze.
Solo mi limiterò a parlarvi di quella parte materiale
del programma che più da vicino mi riguarda come operaio,
e per il quale ho preso una parte attiva.
Le ingiustizie e le sofferenze di cui l’operaio è
continuamente vittima del Capitalista e del monopolio, senza
trovar altro che vane promesse, o non curanza ai suoi giusti
reclami, giustificano pienamente l’esistenza di quest’Associazione
la quale ha per scopo immediato la organizzazione del Lavoro.
(…).
Dunque o signori Giurati dietro a questi eloquenti fatti, in
Italia si deve conchiudere, che l’operaio legalmente non
puol che piangere le sue miserie in seno alla famiglia, soffocando
però quei gemiti, affinché non venghino sentiti
in pubblico, correndo il pericolo di essere cambiati come voci
sediziose, e come tali condannati.
Conchiudo adunqe col dire che l’Internazionale in Italia,
si presenta sotto un aspetto assai diverso a considerarsi da
quello del Pubblico Ministero.
(…).
Ora, o signori Giurati, se considerando questi fatti e come
liberi cittadini, e di una classe agiata della società,
di fronte a una moltitudine affamata di operai privi di lavoro,
con dei vecchi impotenti e dei pargoli macilenti fra le braccia
delle loro madri squallide e smunte dalla miseria, che sorgono
spinti non dai raggiri di un partito, ma da una causa assai
più potente, cioè la miseria; sorgono dico, a
tumultuare contro chi potendo non prende rimedio, e che invece
di provvedervi, immaginano una cospirazione impossibile; se
credete che questi infelici ma onesti operai, che chiedono pane
e lavoro, siano degni di casa di forza, allora non mi rimane
altro che subire con calma la mia sorte, convinto che non ho
nulla a rimproverarmi.
Ma se invece, nella vostra coscienza ha potuto penetrare quel
grido straziante, che con le mie deboli forze ho cercato richiamarvi
alla mente, oh allora non dubito di trovare in voi un atto di
giustizia, e per me sarà un giorno di gioia abbracciando
i miei figli, poter dire: Non tutti i borghesi sono insensibili!
Brani tratti da: Alessandro Bottero, Dibattimenti nel processo
per cospirazione e internazionalismo, Capaccini, 1875.
«Gliela facciamo in barba»
di Angelo Toninelli
Le gallerie dell’Appennino e le ripide scarpate su cui
correvano le rotaie gli facevano trattenere il fiato. Rimase
per tutto il viaggio inchiodato al finestrino, poco curandosi
dei sorrisi degli altri viaggiatori. “È la prima
volta”, si scusò, girandosi, per tornare subito
con gli occhi al vetro, oltre il quale scivolavano via boschi,
burroni, torrenti incassati tra le rocce e il buio improvviso
delle gallerie, che lo faceva sobbalzare, con il fischio della
vaporiera che assordava. Bologna gli apparve in basso, dopo
una lenta curva, con i palazzi, le chiese, le case tutte di
rossi mattoni e un velo di nebbia sopra i tetti.
Gli fu facile trovare Giovanni, che lo condusse fuori della
stazione attraverso la folla che sostava nella sala. “Vieni
dietro, ma a una certa distanza,”, gli disse sottovoce.
Si incamminarono svelti verso un caffè sotto il portico,
al di la della piazza.
“Aspettami qui”.
Giovanni entrò nel caffè e poco dopo uscì
insieme a due uomini.
“Vi mando subito chi vi accompagna”, e si allontanò
diretto alla stazione.
“E te di dove vieni?”, chiese ad Andrea uno dei
due, un meridionale alla parlata.
“Da Firenze”.
“Io dalla Puglia”, e gli diede la mano, “e
l’amico da Palermo”.
Si avvicinò un ragazzo, che fece un cenno con la testa
perché lo seguissero.
Proseguirono per un tratto sotto il portico, poi attraversarono
la strada ed entrarono in un vicolo.
“È pieno di sbirri intorno”, disse il ragazzo
con aria allegra, “ma noi gliela facciamo in barba”.
Passarono da una stradetta all’altra, poi in un orto,
in una casa, uscendo da una porticina che una donna aprì
dopo aver guardato fuori. Nessuno disse una parola.
Giunti in uno spiazzo sterrato, il ragazzo fece cenno di fermarsi,
attraversò di corsa e sparì dietro un cancello,
per riapparire dopo poco.
“Venite”.
Oltre il cancello, da un capannone di mattoni con le alte finestre
protette da grate di ferro arrivava la voce di uno che parlava,
sommersa tratti da un brusio. I due uomini presentarono dei
fogli a qualcun dietro la porta; Andrea tirò fuori la
lettera di Francesco e la consegnò a uno che la lesse,
lo squadrò con aria severa e si fece da parte per farlo
entrare.
Dentro il capannone, molti uomini se ne stavano seduti su panche
allineate di fronte a un tavolino, intorno al quale Andrea riconobbe
Cafiero e Costa; altri erano in piedi, appoggiati alle pareti.
Un uomo, il presidente del congresso Zanardelli, come seppe
poi, in piedi dietro il tavolo, gesticolava e parlava ad alta
voce, ma Andrea non riusciva ad afferrare che qualche parola.
Cercò di farsi largo e avanzare, quando sentì
una mano posarsi sulla spalla.
Era Gaetano.
Stroncare la propaganda
di Angelo Toninelli
Ad Andrea non era mai capitato di fare un’esposizione
filata degli argomenti, come si era preparato, ma era meglio
così: anche in quel modo, con continue interruzioni,
riusciva a dire le cose essenziali, che bisognava ribadire di
continuo. Punto primo, senza il quale era inutile qualsiasi
altro ragionamento, l’uguaglianza e la libertà
di tutti gli uomini, e quest’ultima intesa come rispetto
della libertà degli altri; poi, di conseguenza, il diritto
e dovere per tutti di lavorare, di non sfruttare e non essere
struttati, quindi la fine di ogni privilegio; infine il rifiuto
di affidare ad altri la propria vita.
“Dici bene”, era questa l’obiezione che i
più facevano: “Ma per venire al sodo, cosa proporresti
di fare?”
La risposta era sempre la stessa:
“Se siamo d’accordo su quanto s’è detto,
il da farsi dobbiamo deciderlo insieme, perché poi tutti
ci si deve impegnare a che le cose marcino come s’è
deciso”.
Ci teneva a mettere in chiaro le carte. La differenza tra l’anarchia
dell’Internazionale e la politica dei borghesi, si chiamassero
di destra e di sinistra, monarchici o repubblicani, consisteva
in questo, che i politici pretendevano di imporre a tutti cosa
fare per il bene generale – che solo loro conoscevano
– e chiedevano al popolo di affidarsi a loro; l’anarchia
invece significava l’impegno di tutti ad associarsi insieme
nel lavoro, collaborando a soddisfare i bisogni di tutti. Era
complicato? Certo. Si trattava di trasformare la società
con regole semplici e giuste: nessuno poteva oziosamente campare
sulle spalle degli altri e l’istruzione avrebbe consentito
di sviluppare, nel lavoro, le inclinazioni e le capacità
di ognuno. Lui, Andrea, avrebbe continuato a fare il falegname,
mestiere che gli piaceva fare, e loro, lavoratori della terra,
avrebbero prodotto i beni che sapevano produrre, ottenendo in
cambio dagli altri il necessario per vivere. Se la storia degli
uomini aveva partorito una società come quella in cui
vivevano, che perpetuava la disuguaglianza e l’ingiustizia,
gli anarchici non dovevano indietreggiare di fronte alla difficoltà
di costruire un modo di vivere completamente diverso. Anzi,
dovevano andar fieri del loro programma, l’umanità
avrebbe incominciato un nuovo cammino: bisognava estirpare nell’uomo
l’egoismo e la violenza e coltivare la fratellanza, la
solidarietà.
“Noi lavoratori però si deve capire prima di tutto
che nessuno ha interesse a liberarci dalle catene che ci tengono
schiavi. L’emancipazione, lo dice lo statuto dell’Internazionale,
non può essere che opera nostra”.
Ed ecco sempre l’altra domanda:
“E chi comanda oggi, se n’andrà zitto e buono?”
“Noi si cerca di diffondere le nostre idee, pacificamente,
discutendo come si fa oggi. Quando i lavoratori, che sono la
maggioranza del paese, vorranno realizzare il nostro programma,
vedremo cosa faranno i padroni e ci si comporterà di
conseguenza. Il governo e la polizia non perdono occasione per
tapparci la bocca. L’hanno fatto a Firenze, chiudendo
il Fascio, e a Bologna, dove volevano impedire il nostro congresso.
Se tanto mi dà tanto, non se ne andranno con le buone.
Allora, o ci si rassegna a rimanere sempre dei sottomessi o
bisognerà lottare. A Parigi, due anni fa, il popolo s’è
ribellato e ha dato del filo da torcere ai governanti borghesi.
C’è stata una carneficina, molti rivoluzionari
sono stati condannati all’ergastolo, ai lavori forzati,
fucilati; molti sono scappati, ma le idee della Comune continuano
a vivere e sono le nostre”.
I carabinieri erano stati avvisati di queste riunioni e avevano
informato le autorità cittadine che le idee sovversive
erano portate nei paesi dai contadini più intelligenti
e malcontenti che, andati al mercato, la sera tornavano a casa,
si intrattenevano in discussioni nei ritrovi e la domenica invitavano
gente dalla città. In questura erano anche giunte le
lamentele dei proprietari che desideravano qualche atto energico
da parte dell’autorità per stroncare la propaganda
degli internazionalisti, dato che le ordinarie perlustrazioni
dei carabinieri servivano a poco. Le loro pattuglie giravano
per i casolari o arrivavano all’improvviso nelle osterie:
anche se un silenzio ostile le accoglieva, il brigadiere, guardandosi
intorno, rivolgeva la domanda:
“Allora, si gioca o si discute di politica?”
“Si fa questo e quello tanto per passare il tempo”.
“Già è vagabondo
di suo”
di Angelo Toninelli
Avevano avuto fortuna, la giornata era tiepida, le siepi odorose
dei biancospini costeggiavano la strada, i campi coltivati parevano
morbidi tappeti verdi e sospese nella luce brillavano argentee
le foglie degli ulivi. Franco, seduto a cassetta, spronava con
schiocchi di frusta il Biondo che, appena la strada prendeva
a salire, rallentava svogliato. Andrea, con Gabriella in braccio,
sceso dal barroccio, camminava a fianco del cavallo; la piccola
si sporgeva per toccarlo.
“Povero cavallino, è vecchio, non ce la fa più.
Fagli una carezza”, diceva Andrea.
Anche Francesca e Giulia, impietosite, protestavano per le frustate
che Franco minacciava sui fianchi della bestia; gli chiedevano
di fermarsi, preferivano scendere.
“Guai a te se lo tocchi”, gridava Giulia.
“Brave, dategli spago, così il furbo ne approfitta.
Già è vagabondo di suo”, replicava Franco,
agitando in alto la frusta.
La casa non doveva essere lontana, si sentivano le voci venire
dall’alto. Giulia e Francesca avevano accettato volentieri
quella gita fuori città, poi il dubbio che di donne ci
fossero solo loro due aveva smorzato il primo entusiasmo. Si
erano rinfrancate solo quando, ormai in vista della casa, avevano
incontrato un gruppo di donne anche loro dirette alla festa.
In un angolo dell’aia, sopra un tavolo i bicchieri erano
pieni di vino rosso: gli uomini si avvicinavano, bevevano e
a turno qualcuno si curava di riempire di nuovo i bicchieri
vuoti, dopo averli sciacquati in un secchio d’acqua. Chi
voleva fare uno spuntino entrava in cucina. In un foglio appoggiato
su una sedia era scritta la somma spesa per vino, pane, prosciutto
e formaggi: l’offerta era libera, ma la spesa bisognava
coprirla e le lire in più andavano alla sottoscrizione
per Cipriani, quindi tutti erano invitati alla generosità.
Andrea conosceva molti dei presenti; via via arrivavano anche
altri compagni, una stretta di mano, poi andavano a sedersi
sui muretti intorno e nei campi. Le donne se ne stavano tra
loro in disparte e Gabriella passava in braccio dall’una
all’altra vezzeggiata e allegra.
Gaetano aveva portato la bandiera rossa e nera della Federazione
e Poggi l’aveva appesa in alto a una finestra. Non c’era
pericolo che i carabinieri si facessero vedere.
A un gruppo che lo circondava Francesco raccontava dei suoi
viaggi a Ravenna, a Imola, a Bologna e in varie parti della
Toscana: gli era stato affidato l’incarico di organizzare
i compagni più fidati e decisi, pronti ad agire se le
cose fossero andate in un certo modo; i risultati fino allora
raggiunti davano bene a sperare, ovunque aveva trovato entusiasmo.
Aveva incontrato anche Cafiero e Bakunin in Svizzera, alla Baronata.
L’impressione che gli aveva fatto il russo? Era un uomo
pieno di energia nonostante l’età e gli acciacchi;
conosceva le vicende e gli uomini tutti dell’Associazione,
era informato della situazione di ogni paese, delle lotte politiche
e delle prospettive che si aprivano in ogni parte del mondo;
discutere con lui era un’esperienza che tutti i compagni
dovevano augurarsi di fare. Costa teneva i contatti con i responsabili
dell’Internazionale a Bruxelles e si era recato là
più volte per metterli al corrente dell’organizzazione
che si stava preparando in Italia, dei mezzi predisposti. Francesco
non poteva dire di più. A un gruppo ristretto di compagni
aveva poi detto che quelli di Bruxelles si erano raccomandati
di agire con prudenza, di muoversi solo a condizione di essere
certi che la situazione fosse favorevole per un colpo di mano.
Bisognava evitare che in Italia, come era accaduto in Spagna,
si andasse incontro a un fallimento, che avrebbe gettato il
discredito su tutta l’Associazione. Le notizie che arrivavano
da Malatesta, dal sud, erano confortanti: laggiù molti
garibaldini, anche tra i più influenti, si dichiaravano
disposti ad agire insieme agli internazionalisti.
Gaetano chiese il silenzio e l’attenzione di tutti; col
braccio faceva cenno ai più lontani di avvicinarsi, doveva
comunicare una cosa importante.
“Finalmente anche Firenze ha la sua sezione femminile.
In San Frediano alcune lavoranti della manifattura dei tabacchi
hanno deciso di costituire una sezione dell’Internazionale
e nel giro di pochi giorni sono arrivate a più di quindici.
Tra noi c’è Luisa Pezzi”, Gaetano la indicò
seduta insieme alle altre donne e la invitò a farsi avanti:
“È arrivata a Firenze da poco ma si è subito
rimboccata le maniche col bel risultato che ho detto. Propongo
un brindisi a lei e alle compagne”.
Ci fu un applauso e Luisa, preso dal tavolo un bicchiere di
vino, lo tenne in alto e poi lo bevve tutto d’un fiato.
Era rossa in volto, forse per l’emozione.
“Bisognerebbe cantare la marsigliese”, gridò
Gaetano.
“La marsigliese? Cos’è?”, domandò
il vicino ad Andrea.
“L’inno dei rivoluzionari di Parigi”, rispose
Andrea.
Al suo sguardo interrogativo aggiunse: “Una canzone”.
“Non si conosce”, dicevano da più parti.
Uno accennò il motivo, ma non andò oltre l’“Allons
enfants de la patrie”.
“Siamo tutti stonati, è meglio starsene cheti”.
La festa continuò tutto il pomeriggio. Qualcuno se ne
andava via salutando con una voce, qualche nuovo arrivato stringeva
la mano a Poggi, rimaneva a guardarsi intorno e poi si muoveva
in giro rinfrancato. Sparpagliati nei campi intorno casa, lungo
le prode, sotto gli ulivi, ma attenti a non calpestare i seminati,
si formavano e si scioglievano i gruppi, parlavano della stagione,
del lavoro, della famiglia, di come andava la vita lì
intorno, nel paese, in città. Giulia e Francesca, incuriosite,
si erano avvicinate a Luisa: avevano mille domande da farle.
Gabriella, seduta sopra una coperta che la moglie di Poggi aveva
portato perché l’umido non le facesse male, giocava
con le margherite, i tromboni, le violette che Andrea aveva
raccolto per lei.
Brani tratti da: Angelo Toninelli, Un sogno d’amore,
ETS, 2003.
|

