|
 La provocazione permanente di
Serge Gainsbourg
La provocazione permanente di
Serge Gainsbourg
Seconda parte – Dottor Gainsbourg/mister Gainsbarre
(1979-1991)
Un sottile equilibrio ha tenuto inchiodato Gainsbourg per i
primi vent’anni della sua carriera a un ruolo di notorietà
laterale: conosciuto, ma non celebre; ammirato, ma
non idolatrato; apprezzato e vicino allo star system, per cui
scriveva canzoni di enorme successo, dimostrandone al contempo
il vuoto assoluto, non era però entrato a far parte di
questo star system in prima persona.
Per se stesso, come abbiamo visto, si riservava il ruolo di
ricercatore di forme nuove, di esploratore dei rapporti del
linguaggio col vuoto concentrico del continuo fluire delle mode.
Per una serie di eventi, dal 1978 al 1991, anno della sua morte,
Gainsbourg assurge al ruolo di star, forse l’unico idolo
fra i grandi autori francesi, certamente l’unico della
sua generazione, l’unico di cui tutt’oggi si trovino
i poster offerti dai venditori ambulanti, sui marciapiedi e
nelle stazioni dei metro, accanto a quelli delle star autolesioniste
della storia del rock (Jim Morrison, Jimi Hendrix, Kurt Cobain,
ecc.).
Quasi dovesse tener fede, per una sorta di coerenza con se stesso,
con la sua dimostrazione per assurdo del nulla con cui identifica
la società dell’immagine o lo spettacolo della
società, Gainsbourg si assume questo ruolo sulla sua
persona fino in fondo creandosi un alter ego: Gainsbarre.
Gainsbarre è la parodia di come Gainsbourg viene rappresentato
dai mezzi di comunicazione, una laida macchietta dell’erotomane
sempre ubriaco, incontrollabile e pericolosamente goffo, del
pigmalione depravato che crea ninfette inconsistenti (l’ultima
delle quali sarà Vanessa Paradis, per cui scriverà
un bellissimo album). Gainsbarre sarà in quegli anni
eternamente presente in televisione, intervistato tutti i giorni
su tutte le questioni possibili, e, alla fine, imprigionerà
Gainsbourg in un abisso di degradazione evidente, fino alla
morte.
E già, sono io, Gainsbarre
Mi si trova per caso
Nei night-club e gli american-
Bar, un po’ bonnard.
Ecce Homo
Lo si riconosce, Gainsbarre
Per i Jeans, per la bar =
Ba di tre notti, per il fumo
E per la sua disperazione.
Ecce Homo
Bizzarro questo Gainsbarre
È cool, si direbbe
Che di tutto non gliene
freghi niente, insomma…può darsi
Ecce Homo
E sì, inchiodato Gainsbarre
Al monte Golgota
È un reggae-ilare
Il cuore trafitto da parte a parte
Ecce Homo. (Ecce Homo, 1981).

L’enorme successo personale per Gainsbourg interprete
di se stesso, arriva appunto con quella che sarà la più
pericolosa provocazione della sua carriera: nel 1978, appena
scoperta una nuova forma musicale, vola a Kingston, e, primo
fra tutti i musicisti europei, incide un album totalmente reggae.
Il brano cui è affidata la promozione del disco è
un incredibile versione dell’inno nazionale, La Marseillese,
le cui strofe sono eseguite per intero, ma il cui ritornello
ripete solo, beffardamente, “Aux armes, et coetera…”
(“Armatevi, eccetera…”) tutto ovviamente con
tanto di coriste giamaicane e col gruppo di Peter Tosh alle
spalle. Il risultato è irresistibile. Nella patriottica
Francia la cosa è accolta come un affronto intollerabile,
le associazioni di paracadutisti ed ex combattenti, gli antichi
torturatori fascisti delle guerre d’Indocina e d’Algeria,
insorgono, e si presentano ai concerti (che Gainsbourg tornava
a dare quell’anno, dopo diciotto di assenza dalle scene),
tanto che quello di Strasburgo deve essere annullato perché
il palazzo in cui si doveva tenere viene minato col plastico.
Gainsbourg, pallidissimo, appare solo sul palco e con un filo
di voce ringhia “io sono un rivoluzionario, che cantando
su una musica rivoluzionaria, ha ridato alla marsigliese il
suo senso originale!” e la intona con un incredibile trasporto
(e con un coraggio non indifferente) davanti ai parà
in mimetica e armati.
Due anni dopo, nel suo secondo disco reggae, con più
sarcasmo, dedicherà a quell’episodio la terribile
Che nostalgia, camerata!
Che cosa ti ha preso, cazzo, per spaccare la capanna
Di questo baluba poi sguainare il coltello
Aprire la pancia al primitivo
Che sbaraccava dalla sua savana
Che nostalgia, camerata!
Che cosa t’ha fatto afferrare quella ragazza diafana
Fuori dalle grazie e sotto le sue unghie
Hai rimpianti? Rispondi: “negativo”
O meglio, ridacchi…
Che nostalgia, camerata! (Che nostalgia camerata, 1981).
Quando dico che Gainsbourg divenne famoso nel ’78 ovviamente
tengo conto dell’enorme successo commerciale di dieci
anni prima con Je t’aime, moi non plus, ma in
quell’occasione Serge si eclissò dietro il personaggio
del “signor Jane Birkin”, che, anche in qualità
d’attrice, impersonava la star; i due furono una celeberrima
coppia mediatica, ma lei riuscì a fare da paravento,
proteggendo così la fragilità reale del marito.
Con la dissoluzione di questa coppia (ma Serge continuò
fino all’ultimo a scrivere per lei), lui si trovò
ad affrontare da solo il rapporto suicida con i mass media,
dando come abbiamo visto vita a Gainsbarre.
Depressione al disotto del giardino
La tua espressione di tristezza
Mi hai lasciato la mano
Come se niente fosse
Stato, che l’estate fosse finita
I fiori hanno perso il loro profumo
Che porta via uno a uno
Il tempo assassino. (Depression au dessous du jardin, 1980).
Gainsbarre fece il diavolo a quattro… Per protestare
contro la pressione fiscale bruciò in diretta televisiva
un biglietto da 500 franchi (e bruciare titoli di Stato è
un reato). Invitato in una trasmissione con Withney Huston che,
secondo la migliore tradizione americana, si presentò
discinta e provocante nei modi, ma anche assolutamente puritana
nelle espressioni, lui, completamente ubriaco, la scioccò
(e gelò il povero conduttore ignaro) rivolgendole un
molto prosaico “Baby, i want fuck you” (ragazza,
voglio fotterti).
Alla fine tutte queste gaffe, divertenti all’apparenza,
viste di seguito rivelano la profonda disperazione, il clichè
ripetuto alla nausea di un uomo che spinge sempre un po’
più in là il suo disagio di esistere e che continua
a osare, quasi volesse capire dove lo lasceranno arrivare; la
stessa ossessione erotica che lo anima e che contrasta con un
fisico decisamente ingrato, se lo si svuota del suo carisma,
appare l’esplicita aggressione di un essere che vive molto
male nella sua pelle, e che, non avendo niente, rilancia per
prendersi tutto.
Ma quest’esistenza rappresenterebbe ancora solo una riflessione
sul tema del divismo, ardita ma non unica, se non fosse che,
con Gainsbarre occupato a fare il personaggio pubblico, Gainsbourg,
dall’interno, continua a creare opere, rivoluzionarie
per linguaggio e temi, e a distillare illuminazioni di poesia
purissima.
I dessous chics
È un niente a svelare il tutto
È dirsi che quando si arriva al fondo
È tabù
I dessous chics
È una giarrettiera che sbatte
Nella testa come un tip-tap
I dessous chics
È il pudore dei sentimenti
Truccato oltraggiosamente
Rosso sangue
I dessous chics
È conservarsi sul proprio fondo
Fragili come una calza di seta
I dessous chics
Sono trine e merletti
Di amarezza su un paravento
Desolante
I dessous chics
Sarebbe come il tacco a punta
Che attraversasse il cuore delle ragazze. (Les dessous
chics, 1983).
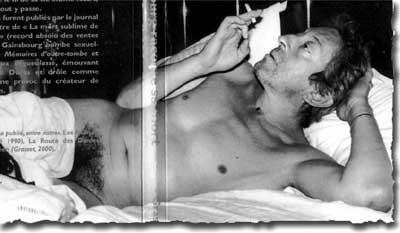
I suoi ultimi dischi, ancora e sempre all’avanguardia,
sono suonati dai musicisti di Micheal Jackson e in filigrana,
fra le solite tonnellate di perfidia e cinismo, lasciano intravedere
la tenerezza dell’uomo, si prenda ad esempio I’m
the boy, sull’omosessualità: “Il
ragazzo che ha il dono dell’invisibilità./Ombra
fra le ombre dei notturni torridi/mi perdo nel numero /per giungere
al sordido./Maschera fra le maschere/di tragedia o amarezza/cuoio
nero e caschi/che scintillano alla luna./Anima fra le anime/febbrile
nell’angoscia/quando brilla la lama/o scintilla lo sguardo./Uomo
fra gli uomini/nel nero o in avorio/ricercando i sintomi/di
un orgasmo illusorio./Puttana fra le puttane/m’infogno
nel fango/dove s’abbracciano i bruti/e si insanguinano
gli angeli”. In questa canzone, paradigmatica dei
due lavori pubblicati rispettivamente nell’85 e nell’88,
un montaggio serrato di immagini, che cortocircuita stereotipi
e accostamenti arditi, fa contrasto con una perfezione formale
che tiene in equilibrio la lirica, facendola assomigliare a
una statua della classicità ellenica, come il Lacoonte
che viene sostenuto dagli stessi serpenti che lo stanno strangolando;
in questa, come nelle altre canzoni di questo periodo (e si
pensi già solo alla controversa Incesto al limone,
cantata in duo con la figlia Charlotte), tutto resta sospeso
in una rappresentazione che non conosce relazioni morali fra
le cose, ma solo una grande estetica dell’esistente in
cui con-vivono (o forse muoiono assieme) sordido e sublime.
Ma sono gli ultimi fuochi. Quasi insopportabilmente stravolto
dagli eccessi di Gainsbarre, Gainsbourg fu folgorato dall’ennesima
crisi cardiaca il 2 marzo del 1991.
 Alessio Lega
Alessio Lega
alessio.lega@fastwebnet.it
|

