| L’apocalisse
e il cantico
In fondo a una tonnellata di rabbia si trova la dolcezza dell’uomo.
Quella miseria delle nostre vite, contro cui digrigna spesso
i denti, gli aveva dapprima suscitato un’enorme tenerezza.
La strada di questa confessione, oggi esplicita, ha dovuto far
passare la sua poesia attraverso lo «stile dell’invettiva»,
la rivolta delle parole.
Sentendosi steso sopra un vuoto esistenziale, spaventato dall’informe
magma che prende la nostra esistenza come esseri sociali, Mauro
Macario urla contro la volta pietrosa della caverna.
Urla contro la cieca ironia di stelle già morte in cielo.
Urla come si tende la mano agli uomini del futuro.
Era un pettirosso (ovviamente da combattimento!) chiuso in gabbia,
il poeta Mauro Macario, quando cercava la propria strada attraverso
il ventennale lavoro di regista teatrale, cinematografico e
televisivo, scartato, per troppa timidezza, da quasi subito
il mestiere d’attore a cui lo aveva avviato il padre,
l’immortale Erminio.
Non trovava parole a un canto che gli rimaneva strozzato in
gola… l’abbiamo già detto: l’uomo conosce
quel grande assente della nostra epoca mediatica che è
il pudore! E così lui, favorito dalla sorte per una strada
già aperta da un genitore attor comico famosissimo, rifuggiva
il pubblico, e non perché non avesse fiumi di parole
da confidargli, ma perché queste parole non trovavano
la strada giusta.
Fu l’incontro con Léo Ferré a sancire la
liberazione della sua poesia.
Léo non era un genio geloso del suo status, né,
peggio ancora, un guardiano del tempio della poesia, piuttosto
un liberatore.
Poche parole, ma dette al momento giusto, seppero aprire le
chiuse dell’anima e far fluire la poesia di Macario, fino
alla tipografia, fino ai teatri, fino alla strada…
Iniziò dunque così un percorso svoltosi in tre
libri esemplari:
Le ali della Jena (1990), Omicidi naturali
(1992), Cantico della resa mortale (1994).
Le ali della Jena era un esordio di
grandissima temerarietà: in un’epoca di frammenti,
di minimalismi, di navigatori per il mare dei pensieri deboli,
un artista esordisce già maturo con un poema eminentemente
politico (nel senso più alto del termine). La prefazione
a questo libro la firma Ferré, che, come dice con una
punta di civetteria lo stesso Macario, «Non regalava niente
a nessuno!».
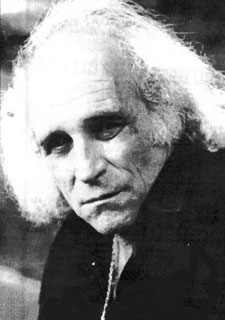
Leo Ferré
L’esordio però della Macario-lingua
è già chiarissimo: una deflagrazione d’immagini
si sporca a ogni tenzone col presente, si perde e si ritrova
in ogni anfratto della cloaca planetaria, consapevole di puntare
altissimo.
Fui deportato sul finire del secolo
In un laboratorio di sintesi organica
Per subire l’asportazione totale
E il ritrapianto dell’intero apparato
L’intervento durò anni e non riuscì.
Dunque la jena alata, una volta sorvolato il globo comincia
a riconoscersi animale, come il poeta, finalmente imbracciata
l’arma che gli è più congeniale, quella
della poesia, comincia a volgere un occhio rosso, violento microscopio
insubordinato e indagatore, ai nemici di sempre, al capitale
imperante, alla untuosa catechesi che alloppia gli spiriti,
che vuole la pace dei sensi a discapito di quella delle mine
antiuomo, e un occhio azzurro/nuvola ai compagni dispersi, ai
viaggiatori alati, a quelli che, forse annoverati fra i perdenti,
non sono ancora fra i perduti. Indiani. Anarchici. Artisti.
Omicidi Naturali, pur riportando
la forma a un flusso più controllato e meno magmatico,
è solo in apparenza una raccolta di poesie: la jena ancora
strappa dal suo taccuino fogli visionari, e li manda per il
mondo come gli aquiloni del signor Dick, il volo s’è
fatto più radente, non più dunque il panorama
completo, la foto del satellite, ma topografie interrotte per
la mappa dell’eldorado.
Ripudio la mia appartenenza
Alla tua sottospecie
Io so che vivi nel buio
Con le mani nei viscere
A macellare l’innocenza
Con l’assenso tranquillo
Di chi getta un’occhiata
Da finestre sordomute.
La sfida alla società non cessa dunque d’essere
pronunciata forte e chiara «chante, persiste e signe»
avrebbe detto Jacques Brel.
Cantico della resa mortale è,
fra questi, il libro cui sono più affezionato, forse
perché è il primo che ho letto, avendo avuto modo
d’averlo sotto gli occhi (e non ricordo nemmeno il dove)
ben prima di conoscerne l’autore, forse perché
due lunghe liriche ivi comprese stanno ai posti più alti
della mia personalissima Macario-parade: Salmo 152
e la collina del belvedere.
Approfondimento e continuazione del precedente, muove a più
impellenti richiami, a più insondabili abissi. Qui tutti
i temi esposti in precedenza si trovano ingigantiti, la sfida
s’è fatta più aspra ancora. Il grande liberatore
Ferré, la cui morte ispira il salmo che citavamo poc’anzi,
non essendo più, ha lasciato dietro di se un grande compito.
Macario se l’assume fra la lirica che apre la raccolta
e quella che la chiude; entrambe autorappresentazioni della
propria morte, la prima offre la descrizione di un’intima
resistenza umana che chiama la propria compagna alla difesa
di quelle spoglie che ripudiate vive da «un potere che
non sa amare i corpi» (mi pare lo dicesse Julian Beck
in una sua famosa poesia) vanno difese poi, dopo la fine, quando
la «lugubre processione di impiegati mistici» le
vorrebbe arruolare nei «garages pubblici dei morti»,
la seconda fa da richiamo e squillo di battaglia, sirena d’allarme
per il mondo intero, corno suonato sull’orlo di una Roncisvalle
definitiva dal poeta, nel timore d’essere infine solo
e di dissolversi nel silenzio tutt’attorno.
Oggi quei tre libri, da troppo tempo introvabili sono finalmente
ristampati dal benemerito editore friulano Campanotto (editore,
fra gli altri, di un grandissimo talento della lirica italiana
contemporanea: Anna Lamberti-Bocconi) e riuniti in un unico
volume a degli inediti che ne permettono un apprezzamento completo.
Scopriamo così che l’asperrima, esaltante visionarietà
del primo libro, ha trovato col tempo un uomo che non ha più
paura di dichiararsi teneramente innamorato degli artisti che
lo hanno via, via appassionato: Fabrizio De André, Charles
Bukowski, Lance Hensons, per non parlare ovviamente del continuo
lungo dialogo che il poeta, in maniera più o meno esplicita,
intrattiene coi suoi numi tutelari Ferré e Rimbaud.
Le profonde convinzioni libertarie restano, come la carta bianca
su cui si scrive, la premessa a tutte le opere del poeta e,
dette o non dette esplicitamente, sono ineludibili…
Non si potrà mai affrontare Macario con il bisturi di
penninchiostro dei tenutari del bordello Accademico, che in
mancanza di poeti da uccidere si danno da stra-fare a imbalsamare
quelli già morti. Macario invece vuole la passione, la
compartecipazione dei suoi gusti e disgusti. Chi lo affronta
sappia che dovrà fare i debiti conti con la lancia della
sua metafora in resta, scagliata com’è all’assalto
di mulini a vento… perché in un’epoca senz’aria
bisognerà pur difendere dalle pale dei mulini gli alisei,
bisognerà pur invocare una bora salvifica che spalanchi
le finestre delle biblioteche, scolastiche e parlamentari, e
faccia entrare finalmente un po’ d’aria.
 Alessio Lega
Alessio Lega
|

