|
Comizi d'amore
2000
È il documentario che ho girato
nel giugno di quest'anno, per ricordare i 25 anni della scomparsa
di Pier Paolo Pasolini. Più che fare qualcosa su Pasolini,
fare qualcosa da Pasolini.
Cosa è rimasto oggi della sua opera? Per quanto mi riguarda
credo che l'aspetto più interessante e moderno dell'eredità
pasoliniana stia nel richiamo continuo alla necessità
di sperimentazione, alla ricerca linguistica, al desiderio di
chi si esprime creativamente per arrivare a nuovi orizzonti.
Il senso di provocazione e la rottura con il conformismo sono
strumenti moderni e efficaci per elaborare tutto questo.
Comizi d'amore è un film inchiesta del 1963 sulla
problematica sessuale in Italia, costruito con il metodo dell'intervista,
alla quale si accompagna e spesso si sovrappone il commento
polemico e riflessivo di Pasolini. Nasce in parte dalla suggestione
"sperimentale" che Pasolini mutuò dal cinema-verità
di Jean Rouch e Edgar Morin (1961).
Il film si apre con la domanda "come nascono i bambini?"
rivolta a un gruppo di ragazzetti del sud. Le loro risposte
fantasiose e ingannevoli anticipano le convinzioni fasulle degli
italiani (in una caserma, una balera, una spiaggia della Toscana,
in treno, in campagna, in Sicilia, una piazza di Napoli), l'atteggiamento
di chi si accontenta di un'ignoranza gratuita. Pasolini discute
di volta in volta gli spezzoni dell'inchiesta con l'amico Alberto
Moravia e con lo psicanalista Cesare Musatti.
Quattro sono le sezioni dell'inchiesta:
1 - Fritto misto all'Italiana: dove si parla dell'educazione
dei figli, del gallismo, di sesso e di sentimenti e dove si
imposta un contrasto forte tra il Nord, moderno e industriale
ma ancora ingombro di rottami ideologici, e il Sud, vecchio
ma intatto nei suoi pregiudizi.
2 - Schifo o pietà: dove le domande riguardano l'anormalità
sessuale, oggetto di scandalo o di disprezzo.
3 - La vera Italia: con domande più pratiche sul divorzio
e sulla libertà degli uomini e delle donne.
4 - Dal basso e dal profondo: che riguarda la prostituzione.
All'inizio e alla fine del film è inquadrata una scena
di matrimonio, suggellata da un bacio.
Tutto il film di Pasolini (provocatorio per la natura stessa
della materia che affronta) cerca di dare una risposta ad alcune
grandi questioni :
1. La differenza tra i costumi sessuali del Nord e del Sud
2. La problematica sessuale, osservata dal punto di vista maschile
e femminile
3. Il problema dell'omosessualità
4. La prostituzione in Italia.
A queste domande, a distanza di 37 anni, ho cercato di dare
una nuova risposta, attraversando l'Italia, mantenendo la struttura
generale di "Comizi d'amore", recuperando i principali
temi che il film affrontava, le domande e possibilmente i luoghi
dove le interviste erano state realizzate.
Il mio film fissa i mille volti dell'Italia della gente comune,
dalle città alle campagne, indagando, senza nessuna "pruderie",
il loro pensiero sull'erotismo e sull'amore.
Medesime sono le domande, medesimi i luoghi di questo viaggio
che trova un senso nei volti rappresentativi della nostra penisola,
nelle differenti culture, nei diversi modi di comportamento
e di pensiero, in quell'Italia fatta di contadini e pescatori
e in ogni caso, di gente che lavora. Ho cercato di contestualizzare
la fatica e il sudore di questi volti, calandoli nei luoghi
dove vivono e lavorano, con un'attenzione particolare per gli
ambienti e per i colori che li circondano.
Facce e luoghi interagiscono, raccontandoci un'Italia fatta
di contraddizioni, di evidenti stridori, di luoghi comuni e
di grande confusione.
Il mio film si sovrappone a quello di Pasolini anche se gli
sguardi sono diversi. A distanza di quasi quarant'anni nulla
è cambiato radicalmente. Forse addirittura, il conformismo
e l'ignoranza sono aumentati.
Comizi d'amore 2000 non ha e non vuole avere basi scientifiche.
Non sono un sociologo, né un antropologo. Il mio interrogarmi
sulla sessualità non cerca statistiche né fornisce
grafici, ma cerca solo di guardare tra la gente per sondare
e fedelmente riportare l'importanza del sesso nella nostra vita.
Di risultati non ce ne sono. Certo il Sud Italia continua a
riflettere un'immagine di colore e di forza refrattaria alla
modernità ma autentica e sincera, anche nelle distorsioni.
Il Nord, più evoluto e disinibito, non riesce a cancellare
il dubbio di uno snobismo e di una superiorità per me
insopportabili e di una qual certa falsità. La vera sorpresa
è la coscienza femminile. A differenza degli uomini,
nella maggioranza frustrati e imbevuti di un maschilismo vetusto
ma dominante, la donna ne esce più matura, rispettosa,
accogliente e comprensiva. Credo che la coscienza femminile
sia la più autentica e più rivoluzionaria spinta
sociale in questi anni dominati dal conformismo e dal qualunquismo.
 Bruno Bigoni
Bruno Bigoni
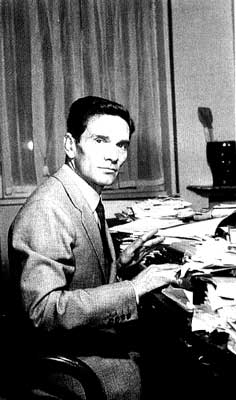
Ridere del
potere
"Falsi da ridere" è il titolo di un mio libro,
che è appena uscito per le edizioni Malatempora, la casa
editrice autonoma diretta da quel vecchio/giovane ribelle "underground"
che è Angelo Quattrocchi.
Il libro, a parte una nota introduttiva storico/autobiografica/teorica
("Giornali falsi, ma non bugiardi"), è un'antologia
di testi "falsi" apparsi - con varie firme - sia sui
nostri giornali "veri" (Il Male, Frigidaire,
Frìzzer, il Lunedì della Repubblica…)
che sui "giornali falsi" da noi distribuiti in aperta
sfida alla "Grande Comunicazione Imperiale".
I falsi de La Repubblica, del Corriere, dell'Unità,
de La Stampa, del Mattino, del Giornale di
Sicilia ecc. per l'Italia, ma anche i falsi internazionali
distribuiti clandestinamente nei paesi dell'Est, prima della
caduta di quei regimi.
Cronache "false" nelle quali tuttavia, proprio per
la libertà e l'autonomia connesse al fatto (o alla scusa)
di "raccontare il falso", abbiamo (io e altri) potuto
svelare tanti aspetti, intrighi, movimenti e mutamenti di questi
ultimi venti anni.
Così mentre Andreotti presiedeva il consiglio dei ministri
(nel '90) noi lo davamo per latitante, inseguito da un mandato
di cattura per i delitti Pecorelli e Dalla Chiesa e per essere
il referente politico nazionale della Mafia. E avevamo mandato
Craxi ad Hammamet molto prima che fosse costretto ad andarci
davvero…
Oppure quando Breznev e Suslov guidavano ancora con pugno di
ferro l'impero sovietico la nostra Pravda (del 1980)
descriveva la dissoluzione dell'impero sotto il titolo: "La
Russia ha sconfitto i dèmoni. Né Unione, né
Socialiste, né Sovietiche, solo Repubbliche".
Citazioni di "profezie" che potrebbero continuare
a lungo, ma è solo per dire che non si tratta affatto
di "profezie" in senso stretto, bensì di una
lotta contro le megabugie della Comunicazione Imperiale, che
nascondeva ieri e nasconde oggi (in modi ancor più raffinati
e perversi) la realtà dietro l'ideologia, il potere dietro
l'umanitarismo, la guerra dietro la pace, la rapina dietro lo
scambio "tra eguali".
Dunque un'antologia satirica, scritta per ridere, ma ridere
del potere, non al servizio del potere. Differenza sostanziale
e assoluta tra la satira giullaresca, che imperversa e rincoglionisce,
e la nostra satira, che è letteratura, guerriglia, interferenza
sui circuiti della falsificazione ufficiale.
 Vincenzo Sparagna
Vincenzo Sparagna
(direttore di Frigidaire)

Delitto a
Torino
Il risvolto di copertina inizia laconico: "un racconto
ricerca su un fatto di cronaca accaduto nella Torino del 1930,
che allora fece grande scalpore e che entrò e restò
per molto tempo nella memoria collettiva sotto forma di narrazioni
orali e di canzoni popolari."
In copertina: "Corso Oporto n° 51" e una foto
piccola di donna (chi?).
Il volto, di profilo a tre quarti, l'acconciatura dei capelli,
gli orecchini, la collana e quel che appare dell'abito, oltre
a un bianco e nero sapiente - vagamente sul seppia che impreziosisce
-, collocano il quadratino fotografico più o meno nel
trentennio del secolo, l'epoca in cui si colloca il fatto di
cronaca che Guido Ceronetti racconta e restituisce, costruendo
con infinita pazienza e tanta cura un collage di notizie, testimonianze,
racconti giudiziari e voci sparse, con letterine e quasi lettere
recuperate chissà come e dove, e che sembrano a momenti
non più lettere ma fantasmi di un'Italia la cui provincialità
si rivela tanto scopertamente da apparire come suscitata da
un vecchio film di quelli che la sera tardi nel periodo estivo
la nostra televisione ci propina.
La vera storia di Rosa Vercesi e della sua amica Vittoria,
edizione Einaudi, Lit. 14.000, è un libro che non ha
nulla di morboso, e oltre ad accompagnarci lentamente al cuore
della vicenda, è scrupolosamente vagliato e attento a
zone d'ombra in cui si addentra senza nessuna pretesa di definitive
certezze. Le ombre che si allungarono su questa storia nella
Torino del 1930 non sono tutte e sempre leggibili, se non da
una riga all'altra, tra una riga e l'altra di quei verbali compilati
dalla polizia fascista – polizia politica – chiamata
per un caso che di politico nulla aveva, trattandosi dell'uccisione
di una donna da parte della sua migliore amica, uccisione il
cui movente oscillava pericolosamente tra delitto passionale
e omicidio per furto.
Ecco quindi nell'affacciarsi della prima ipotesi la necessità
che gli uomini fidati del regime mettessero subito ordine nella
faccenda, riportando il tutto nello spazio sicuro del detto
e non detto, del passar sotto silenzio quanto è più
che sussurrato in una città emotivamente scossa, non
dal delitto in sé, ma da quanto lascia intravedere.
In Corso Oporto al n° 51, in un appartamento elegantemente
borghese, nell'agosto del '30 è rinvenuto il corpo senza
vita di Vittoria Nicolotti, uccisa dall'amica amante Rosa Vercesi,
che a seguito di questo sarà condannata all'ergastolo
e solo dopo trent'anni verrà graziata "dopo essersi
ravveduta".
Rosa Vercesi negherà la passionalità del delitto
(mi si perdoni il termine, ma le cronache dell'epoca e lo stesso
linguaggio dell'imputata e degli avvocati girano intorno ai
fatti con frasi tipo: "congresso contro natura").
Guido Ceronetti suggerisce in base a indizi solidi (ignorati
allora per comodo) che la Vercesi preferì l'ergastolo
certo e l'accusa di essere anche una ladra, pur di sottrarsi
alla vergogna di essere esibita pubblicamente come bisessuale
e amante di una donna libera, indipendente economicamente, viaggiatrice
in quella Parigi culla di cultura e di scandali, dove altre
donne libere si consentivano relazioni e amori tutt'altro che
nascosti con l'altra come me. La verità appare
evidente, molte canzoni e narrazioni si sbizzarriscono, ma alla
finzione si sommano le tante ombre che spostano il centro dell'accaduto
e sembrano favorire il silenzio. Storie nella storia che la
avviluppano, lasciandola lontano ma non tanto che la trama ne
sia alterata.
Pagina dopo pagina veniamo a sapere che di Vittoria non ci sono
fotografie, nessun ritratto di nessun tipo, e di Rosa solo una
foto scattata al momento del suo arresto e tanto impietosa che
Ceronetti non la inserisce. Nel cimitero maggiore di Torino
c'è una "lapidina" (dove qualcuno ha portato
un fiore) con il nome di Vittoria Nicolotti e le date 1898-1930).
Accanto anche la tomba della madre.
Nel Manuale di medicina legale dei Professori Carrara,
Romanese, Canuto, Tovo, del '38, un'anonima foto di ragazza
morta con la didascalia: "tentativo di soffocamento e strozzamento
- omicidio ..." eccetera. Su quel manuale generazioni di
studenti hanno studiato e la ragazza morta, che nessuno sapeva
più identificare, era Vittoria Nicolotti. A Torino invece
era ben conosciuta e ben voluta. Il suo negozio di abbigliamento
per bambini "La Falena" era in voga e lì si
servivano le buone famiglie torinesi. Rosa Vercesi invece trattava
vari affari, grazie a un carisma notevole, e pure dopo molti
illeciti trovava credito proprio perché personaggio inconsueto
e con un'aura di sicurezza che piaceva. Veniva da una famiglia
povera e non andava per il sottile quando si trattava di soldi
e proprio per questioni di affari incontrerà e frequenterà
Vittoria. Il caso porterà queste due vite fino al punto
di collisione e lascerà che per cinquant'anni due destini
rimangano avviluppati e appannati fino allo sprazzo di luce
che pare essere suscitato per chiudere definitivamente la loro
storia; i ricordi sono l'ostinata materia che non si dissolve
se non li si mette alla luce e la luce non viene né a
salvare né a condannare ma a permettere che l'irriconosciuto
non sovrasti e possa quindi essere memoria. Quando alla fine
della sua vita, Rosa, ormai impazzita, esce e vaga nelle campagne
evocando il nome della sorella più giovane e da lei molto
amata, l'altro nome mai più pronunciato in trent'anni,
sembra posseduta da forze che non sono che il rimosso della
sua psiche che satura di oblio sovrappone corpi e luoghi, nomi
e volti, senza più conoscerli.
 Nadia Agustoni
Nadia Agustoni
Al tamburo della"rivoluzione
nera"
Pubblicato per la prima volta nel 1977, "As serious as
your life" di Valerie Wilmer, è da pochi mesi di
nuovo in circolazione grazie a Serpent's Tail Press. (Non so
di una edizione italiana, per questa inglese: www.serpentstail.com).
Valerie Wilmer è oggi una nota giornalista musicale nonché
fotografa di origine inglese, ma agli albori degli anni '60,
spedita dal Melody Maker a New York, era una giovane innamorata
della black music. Finì per trovarsi al centro di una
intera generazione di jazzisti, passati alla storia come i fautori
del "free jazz". Diventa amica di Albert Ayler, Cecil
Taylor, Ornette Coleman, Sun Ra e mille altri, in un crocevia,
mai ripetuto se non in parte dal fenomeno Rap, di lotta politica,
coscienza sociale e fierezza culturale di cui il Free Jazz è
stato interprete centrale.
Nel 1970 Albert Ayler, forse il più lucido (e ludico)
esponente con i suoi riferimenti incrociati alla musica bandistica,
al rythm'n'blues, al gospel, viene ripescato cadavere nell'East
River. Val Wilwer si mette a scrivere e nel 1977 esce questo
"As serious as your life", tra quella manciata di
libri sul, attorno, dentro al Jazz che merita avere (citerei
"Blues People" di Le Roi Jones, "Free Jazz/Black
Power" di Carles-Comolli, "The Jazz Life" di
Nat Hentoff).
Il libro cita, nell'introduzione, Henry David Thoreau: "Se
un uomo non tiene il passo coi suoi compagni, è forse
perché è all'ascolto di un tamburo differente.
Lasciatelo marciare al ritmo che sente, qualunque sia o quantunque
distante".
Al tamburo della "rivoluzione nera" questi musicisti
hanno dato tutta la loro arte, sofferenza e orgoglio. Il libro
di Val Wilmer ne dà una testimonianza ancora oggi fortissima.
 Stefano Giaccone
Stefano Giaccone

|

