| ricordando
Colin Ward
Stati d'animo dell'anarchia
intervista (immaginaria) a Colin Ward
di Leonardo Caffo
Il pensiero anarchico, la rivista
Anarchy, l'eredità di Thoreau, il bambino al centro
dell'ambiente: sono alcuni dei temi di questa chiacchierata
mai avvenuta con l'architetto e militante anarchico inglese
(1924-2010) che ha saputo esprimere al meglio la concezione
per così dire anglosassone dell'anarchismo, equilibrata
e moderna.
Non è che ho paura di morire. Solo che non voglio
esserci quando accadrà.
Woody Allen
Colin Ward è morto a
Ipswich l'11 febbraio del 2010. Mi è capitato di incontrarlo
di recente: e nulla di strano – non stupitevi (né
spaventatevi... nessuna seduta spiritica). Gli autori come Ward
hanno avuto una funzione specifica che gli consente, almeno
a mio avviso, di parlare anche in assenza: facciamo subito un
esempio pratico così capirete dove è avvenuto
il nostro dialogo. Mi trovavo a un convegno di filosofia morale
e, come al solito, anche questa volta l'anarchia veniva utilizzata
come spauracchio di un mondo privo di etica e organizzazione.
Stanco della solita agonia, tuttavia, avendo già fatto
il mio intervento, decisi di andare via all'applauso scatenato
dalla frase “l'anarchia è disumana” –
e, arrivato nel chiostro (era l'Università Cattolica
di Milano), ecco che mi appare questa figura: sorridente come
suo solito, sigaretta accesa nella mano destra, e camicia maldestramente
abbottonata. Colin Ward, l'altra mano in tasca e sguardo sereno,
mi invita a restare un po' con lui – dopo aver compreso
la mia amarezza per quanto successo al convegno – sollecitando
la mia curiosità: finalmente potevo chiedergli tutte
quelle cose che, da sempre, avrei voluto sapere una volta chiusi
i suoi libri. E... ecco, è andata più o meno così.
Certe volte mi domando come abbiate fatto a resistere,
testimoniando attraverso le vostre riflessioni, in una società
come questa in cui è praticamente impossibile scindere
tra Stato e Società. Uso il plurale perché, ovviamente,
non penso solo a te ma anche a Noam Chomsky o a Robert Paul
Wolff (che proprio su come le università siano resistenti
all'anarchia, anche solo a livello teorico, ha scritto molto).
È tutto talmente naturalizzato, dal capitalismo al potere
dispotico, che a discutere di uno spazio politico possibile
privo di gerarchie, e addirittura confacente alla natura umana
– mentre la psicologia evoluzionistica prova a insegnare
che siamo malvagi sin da piccoli –, sembra di fare a pugni
con la nebbia. Non ti sembrava, anche quando collaboravi con
Freedom, piuttosto che quando fondasti Anarchy,
che di fronte avessi una sfida troppo grande rispetto alle reali
capacità di comprensione di coloro che potevano ascoltarvi?
«Mah... questa tua domanda mi stupisce molto perché
la risposta è secca: no. Nel mio Anarchy in Action1
del 1973, come dovresti sapere, ho argomentato proprio che l'anarchia
non è, per usare le tue parole, uno “spazio politico
possibile”, ma proprio uno spazio politico attuale. Qualcosa
che, al massimo, dobbiamo cercare di estendere e di utilizzare
come testa d'ariete contro la resistenza, coatta, del potere
gerarchico. Questo, in parte, risponde anche al senso più
generale della tua domanda: come abbiamo fatto, o almeno come
ho fatto io, a resistere in una Società in cui scrivere
contro lo Stato è considerato quasi un atto violento.
Perché risponde anche a questa questione? Perché
sapere che esistono progetti, in giro per il mondo, che da Linux
come comunità basata sul “dono”, fino ai
tentativi come quello dell'Isola delle Rose (Insulo de la Rozoj),
dimostrano che l'anarchia non solo è possibile, ma è
anche attualizzabile in varie forme, serve proprio a rendere
il nostro essere anarchici una forma di resistenza al potere
costituito. Mi spiego: se anche noi perdessimo la volontà
di testimoniare allora sarebbe, davvero, darla vinta a coloro
da cui tu oggi sei scappato. Lasciare il convegno, per esempio,
senza dire la tua – rispondendo sul punto a coloro che
sostenevano che l'anarchia è il male peggiore –
è una tua grave mancanza. Base morale del pensiero anarchico,
infatti, è che non siamo responsabili soltanto di ciò
che facciamo – ma anche di ciò che avremmo potuto
fare e abbiamo scelto coscienziosamente di non fare. Tu, in
parte, sei responsabile del fatto che oggi, molti, usciranno
da quel convegno rafforzando i loro preconcetti sull'anarchia.
Non voglio colpevolizzarti, ma invitarti a lottare per le tue
idee. C'è poi questa questione della psicologia evoluzionistica,
che dici essere colei che insegna che siamo “malvagi”
sin da piccoli, che come sai non è altro che un'estensione
del modello di Hobbes secondo cui non saremmo altro che lupi
in lotta tra loro. Anche contro questo bisogna lottare: non
basta congedare queste teorie con sufficienza.
Proprio quando fondai Anarchy, che hai citato, feci in
modo di ottenere una collaborazione tra scienziati, filosofi,
antropologi, e tante altre figure, per usare anche le nuove
acquisizioni scientifiche volte a contrastare vecchi pregiudizi.
La natura umana non è né buona né cattiva,
ma ha in sé le condizioni di possibilità per l'anarchia
più di quanto non le abbia della democrazia o della monarchia
(ci fosse qui Noam potrebbe spiegarti, sapientemente, il paragone
tra questa mia idea e la sua sul linguaggio). La barriera tra
il sé e l'altro, completamente inesistente già
a livello infantile (pensiamo agli studi di psicologi come Donald
Winnicott o Melanie Klein), è poi comunque un falso confine
– come mostrano i contemporanei studi sui neuroni specchio2.
Si tratta, come dire, di unire i due pezzi della risposta che
ti ho dato: mostrare che, non soltanto tentativi anarchici esistono
e sono ben riusciti, ma che sono anche la forma culturale migliore
per la nostra natura umana. Si tratta di lavorare sfaldando
il sistema che critichiamo dall'interno, ognuno dalla prospettiva
che meglio sente di poter perseguire.»
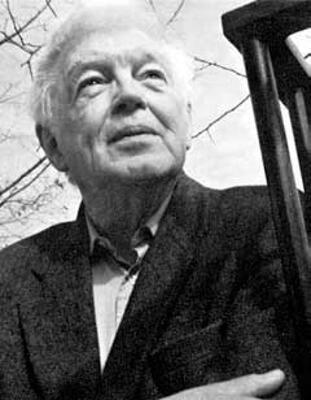 |
| Colin Ward |
L'anarchia è qui, intorno a noi
Capisco... e non c'è dubbio che il pensiero anarchico,
una volta assunto come modello per la propria vita, dovrebbe
condurre a resistere sempre alla spada di Damocle che è
la presunta vittoria di un modello d'esistenza completamente
diverso. Ma non credo di essere stato chiaro, e non voglio certo
riproporre un classico dialogo tra lo scettico e l'anarchico
come quelli su cui tu stesso hai scritto. Mettiamoci d'accordo
– qui siamo anarchici entrambi e, se io lo sono, lo devo
proprio alla gente come te che ha speso la propria vita in favore
di questa idea di libertà. Ma concedimi, lo stesso, la
domanda più banale che potrebbero farti: quali sono oggi,
a tuo avviso, le reali possibilità per l'anarchia –
non solo a livello microscopico – ma anche macroscopico?
«Ancora una volta la domanda potrebbe condurre fuori strada
– se con macroscopico ci si immagina delle cose, come
gli Stati attuali, però anarchici. Questo sarebbe un
ossimoro: la stessa organizzazione dei territori in forma geopolitica
lo è – se assumiamo una prospettiva anarchica.
Uno dei nostri antenati anarchici più chiari, su questo
punto, è sicuramente Thoreau: pensiamo al suo Camminare3,
e alla disperazione nel sapere che un giorno avremmo avuto questo
mondo – in cui intere porzioni di terra, di libera
terra, sono proibite da umani ad altri umani – in un folle
gioco al massacro. Ma dobbiamo proprio smetterla di continuare
a chiederci quali siano le reali possibilità dell'anarchia
altrimenti, consentimelo, facciamo il gioco degli stessi detrattori
dell'anarchia. L'anarchia è qui, intorno a noi, ogni
giorno: ogni volta che qualcuno fa del bene senza che gli venga
imposto da un principio esterno. Sai che l'ho definita “seme
sotto la neve” – perché basta sapersi guardare
attorno, e questa utopia è in realtà già
nascosta tra il peso del quotidiano. Noi siamo una specie cooperativa
– questo è ovvio anche nelle contingenze storiche
che più hanno condotto lontano da un ideale anarchico.
Quello che bisogna fare, sin da subito, è smetterla di
pensare se l'anarchia è possibile e invece vivere, direttamente,
delle possibilità che oggi ci vengono offerte: cooperazione
e mutuo appoggio sono la cifra del pensiero anarchico ma si
ottengono solo attraverso il ricorso all'azione diretta che
va organizzata in modo libero. La mia idea è: se l'anarchia
è un seme sotto la neve ciò che bisogna fare è
far crescere questo seme e fargli strada. Il resto verrà
da sé.»
Sì ma tu stesso hai speso diverse energie per sostenere
che, affinché questo seme si faccia strada, le cose vadano
accompagnate da processi specifici. Mi riferisco soprattutto,
nel tuo caso, all'organizzazione degli spazi anche in senso
architettonico. L'idea che architettura e potere siano intrinsecamente
legate – e che anche per le generazioni che rappresentano
la vita che verrà, dunque, la città vada ripensata
dalle fondamenta4 – attraversa
tutti i tuoi scritti...
«Sì, questo è un aspetto importante della
mia teoria che non voglio venga trascurato – e non, come
dire, solo perché sono stato principalmente un urbanista.
Piuttosto perché la vita architettonica rappresenta il
mondo-ambiente dell'umano: noi costruiamo sulla base dell'idea
di mondo sociale che abbiamo e, come un cerchio che trova la
sua unità, viviamo ed esperiamo il mondo sociale sulla
base delle costruzioni che ci circondano. Il motivo per cui
ho messo “il bambino” al centro delle mie critiche
anarchiche è che è nella sua essenza rendere espliciti
certi principi morali a passeggio per le nostre città.
Divulgare anarchia tra costruzioni come le carceri o i macelli,
piuttosto che in città che assumono sempre più
la struttura di un immenso Panopticon, è davvero complesso
– per questo ripensare il nostro modello di vita significa
anche ripensare gli spazi che costruiamo e in cui, ovviamente,
questo stesso modello dovrebbe svilupparsi. Che potere e architettura
si incrocino di continuo è ovvio – pensa a come
W.G. Sebald ha raccontato nel suo Storia naturale della distruzione5
il tentativo, architettonico, di rimuovere dalla Germania post-bellica
il concetto di colpa (per la Shoah) anche a livello urbanistico.
La mia idea è la città debba essere uno spazio
che estende i principi della natura umana di cui ti ho detto:
luogo dove bambini e adulti socializzano e scoprono nuovi modelli
di esistenza e sopravvivenza – “perché nessuna
città è governabile se i cittadini non la sentono
propria”.»
Senti... io rientro al convegno, e proverò a intervenire
sul punto. Quale che sia il risultato, avrò fatto spazio
sotto la neve a quel seme meraviglioso.
«Sì... rientra. Ma l'importante è fare tesoro
di ciò che ci siamo detti: l'anarchia è qui, in
mezzo a noi, ed è estensione della natura umana che deve
trovare compimento anche in quella che, voi filosofi, chiamate
“ontologia sociale”. L'architettura, come pratica
di vita, è il compimento ultimo di questo percorso. Quale
che sia, oggi, lo spazio che riuscirai a fare a quel seme –
l'azione diretta, tua e di ogni altro, rimane comunque qualcosa
di necessario. E consentimi di concludere con un verso di Giacomo
Leopardi, che dice tutto ciò che ci siamo detti, e anche
il resto che ancora potevamo dirci, prima che io torni a oziare
tra coloro che vi faranno da punto di partenza per le vostre
sfide, analisi e battaglie future:
Sempre i codardi, e l'alme
Ingenerose, abbiette
Ebbi in dispregio.»
Leonardo Caffo
Note
- C. Ward, Anarchia come organizzazione, Antistato, Milano
1976 e ried. Elèuthera, Milano 2006.
- G. Rizzolatti, C. Sinigaglia, So quel che fai: il cervello
che agisce e i neuroni specchio, Raffaello Cortina Milano
2006.
- H.D. Thoreau, Camminare, Se, Milano 1999.
- Cfr. C. Ward, Il bambino e la città, Ancora
del Mediterraneo, Napoli 2000.
- W.G. Sebald, Storia naturale della distruzione, Adelphi,
Milano 2004.
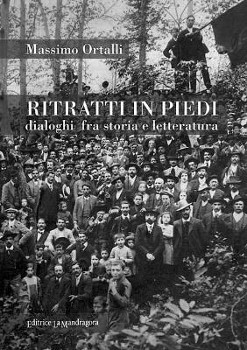 Ritratti
in piedi Ritratti
in piedi
dialoghi fra storia e letteratura
Questo
libro raccoglie i quaranta Ritratti in piedi apparsi
sulla nostra rivista tra il 2001 e il 2009.
In
ciascuno di essi Massimo Ortalli propone al lettore una
scelta di testi letterari affiancandovi documenti d'epoca
tratti dalla pubblicistica o da fonti d'archivio.
Il volume, 572 pagine con illustrazioni e indice dei nomi,
va richiesto direttamente all'autore.
Massimo Ortalli, via Emilia 216, 40026 Imola (Bo). Cellulare
348 7445927.
Una copia costa € 22,00 (invece dei 32,00 di copertina),
spese di spedizione comprese.
Pagamenti: bonifico bancario, intestato a Massimo Ortalli,
IBAN IT 49 G05080 21012 CC 120000075, Bic/Swift IMCOIT2AXXX.
|
|

