cultura
 “Il
Vangelo
che medito” Sono passati vent'anni dall'incidente stradale in cui Padre
Ernesto Balducci ha perso la vita, e le sue parole, i suoi scritti,
la sua testimonianza di fede (e di uomo) non smettono di chiamarci
in causa ed interpellarci. Questo frate scolopio, nato sui monti
dell'Amiata, in un paese di minatori - Santa Sofia - può
essere considerato a buon diritto un “gigante” del
pensiero cristiano del Novecento e un insuperabile comunicatore.
Da giovane si mosse nella Firenze dei La Pira e dei don Milani
e fece del magistero del Concilio Vaticano II il crinale di
una fede sempre pronta ad interloquire con la cultura e la politica.
La casa editrice Chiarelettere ha raccolto gli interventi di
Padre Balducci nel volumetto Siate ragionevoli chiedete l'impossibile
(Chiarelettere, 2012, pagg. 156, Ä 7,00): un bel pugno
di articoli usciti su diverse testate (L'Unità, Il Sole
24 ore, Il Secolo XIX...) in un arco di tempo che va dagli anni
ottanta a qualche settimana prima della sua tragica morte.
Diviso per tematiche in undici capitoli, con la prefazione di
Don Andrea Gallo, il volume riporta la parola di Padre Balducci,
che ci viene incontro con la forza di una rivelazione. Per il
frate - che vestiva abiti laici - era fondamentale la necessità
che il Cristianesimo, ormai screditato, soccombesse del tutto,
in modo da poter ritrovare un'altra “fecondità
sorgiva”, rintracciabile solo nel fermento e nello slancio
del Vangelo: “Non voglio che si diffonda il Cristianesimo
che io conosco. Voglio che si diffonda il Vangelo che io medito,
che è un'altra cosa”. Severo con la sua Chiesa,
cerca invece di farsi portavoce dei dannati e degli ultimi,
perché “non si può parlare a nome di Cristo
senza condividere la vita dei diseredati”. Non risparmia
critiche nemmeno a Papa Wojtyla, reo di non aver saputo prendere
una posizione netta e inequivocabile contro guerre e conflitti,
come invece suggerirebbero alcuni pronunciamenti pontifici quali
“Pacem in Terris”. Secondo il nostro tutte le religioni,
per ritrovare la propria indole, devono rinnovarsi, abbandonare
le loro certezze e sapersi confrontare con “l'asse orizzontale
del futuro dell'uomo”. E di futuro Balducci parla anche
quando incrocia il tema del disagio giovanile o della ricerca
del facile benessere, del razzismo o della politica, che come
la fede ha per molti versi tradito il suo progetto di speranza.
Perché gli uomini possano rimettersi in cammino e aprire
nuovi squarci di orizzonte il frate non sa indicare che una
strada: quella che porta a cercare l'impossibile perché
- secondo lui - solo così si raggiunge il possibile.
 Mimmo Mastrangelo
Mimmo Mastrangelo
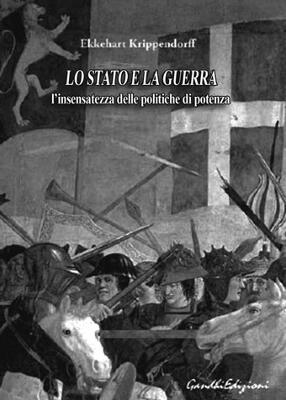 È
nato prima lo stato
o la guerra? È possibile che un libro scritto quasi trent'anni fa,
in piena guerra fredda, sia ancora oggi attuale? Sì,
se parliamo del testo Lo stato e la guerra. L'insensatezza
delle politiche di potenza (Gandhi Edizioni, Pisa, 2008,
pagg. 352, € 30,00) dello storico tedesco Ekkehart Krippendorff,
che in esso ricostruisce la genealogia dei legami tra eserciti,
stati e guerre, attraverso un'analisi storico-politica che parte
dall'antichità e arriva agli anni '80 del '900, passando
per l'epoca medioevale. “Sono così arrivato necessariamente
al vero oggetto della questione sulla guerra (corsivo
dell'autore), vale a dire il potere nato dalla violenza e tutelato
militarmente, con il monopolio dell'uso della forza, lo stato”1.
Questa è la conclusione finale dell'autore, il quale
pur non partendo da una prospettiva di ricerca anarchica, approda
ad essa nel corso del suo lavoro.
Krippendorff, avvalendosi non solo delle sue competenze di storico
ma utilizzando anche le riflessioni di letterati e filosofi,
tra cui Tolstoj, Nietzsche e Goethe, sostiene la tesi per cui
l'esistenza degli Stati, ma più in generale di ogni forma
di dominio politico strutturale e permanente, dipende dalla
presenza di forze militari istituzionalizzate, e non viceversa.
L'atto di violenza originaria insomma, genera gerarchia e dominio,
che a loro volta rigenerano sé stesse attraverso la guerra
e le svariate forme che essa assume.
E se queste considerazioni sono ovvie per molti libertari e
anarchici, non è invece di poco conto che questa prospettiva
entri a far parte del dibattito “accademico” delle
relazioni internazionali, solitamente imbevute di realpolitik
hegeliana-weberiana. Ma torniamo al libro.
Nei primi capitoli, incentrati sul XIX e sul XX secolo, vengono
analizzate la politica di potenza e la ragion di stato, interpretate
come politiche astratte, senza fini definiti o precisi, o peggio
con fini di conquista, realizzate continuamente a discapito
della popolazione. E a tal proposito, sebbene Krippendorff prediliga
una analisi strutturalista, viene pure evidenziato l'ordine
simbolico e culturale che le sorregge e reifica.
Successivamente l'autore si sofferma sul ruolo delle forze armate
in alcuni dei principali momenti di cambiamento politico dello
scenario internazionale dell'epoca moderna: la rivoluzione statunitense
e quella russa. In esse ravvisa come le forze armate, da rivoluzionarie
che erano per pratiche e idee, diventino reazionarie e repressive
quando le briglie dello stato le fagocitano e le istituzionalizzano,
attraverso un complesso procedimento giuridico-istituzionale
e culturale, che ne svilisce lo slancio sociale di liberazione.
I capitoli seguenti procedendo a ritroso nella storia, considerano
lo stesso tipo di dinamiche, calate in contesti antecedenti:
l'impero romano, il medioevo e il periodo successivo all'accordo
di Westfalia. Viene ricostruita quindi, con le debite differenze
inerenti ai vari momenti storici, l'evoluzione della violenza
da affare privato da vendere al miglior offerente (si pensi
ai mercenari, ai lanzichenecchi, etc.) a violenza statalizzata
al servizio dei governi.
Per chiudere, non si può non sottolineare la fervida
ironia, ai limiti del sarcasmo, con cui l'autore ricostruisce,
nel corso delle quasi 400 pagine del libro, l'idiozia e la ridicolaggine
di alcuni personaggi e momenti storici ritenuti “intoccabili
e mitici” dalla storiografia classica delle relazioni
internazionali. Da Bismarck, che giudica le persone secondo
la reazione del suo cane, alla sgangherata banda della Mano
Nera, che riuscì ad uccidere l'arciduca Francesco Ferdinando
dopo mille buffe disavventure: finalmente abbiamo una storiografia
che smonta la pretesa grandezza e ragionevolezza della ragion
di stato e della politica estera di potenza. Un valore aggiunto
insomma per un libro che si presenta come un classico del pensiero
pacifista e che si caratterizza per il tentativo di detronizzare
la storia internazionale per come ce l'hanno raccontata sino
ad ora.
 Tommaso Regazzo
Tommaso Regazzo
1. Ekkehart Krippendorff, Lo
stato e la guerra. L'insensatezza delle politiche di potenza,
Gandhi Edizioni, Pisa, 2008, pp. 19, 20.
La presenza libertaria dentro i
sindacati “ufficiali”
“Uno dei fenomeni che si verificano durante le più
acute crisi storiche, nel campo intellettuale, è il ritorno
agli autori del passato, specialmente ad alcuni che nei momenti
di quiete erano più trascurati e dimenticati...”
(Luigi Fabbri)
Prima ancora di leggere l'interessante volume di Giorgio Sacchetti
Lavoro, democrazia, autogestione. Correnti libertarie nel
sindacalismo italiano (1944-1969) (Aracne Editrice, Roma,
2012, pagg. 376, € 21,00) ho pensato che ci è voluto
del coraggio nell'affrontare non la ricostruzione di una fase
“alta” della lotta di classe e del movimento libertario,
ma la disamina di una deriva difficile e complicata, come difficili
e complicate sono sempre le vicende di correnti rivoluzionarie
in un'epoca di controrivoluzione o, se si preferisce, di rivoluzione
capitalistica dall'alto.
Eppure, proprio la scelta di studiare l'azione di coloro che
“contre vents et marées” hanno tentato di
mantenere viva una presenza libertaria nel movimento di classe
costituisce il fascino del libro e, almeno per me, il principale
motivo di interesse che lo caratterizza.
Su quest'epoca, la recente edizione del bel libro di Gaetano
e Giovanna Gervasio Un operaio semplice. Storia di un sindacalista
rivoluzionario anarchico (1886-1964) (edizioni Zero in Condotta,
Milano, 2012) ha fornito un materiale di grande interesse documentario
e, non a caso, lo stesso Giorgio Sacchetti lo utilizza per la
sua ricostruzione.
Credo che una disamina dettagliata di molteplici percorsi ed
esperienze quale quella che Giorgio ci propone meriti una lettura
attenta. Da parte mia, porrò l'accento su un aspetto
del libro che ritengo non solo importante ma in qualche misura
singolarmente e, lo ammetto, preoccupantemente, attuale.
Il libro, come si è detto, ricostruisce l'attività
e il dibattito di compagni impegnanti nel movimento operaio
in anni difficili. In particolare rende conto di due scelte
- mi rendo conto che opero una semplificazione, ma ritengo sia
accettabile. La prima è quella dei compagni che ritennero
possibile la ricostituzione dell'Unione Sindacale Italiana,
e cioè di un sindacato esplicitamente rivoluzionario
e libertario; la seconda è quella dei compagni che ritennero
fosse più praticabile - e più adeguata alla situazione
- la scelta di operare come componente autonoma - ma necessariamente
di estrema minoranza - dapprima nella CGIL “unitaria”
e in seguito, dopo la scissione ad opera di CISL e UIL, nella
CGIL egemonizzata da PCI e PSI.
Entrambe le scelte, come è noto, si esaurirono senza
pervenire a significativi risultati, al punto che, quando negli
anni '60 del secolo scorso il conflitto industriale riprese
vigore, non vi era una corrente operaia libertaria degna di
nota e i compagni che entrarono allora in campo - chi scrive
è fra questi - dovettero in qualche misura “ripartire
dalle aste”.
Si potrebbe sostenere, e gli amanti delle polemiche ad estenuazione
lo hanno sovente fatto, che se “tutti” i compagni
avessero fatto una scelta o l'altra i risultati sarebbero stati
significativamente diversi e che, di conseguenza, vi fu una
carenza della soggettività anarchica o meglio della soggettività
degli anarchici che fecero la scelta “sbagliata”.
Per parte mia, ritengo che porre l'accento su “errori”
degli uni o degli altri non porti da nessuna parte, e anzi conduca
a perdere di vista le effettive ragioni di quanto è avvenuto
che, schematizzando, sono a mio avviso tre.
In primo luogo il fatto che, dopo la seconda guerra mondiale
e la sconfitta della rivoluzione spagnola, si era in un'epoca
di rilancio del capitalismo occidentale, l'età d'oro
del capitalismo per un verso e dall'altro di egemonia sui settori
marginali del movimento operaio occidentale, quale quella operata
dallo stalinisno in Italia.
In seconda istanza, come lo stesso libro rileva bene, in questa
fase non si formano nuove generazioni rivoluzionarie. I quadri
storici sindacalisti libertari, per lo più uomini di
grandissima capacità, generosità, sincerità
- penso, per fare un altro esempio oltre a quello di Giovanni
Gervasio, ad Attilio Sassi, sul quale si può leggere
l'eccellente libro di Tomaso Marabini, dello stesso Giorgio
Sacchetti e di Roberto Zani Attilio Sassi detto bestione.
Autobiografia di un sindacalista libertario (edizioni Zero
in Condotta, Milano, 2008) - sono troppo spesso aquile solitarie,
circondate dalla stima dei militanti sindacali anche di altro
orientamento, ma privi di un'area politico/sindacale di riferimento
in grado di dare loro sostegno e, soprattutto, prospettive nel
medio lungo periodo.
Infine, pur rendendomi conto che con questa affermazione urterò
qualche suscettibilità, ritengo che per molti abbia pesato
il rifiuto, o se vogliamo la difficoltà, a ripensare
categorie interpretative, forme di azione, modalità organizzative
a fronte di relazioni sociali capitalistiche che, piacesse o
meno, disegnavano scenari nuovi che non potevano essere semplicemente
rifiutati, almeno da parte di chi voleva stare in campo aperto.
Se dovessi citare un libro - peraltro di gradevolissima lettura,
come altri del medesimo autore - indicherei Mezzo secolo
di anarchia (1898-1945) di Armando Borghi (Edizioni Scientifiche
Italiane, Napoli, 1954). Non credo che una diversa attitudine
avrebbe dato frutti straordinari ma certo a molti la salvaguardia
dell'identità e della tradizione parve il primo se non
l'unico obiettivo meritevole di perseguimento.
Oggi, a mio avviso, sembra che alcune delle domande e delle
contraddizioni che percorrono il libro di Sacchetti siano perfettamente
attuali e a maggior ragione dialogare, attraverso questo volume,
con i compagni nostri di allora è esercizio utilissimo.
 Cosimo Scarinzi
Cosimo Scarinzi
|

