
Appunti di viaggio
Ci sono sempre state due Americhe, che non si
parlano e non si amano. Da una parte chi vive sulla costa, dall'altra
la gente dell'interno. Più aperti i primi, tradizionalisti
gli altri. È una delle chiavi possibili per comprendere
qualcosa degli Stati Uniti. Una, appunto.
Vengo dall'Alabama col banjo sul ginocchio.
vado in Louisiana ad incontrare l'amata.
Oh! Susanna, non piangere per me,
vengo dall'Alabama col banjo sul ginocchio.
(da Oh! Susanna, Steven Foster, 1848)
Il ritornello di Oh! Susanna, chissà perché,
l'ho imparato da bambino, ma solo pochi anni fa ho scoperto
che quell'allegra canzone, molto famosa ai suoi tempi, è
folle, macabra e razzista, un nonsense a ritmo di polka che
mette in rima assurdi paradossi, mentre il protagonista uccide
con indifferenza ben cinquecento “negri”1
lungo il cammino che lo conduce dall'amata. Quando mi lascio
New York alle spalle per macinare chilometri lungo autostrade
monotone, il ritmo di quel motivetto mi accompagna in segreto,
perché il nonsense può essere una chiave di lettura
di questo paese. Guidati dai suoni metallici e vagamente sgradevoli
del banjo si può percorrere meditabondi l'ovest sconfinato
o andare imbronciati verso sud, fino in Louisiana, dove certamente
non è mai esistita alcuna Susanna a lavorare nei campi
e gli schiavi cantavano ben altre canzoni, tormentati dalle
fruste dei sovrintendenti.
Il ritmo interiore del mio viaggio, insomma, è falsa
allegria in terra rubata. Parto dalla costa orientale per cercare
di capire. Trattengo il fiato, mi guardo attorno, nascondo il
malumore. Passo per queste terre con l'animo di un apache, silenzioso
e malinconico in sella al suo cavallo.
Sessant'anni fa John Steinbeck fece lo stesso. Emulo Don Chisciotte,
ribattezzò Rocinante2
il camper costruito nel giardino di casa, partì in compagnia
del suo barboncino Charley e percorse 10.000 miglia, attraverso
l'America. Pubblicò le memorie di quel viaggio in un
libro forse poco noto ma ricco di osservazioni argute.3
Lungo la strada incontrò persone strane, curiose, solitarie.
Vide con occhi inquieti lo sviluppo del dopoguerra, l'avanzare
del consumismo, l'inaridirsi dei rapporti umani. Testimoniò
il razzismo, onnipresente negli stati del sud, e raccontò
di strana gente sradicata, che viveva in case mobili e si spostava
di frequente a caccia di futuro, senza mai avere un indirizzo
né un passato.
Sono racconti che hanno la mia età, immagini che cerco
di mettere a confronto con quel che incontro oggi negli stessi
luoghi che anche lui percorse e mi viene da concludere che,
forse, nel profondo, l'America non è troppo mutata da
allora. Ma io non ho Rocinante e il ritmo delle mie incursioni
è troppo spezzettato nel tempo. Gli appunti di viaggio
ne soffrono, si mischiano, si sovrappongono. Lo scrittore osservava
il suo paese, io lo guardo da straniero. Le note sui miei diari
sono solo frammenti di un discorso, per un amore mai sbocciato.
Non posso che restituire qualche fotogramma, neanche troppo
nitido.
Se si parte dalla Grande Mela...
“Ci sono sempre state almeno due Americhe, che non si
parlano e non si amano”. Peter mi ha messo in guardia
fin dalla prima volta che gli ho raccontato dei miei progetti
on the road. Secondo lui il paese si divide fra chi vive
sulle coste e chi all'interno: gli abitanti delle due sponde
sarebbero più liberali, aperti, tolleranti, moderni,
tutti gli altri sarebbero invece fermi al medioevo, conservatori,
bigotti, arretrati. La guerra civile poi avrebbe lasciato una
ferita che non si è più rimarginata. Peter è
gay e in posti come l'Alabama e il Montana lui e il marito hanno
avuto problemi, subito discriminazioni. Anche John e Mariel,
lui bianco, lei nerissima, mi hanno raccontato dell'ostilità
trovata come coppia “mista” in Louisiana. Secondo
questi amici, dunque, non vale la pena esplorare e non c'è
davvero niente da capire, perché l'America è sempre
la stessa, con San Francisco e New York accoglienti, inclusive,
multietniche; e un'infinita serie di altri luoghi dove ancora
oggi prevalgono diffidenza, razzismo, gretto provincialismo.
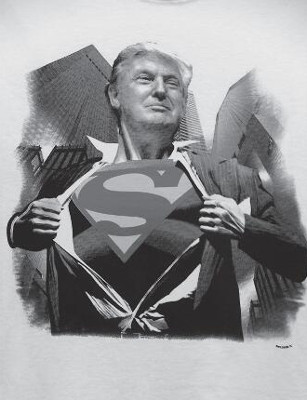 Per
chi si muove per gli States partendo da New York, la sensazione
più forte è che fuori dalla Grande Mela la storia
si sia fermata. Si viaggia per cinquanta chilometri a nord di
Manhattan e si passano paesini vecchi, tristi, decadenti, che
paiono immobili nel tempo. Si arriva in Virginia e ci si ritrova
subito in un'atmosfera da Via col vento, con le donne
nere a servire nelle cucine dei ristoranti e nelle case dei
bianchi mentre le bandiere sudiste sventolano dai pennoni. Si
percorrono i campi coltivati del Missouri o i deserti del Nevada
e ci si ritrova calati in un film americano, coi centri abitati
deprimenti, lontani da tutto, i poveri che vivono ai margini,
negli accampamenti di roulotte e caravan e i paesani che nella
vita non hanno mai lasciato nemmeno la contea dove sono nati,4
sono irrimediabilmente gretti e provinciali, nulla sanno del
mondo e sono convinti che la loro esistenza, trascinata tra
il supermercato e il pub, sia la sola possibile, l'unica degna
di essere vissuta, quella cui tutti al mondo dovrebbero aspirare.
Se guardano i notiziari vedono gli odiati pellerossa
in tutti i popoli contro cui l'America combatte. Per
chi si muove per gli States partendo da New York, la sensazione
più forte è che fuori dalla Grande Mela la storia
si sia fermata. Si viaggia per cinquanta chilometri a nord di
Manhattan e si passano paesini vecchi, tristi, decadenti, che
paiono immobili nel tempo. Si arriva in Virginia e ci si ritrova
subito in un'atmosfera da Via col vento, con le donne
nere a servire nelle cucine dei ristoranti e nelle case dei
bianchi mentre le bandiere sudiste sventolano dai pennoni. Si
percorrono i campi coltivati del Missouri o i deserti del Nevada
e ci si ritrova calati in un film americano, coi centri abitati
deprimenti, lontani da tutto, i poveri che vivono ai margini,
negli accampamenti di roulotte e caravan e i paesani che nella
vita non hanno mai lasciato nemmeno la contea dove sono nati,4
sono irrimediabilmente gretti e provinciali, nulla sanno del
mondo e sono convinti che la loro esistenza, trascinata tra
il supermercato e il pub, sia la sola possibile, l'unica degna
di essere vissuta, quella cui tutti al mondo dovrebbero aspirare.
Se guardano i notiziari vedono gli odiati pellerossa
in tutti i popoli contro cui l'America combatte.
Soste brevi, partenze frettolose
Per ogni dove negli States s'incontra uno strano altrove, dove
essere armati è norma che non si discute, le caffetterie
hanno le pistole nelle bacheche e si comprano i fucili per tempo,
da regalare ai figli ormai adolescenti nella notte di Betlemme.
“Ama i nemici ma tieni sempre ben oliato il fucile”,
è la targa blasfema che ho visto attaccata su più
di una porta girando per il sud degli Stati Uniti: sii sempre
pronto a uccidere il viandante che bussa alla tua porta. Sembra
riassumere la filosofia di un paese congelato nei suoi miti,
dove la religione è fatta a misura della presunzione
americana di essere la nuova terra promessa da Dio all'uomo
occidentale.
Ovunque infatti le chiese di tutte le possibili denominazioni
punteggiano di bianco i paesi dalle strade deserte e si riempiono
di fedeli alla domenica. Qui la scrittura la si legge ancora
con enfasi profetica, i sermoni apocalittici sono il pane quotidiano
e dai pulpiti si condanna volentieri al fuoco eterno. Ma subito
fuori da ogni tempio la salvezza si impregna di strana cultura
americana, quasi fosse un bene da comprare al supermercato,
e nelle bacheche sistemate a beneficio dei passanti davanti
alle chiese si possono leggere frasi sorprendenti, da Jesus
paid it all a God bless the US Army.5
Le mie soste sono brevi e le partenze frettolose. La borsa non
è mai disfatta. Se mi fermassi più di tanto in
uno di questi paesini la malinconia finirebbe per appiccicarsi
alla pelle. L'urgenza di scappare allora mi assale, la voglia
di andare lontano per salvarmi dalla tristezza e dissolvere
la bruma che sento formarsi dentro al petto.
Ma nei lunghi spostamenti ho dovuto spesso capitolare di fronte
al dominio incontrastato delle grandi catene di fast food, dove
per forza devi fermarti se non vuoi morire di fame lungo il
tragitto o avventurarti per le campagne in cerca di un'improbabile
alternativa. In quelle aree di sosta si può comprare
e consumare senza nemmeno scendere dall'automobile. Solo i bisogni
fisiologici costringono i viaggiatori ad abbandonare l'abitacolo,
con la pressante urgenza di chi ha bevuto litri di bevande gassate
e caffè annacquato. Le file silenziose agli orinatoi,
col ronzio dei ventilatori, restano l'unica vicinanza umana
che mi spetta in queste migrazioni.
In giro per il paese si rende testimonianza stupefatta di un
consumismo esasperato, becero e sprecone, di un mangiare smodato
a tutte le ore e di una sconcertante obesità. Restano
tracce evidenti nei cumuli osceni di contenitori di polistirolo
e bicchieri di plastica, l'atto di accusa ad ogni pasto consumato.
Steinbeck aveva annotato con preoccupazione come il paese stesse
riempiendosi anzitempo di rifiuti. Aveva compreso già
allora la portata di quel fenomeno. Non arrivò a immaginare
che gli Stati Uniti sarebbero diventati una minaccia per la
sopravvivenza stessa del pianeta inquinando il mondo, procapite,
più di ogni altro popolo, ma aveva intuito le conseguenze
estetiche della cultura di massa che stava prendendo piede allora,
del capitalismo indifferente alle sorti dell'ambiente. In Francia
e in Italia lo scrittore aveva ammirato l'antica sapienza dei
cuochi, la passione che mettevano nel lavoro. Tornato nel suo
paese, aveva osservato come qui i processi industriali stessero
sostituendo le mani e il cuore. Aveva constatato come, persino
nelle zone rurali, i suoi concittadini, corrotti dalla pubblicità,
preferissero ormai cibi già pronti, liofilizzati rinvenuti,
mescolati, riscaldati e distribuiti da tristi macchinette. Lo
aveva sconcertato la nuova abitudine di far uso di contenitori
usa e getta che, a milioni, stavano riempiendo il paese.
|
| Stato
del Delaware (USA), magliette in vendita in
un negozio: “Come si inginocchiano gli americani” |
Allarme nativi
Ovunque oggi si ha l'impressione che, da allora, più
nessuno si sia più posto il problema. Ad ogni pasto i
tavolini sembrano il campo di battaglia di una guerra infinita
contro l'ambiente. Milioni e milioni di onesti individui ogni
giorno non sembrano preoccuparsi di dove tutto questo materiale
vada a finire. Dalla colazione del mattino il senso di colpa
del viaggiatore inquinante non mi lascia mai. Quando guardo
attorno a me i miseri resti, abbandonati al loro destino da
questi emuli Gargantua, mi chiedo come possa essere che qualcuno
ancora ammiri l'insostenibile e poco desiderabile modello di
vita statunitense, questo sogno americano naufragato in un mare
di rifiuti, cibo malsano, appetiti smodati, alienazioni, solitudini,
povertà, indifferenza, razzismo e televisione spazzatura.
Un modello di vita che ha portato all'obesità come drammatica
questione sociale ed emergenza medica nazionale che appare al
viandante come un'epidemia inarrestabile.
L'incipit di un articolo specialistico sulla questione scopiazza
volutamente i titoli dei film di fantascienza degli anni cinquanta:
“L'invasione dei cibi ultra-processati”.6
Tutti i medici e gli specialisti con cui ho parlato confermano
l'allarme sociale, l'emergenza sanitaria permanente in cui vive
il paese in conseguenza della cattiva alimentazione. Ma i profitti
dell'industria hanno la precedenza sui moniti degli scienziati
e poi, in fondo, anche la sanità qui non è che
un business e le conseguenze di quest'epidemia sono un affare
per le compagnie assicurative. Intanto, chi odia l'America,
non ha che da attendere: i suoi figli si stanno uccidendo da
soli, tossicomani di zuccheri, sali e ormoni di cui sono avvelenati
i loro cibi. L'ecatombe dei ricchi che si suicidano di calorie,
mentre altrove si muore di fame autentica, sembra una strana
parabola moderna. Fuggire di villaggio in villaggio non serve,
ovunque s'incontrano i misteriosi, enormi alieni, che si aggirano
sudati fra i locali a caccia di cibo. Un incubo da cui è
impossibile svegliarsi.
Girando per gli States mi sono anche imbattuto, inevitabilmente,
in quel che resta dei nativi: hopi, navajo, sioux, cheyenne.
Il battesimo è stato in una cittadina della Virginia,
ai margini di una piccola riserva Cherokee. Mi ha colpito trovare,
arrivando, il Bureau degli Affari Indiani.7
Sapevo dell'esistenza di questo ente governativo dai fumetti
che leggevo da ragazzo, ma immaginavo fosse una vestigia del
passato. Invece la burocrazia bianca gestisce ancora le vite
dei nativi.
In realtà, in quella zona, di indiani ce ne sono ben
pochi: verso la metà dell'800 furono quasi tutti sterminati
e i reduci deportati, costretti a una lunga marcia in condizioni
terrificanti, per raggiungere i territori loro assegnati in
Arkansas. In quattromila morirono di stenti e freddo lungo il
cammino, in maggioranza vecchi e bambini. Ancora oggi quella
pulizia etnica è ricordata dai nativi come il “sentiero
delle lacrime”. Nella riserva sopravvivono oggi i pronipoti
di una sessantina di famiglie che resistettero alla cacciata
rifugiandosi sulle montagne circostanti.
In considerazione di questa tristissima e crudele storia, colpisce
constatare che la cittadina, oggi, vive dei proventi di un'industria
del turismo, gestita dai bianchi, che sfrutta gli stereotipi
sui nativi imposti dai film western. Impazzano i negozi di souvenir,
arredati con finti totem e corna di bufalo, che espongono paccottiglia
per turisti, dai mocassini ai copricapo piumati che, peraltro,
sono patrimonio di altre culture e che i Cherokee non usarono
mai. Pub e ristoranti hanno arredamenti in stile e nomi esotici
come PowWow, TeePee, Kacinah e Calumet. Si può persino
visitare un villaggio “tradizionale”, con veri indiani
pagati dall'assistenza pubblica per recitare la parte di finti
indiani. Tutta la scenografia di quel paese mi ha riempito di
amarezza. Nelle capigliature posticce in vendita mi sembrava
fossero rimasti intrappolati tutti i sogni di libertà
di questo paese. Mi sono presto lasciato alle spalle le ultime
vestigia di quel popolo e ho ripreso la strada di casa.
|
| “Patriota
americano, proprietario di una pistola”,
“Questa famiglia protegge la mia famiglia” |
|
Ma molte culture precolombiane...
Durante quel viaggio, alla sera, rileggevo alcune pagine di Eduardo Galeano, lo scrittore uruguayano che, negli anni settanta, mi aveva aperto gli occhi su colonialismo e imperialismo, raccontati dalla parte degli sfruttati. Per una strana coincidenza, Galeano lasciò questo mondo proprio il giorno in cui rimisi piede a New York. La tristezza mi avvolse, il fatto mi turbò. Mi sembrò un presagio, che non sapevo come interpretare.
Nella sua monumentale “Memoria del fuoco”,8 basata su anni di studio delle culture amerindie, Galeano sosteneva che, per superare il capitalismo e costruire un modello di società più appagante, sarebbe stato necessario recuperare molti aspetti della vita e filosofia di alcuni dei popoli indigeni annientati dal genocidio. Dalle sue ricerche concludeva che molte culture precolombiane praticavano modelli di vita comunitaria molto avanzati, erano egalitarie, ponevano le donne sullo stesso piano degli uomini, lavoravano solo quel tanto che basta per vivere, non perseguitavano gli omosessuali, non davano importanza alla verginità ed erano sessualmente libere e disinibite, davano spazio al gioco e avevano una profonda spiritualità, legata al culto della terra madre e nutrice.
Tornando a New York decisi di onorare il ricordo di Galeano studiando a fondo quell'opera, per combattere la tristezza che avevo incontrato per le strade del sud. Ma New York ti cattura, consuma il tempo e la voglia e quando percorri il piccolo inferno di Times Square, fendendo la folla che vaga senza meta, coi grattacieli trasformati in mega schermi che brillano giorno e notte e i turisti incantati a guardare sorridenti e felici quelle luci fantastiche e inutili, capisci che questa civiltà ha seppellito l'altra per sempre. La madre terra è stata strappata agli antichi abitanti da troppo tempo e quelle culture sono solo ombre, appena un accenno nella luce accecante dell'impero. Il sogno di Galeano è perso, le Memorie del fuoco sono rimaste a impolverarsi sullo scaffale. Ma anche il sogno americano è stato seppellito sotto un'immensa montagna di contenitori usa e getta e le rime di Oh! Susanna restano un inganno, totalmente prive di senso.
Santo Barezini
- “Niggers” nel testo originale. In omaggio al politicamente corretto il termine scompare nelle versioni moderne. Un esempio di nonsense nella strofa di apertura: “il giorno che sono partito ha piovuto per tutta la notte / il tempo era così asciutto / il sole così caldo / che quasi sono morto congelato”. Sorprendentemente, Foster è considerato oggi il padre della musica americana.
- Il nome del cavallo di Don Chisciotte, tradotto con Ronzinante nella versione italiana dell'opera.
- Travels with Charley in search for America, 1960.
- Oltre il 60% dei cittadini USA non hai mai avuto un passaporto.
- “Gesù ha pagato tutto” e “Dio benedica l'esercito degli Stati Uniti”.
- Beth Fontenot, medico, marzo 2016. Nel prologo si legge: “I cibi ultra-processati non sono nemmeno veri cibi, ma un ammasso di emulsionanti, sali, zuccheri aggiunti e calorie e sono i migliori amici dell'obesità”. Il film “L'invasione degli ultracorpi” è del 1956.
- Il Bureau of Indian Affairs è un'agenzia federale alle dipendenze del Ministero dell'Interno. Amministra 225.000 Kmq di territorio destinato a riserva per 567 nazioni indiane.
- Memorias del fuego, trilogia pubblicata fra il 1982 e il 1986 per l'editore Del Chanchito.
|

