
Zona letteraria/
Poco pane, qualche rosa
È uscito il primo numero di Zona Letteraria – Studi e prove di letteratura sociale, nuova rivista diretta dal nostro collaboratore e caro amico Giuseppe Ciarallo. Gli abbiamo dato tremila battute per presentarla.

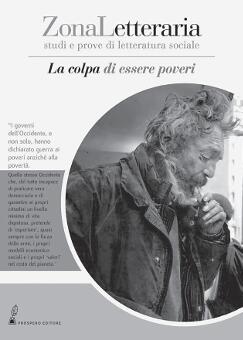 Se
è vero, come ebbe a dire un grigio ministro dell'economia
(capitalistica), che “con la cultura non si mangia”,
è altrettanto innegabile che per sua natura l'essere
umano necessita, per sopravvivere, delle rose oltre che del
pane. Ed è in ossequio a questo incontrovertibile principio
che un già rodato collettivo redazionale e una giovane
casa editrice battagliera hanno unito le loro forze per creare
una rivista come “Zona Letteraria – Studi e prove
di letteratura sociale”. Se
è vero, come ebbe a dire un grigio ministro dell'economia
(capitalistica), che “con la cultura non si mangia”,
è altrettanto innegabile che per sua natura l'essere
umano necessita, per sopravvivere, delle rose oltre che del
pane. Ed è in ossequio a questo incontrovertibile principio
che un già rodato collettivo redazionale e una giovane
casa editrice battagliera hanno unito le loro forze per creare
una rivista come “Zona Letteraria – Studi e prove
di letteratura sociale”.
Questo semestrale si è posto l'obiettivo di diventare
– nell'ambito di una sinistra sfilacciata – strumento
capace di stimolare una riflessione sui grandi temi sociali,
culturali e politici, partendo dallo specifico letterario e
individuando di volta in volta particolari tematiche da analizzare.
Nel numero d'esordio abbiamo deciso di trattare lo spinoso argomento
della vergognosa e inumana guerra che i governi dell'opulento
occidente, e non solo, hanno dichiarato ai poveri anziché
alla povertà. Una guerra all'insegna del “take
no prisoners”, nella quale gli ultimi sono le vittime
sacrificali predestinate, su cui riversare odio e indifferenza,
nonché fastidio. Ma soprattutto ci siamo chiesti quale
sia stato il big bang che ha fatto sì che intere
società diventassero fredde, insensibili ed egoiste,
quale sia stato il percorso che ha portato generazioni di migranti
a dimenticare il proprio passato, il dovere dell'accoglienza,
la solidarietà verso il debole e il bisognoso, la ricchezza
del dono, scivolando rovinosamente nell'abisso dell'aridità
relazionale.
In un tentativo di risposta a tali domande, all'interno di questo
“numero uno” si parla della grande crisi del '29
in Furore di Steinbeck, delle “villas miserias”
argentine, dei messicani poveri e del loro tentativo di varcare
il confine con gli Stati Uniti, del cinema di Ken Loach, sempre
molto attento alle sorti del proletariato inglese, di criminalizzazione
dei Rom, del pauperismo in Valdo e in San Francesco, di Goffredo
Parise e di decrescita felice, della tecnologia applicata alla
repressione della povertà a Singapore, di Woody Guthrie
e di musica popolare e di protesta negli USA, di come la pittura
ha nel tempo raffigurato gli ultimi, di Arte e povertà,
e poi ancora di Italo Calvino, di Beppe Fenoglio e dei suoi
contadini, della Cina dello scrittore Yu Hua, di Valerio Evangelisti,
di Anthony Cartwright e del suo romanzo sulla Brexit, di John
Berger e del suo Il settimo uomo, e ancora, di Lucio
Dalla, di Gianmaria Testa, di Loriano Macchiavelli, di Maurizio
Bovarini e persino di Superciuk, l'antieroe dei fumetti, che
rubava ai poveri per donare ai ricchi. Senza dimenticare, nella
rubrica Riflessioni, il rapporto tra “fame” e “potere”
narrato in chiave psicanalitica.
Queste, in sintesi, le nostre rose.
https://www.prosperoeditore.com/libri/Abbonamento-Redazione-Zona-Letteraria
Giuseppe Ciarallo
Un secolo fa in Argentina/
Storie d'amore e d'anarchia
“Eroe o criminale? Rivoluzionario o assassino? L'uno
e l'altro certo. Eppure non riesco davvero ad andare a fondo
[...] Le vite delle persone non si costruiscono con i se. I
se, piuttosto, servono a noi. Se solo Severino non avesse sostituito
le parole col tritolo, l'ansia di giustizia con una rabbia feroce,
l'attesa di una nuova alba di umanità con la voglia di
far sprofondare tutto nella notte della vendetta... se solo...
se solo... Ragionamento che lascia il tempo che trova...”.
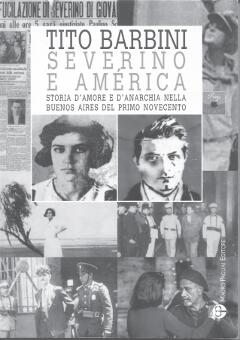 Sono
stralci significativi delle riflessioni che Tito Barbini, alla
fine del libro Severino e América. Storia d'amore
e d'anarchia nella Buenos Aires del primo Novecento (Mauro
Pagliai Editore, Firenze 2018, pp. 172, € 15,00) dedica
al protagonista principale di una storia maledetta e fascinosa. Sono
stralci significativi delle riflessioni che Tito Barbini, alla
fine del libro Severino e América. Storia d'amore
e d'anarchia nella Buenos Aires del primo Novecento (Mauro
Pagliai Editore, Firenze 2018, pp. 172, € 15,00) dedica
al protagonista principale di una storia maledetta e fascinosa.
La bibliografia su Severino Di Giovanni (1901-1931), anarchico
e “idealista della violenza”, si è ormai
fatta consistente ed ha costruito e alimentato, nel tempo, il
mito di un vero personaggio da fiction. L'opera di Osvaldo Bayer,
prima di tutte, ha reso viva questa storia d'emigrazione, che
è stata insieme saga familiare e paradigma di una lotta
politica estrema.
Teatro dei fatti la turbolenta Argentina di un secolo fa, dove
erano in atto mobilitazioni popolari di protesta pro Sacco e
Vanzetti e dove l'antifascismo in esilio, mordendo il freno,
meditava il riscatto per l'Italia. L'impatto sociale dello scontro
di massa ingaggiato con la classe dirigente del paese sudamericano
fu forte, sorretto da una vivace potente presenza delle organizzazioni
libertarie e anarchiche, che all'epoca editavano una gran mole
di stampa, insieme ad un importante giornale quotidiano. Il
passaggio cruciale da un regime democratico alla dittatura militare,
nel 1930, rese, se possibile, ancora più tragici e sanguinosi
gli esiti di una guerriglia sociale ormai divenuta aperta e
senza quartiere. Tutto questo mentre il “film” calava,
con mestizia, il sipario sulla fucilazione del protagonista...
Sulla opportunità del ricorso alla violenza politica
e alle azioni terroristiche il contrasto nel movimento fu aspro,
la discussione molto articolata. Per Errico Malatesta: “Noi
dobbiamo ricordarci che la violenza, necessaria purtroppo per
resistere alla violenza, non serve per edificare niente di buono:
che essa è la nemica naturale della libertà, la
genitrice della tirannia e che perciò deve essere contenuta
nei limiti della più stretta necessità.”
(«Umanità Nova», 14 ottobre 1922).
Barbini, prolifico scrittore di viaggi, ha interpretato quel
dramma epocale vissuto dal popolo argentino cogliendo il fil
rouge di un “romanzo di sentimenti”, guardando
cioè “in un'altra direzione”, raccontando
la storia travolgente e totale di due amanti – Severino
e América –, con un libro che, prima di tutto,
si interroga sull'amore e sui suoi misteriosi intrecci con la
passione politica. La trama si dipana in momenti intensi, poetici
e struggenti: “come un tango”, dice l'autore. Lavori
come questo ci ricordano che qualcosa sta davvero cambiando
(in meglio) nei modi di raccontare la storia e le storie; e
che ciò si deve alla sempre maggiore integrazione dei
registri narrativi fra ricercatori e scrittori. Le emozioni,
il racconto in soggettiva, l'utilizzo scientifico di fonti di
repertorio per la ricostruzione del “verosimile”,
il sopralluogo come metodo, ecc. sono solo alcuni degli strumenti
possibili atti a rinnovare l'intero impianto metodologico della
storiografia, a dare davvero visuali “altre” sul
Novecento. Se dovessimo, come si usa fare, rendere riconoscibile
alle ricerche bibliografiche questo libro e quindi assegnargli
tag o keyword che dir si voglia, a quelle, forse
un po' scontate, di Amore e Anarchia se ne potrebbe aggiungere
un'altra: Geografia.
“Non fosse per il sorriso di América. Per la sua
vita dopo. Mi sono più volte chiesto se questa storia
c'entri con il fatto che scrivo di viaggi. Certo che sì.
La geografia conta in questa storia. Anche se piuttosto parlerei
di geografia della mente. Di geografia della libertà.
Come quel geografo anarchico, Eliseo Reclus, per stampare le
cui opere Severino svaligiava le banche...” (p. 146).
In un'epoca in cui la dimensione politica sembra ormai sostituita
dalla governance e la geografia rimpiazzata dalle connessioni,
si potrà ben capire l'importanza di riconoscere i topoi,
ossia i “luoghi” dove materialmente si sono svolti
i fatti che si vogliono rievocare, alla ricerca delle anime
perdute che da lì sono passate, per respirare quella
stessa aria e provare a incrociare quegli stessi pensieri.
L'autore, pur non avvezzo a scrivere di cose anarchiche, si
è comunque avvicinato all'argomento in punta di piedi,
con il dovuto rispetto. Lo stereotipo dell'anarchico tutto bombe
e disorganizzazione, storicamente inconsistente, non ha così
preso le forme consuete della narrazione mainstream. Il movimento
anarchico, sebbene attraversato dalle correnti cosiddette violentiste/illegaliste
e perfino dal banditismo sociale, mantiene un posto d'onore
nella storia del movimento operaio e, più in generale,
in quella nella lotta ad ogni tirannia. Come movimento antitotalitario
che ha subito la “doppia” tragica sconfitta nella
Spagna del 1936-'37, gli anarchici, passati dal protagonismo
alla testimonianza, hanno poi continuato, nonostante tutto,
a rappresentare una speranza di riscatto umano e sociale –
proprio per le loro “esagerate idee di libertà”
– ed un punto di riferimento essenziale nel corpus teorico
del pensiero radicale contemporaneo.
Per la curiosità dei lettori: l'autore di Severino
e América ha calcato a lungo il proscenio della politica
locale e non solo: sindaco di Cortona, presidente della provincia
di Arezzo, assessore nella Regione Toscana, membro del Comitato
centrale del PCI, è stato amico personale di Mitterrand.
Nel 2016 pubblicava un altro bel libro intitolato Quell'idea
che ci era sembrata così bella (Aska), “viaggio
a ritroso, dietro ai fallimenti e alle delusioni della grande
utopia comunista”.
Giorgio Sacchetti
Sicilia/
Quel carcere a chiocciola ad Alcàra Li Fusi
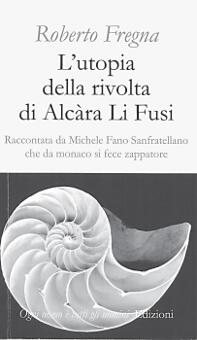 Roberto
Fregna, in un suo recente e prezioso volumetto, ispirato all'opera
e al lavoro artistico di Vincenzo Consolo, parla della lingua
letteraria dello scrittore siciliano “che rompe il codice
linguistico comune per rappresentare la società che include
le periferie lontane di emigrazione storica, di emarginazione
e di povertà, dove vi sono donne e uomini senza terra,
piegati da fatiche immani, zappatori a dissodare campi pietrosi
o cavatori in miniere di zolfo o di pomice destinati a morire
del morbo di San Biagio”. Poi, con un procedere
per immagini divaganti e a spirali, Fregna fa cenno ad un racconto
di Consolo sull'incontro tra Miguel de Cervantes e Antonio Veneziano
(uno dei più grandi poeti siciliani del 600), in un
carcere di Algeri, proseguendo con l'annotare informazioni su
un altro carcere, quello di Sant'Agata di Militello, il paese
natio di Consolo, costruito a mo' di chiocciola nei primi decenni
del 600. Roberto
Fregna, in un suo recente e prezioso volumetto, ispirato all'opera
e al lavoro artistico di Vincenzo Consolo, parla della lingua
letteraria dello scrittore siciliano “che rompe il codice
linguistico comune per rappresentare la società che include
le periferie lontane di emigrazione storica, di emarginazione
e di povertà, dove vi sono donne e uomini senza terra,
piegati da fatiche immani, zappatori a dissodare campi pietrosi
o cavatori in miniere di zolfo o di pomice destinati a morire
del morbo di San Biagio”. Poi, con un procedere
per immagini divaganti e a spirali, Fregna fa cenno ad un racconto
di Consolo sull'incontro tra Miguel de Cervantes e Antonio Veneziano
(uno dei più grandi poeti siciliani del 600), in un
carcere di Algeri, proseguendo con l'annotare informazioni su
un altro carcere, quello di Sant'Agata di Militello, il paese
natio di Consolo, costruito a mo' di chiocciola nei primi decenni
del 600.
Ragionando sulla chiocciola – e sulla sua forma difficile
da rappresentare geometricamente, quindi sulla geometria che
è scienza stratta e rimanda a spazi e punti che sono
rappresentati in un non luogo, quindi in un'utopica realtà
– Fregna richiama la Città del Sole di Tommaso
Campanella, che era di Stilo, paese della punta estrema della
Calabria, non lontano da Sant'Agata di Militello, cittadina
prossima allo stretto di Messina e dove Campanella con i suoi
discorsi aveva ispirato la “Rivolta delle Calabrie”
del 1599, muovendo i poveri contro i potenti, in un assalto
che risultò fallimentare ma che voleva abbattere la loro
“tirannide”, i loro “sofismi” e le loro
“ipocrisie”.
Lo stesso assalto al potere che animò i contadini siciliani
nel 1860, raccontato nel romanzo di Consolo Il sorriso dell'ignoto
marinaio, dal quale Fregna riprende il tema della delusione
popolare e contadina seguita alla spedizione garibaldina in
Sicilia, che tante attese aveva suscitato e tanti fuochi rivoluzionari
aveva acceso, tutti spenti dalla repressione delle forze dell'ordine
e dell'apparato giudiziario del nuovo Regno dell'Italia unita.
Così, ne L'utopia della rivolta di Alcàra Li
Fusi. Raccontata da Michele Fano Sanfratellano che da monaco
si fece zappatore (Ogni uomo è tutti gli uomini Edizioni,
Bologna 2018, pp. 42, € 9,50), Fregna riporta le scritte
sulle mura delle celle degli insorti alcaresi nel carcere della
vicina Sant'agata di Militello, e ridà voce alla rabbia
e alle ragioni dei contadini siciliani, ben palesate nelle aspre
e accese parole di Michele Fano di San Fratello, paese d'antica
storia e di millenarie e arcaiche tradizioni, immerso nei boschi
e nelle montagne dei Nebrodi, non lontano da Alcàra Li
Fusi e da Sant'Agata di Militello. E riporta, Fregna, tra le
altre, la scritta ultima e disperata di Fano, questa, nella
traduzione dal siciliano di Consolo: “Questa è
la storia vera/di Alcàra/maggio e giugno dell'anno sessanta/raccontata
dalla gente che la fece/scritta con il carbone sopra la pietra/da
Michele Fano Sanfratellano/che da monaco si fece zappatore/se
entri dentro questo pozzo torto/sappi come accadde e restatene
zitto/dì uscendo che la prossima volta/il popolo incazzato
di Alcàra/di Bronte Tusa oppure Caronia/non lascia sopra
la faccia di questa terra/neppure la semenza di sorci e notabili/cantò
la civetta e il gufo e il corvo/uniti tutti e tre un giorno
cantarono/...lupare e coltello/morte a tutti i ricchi/il povero
esclama/al fondo di tanto abisso/terra pane/l'origine è
là/fame senza fine/di/libertà”.
Silvestro Livolsi
I GAAP, 2° volume/
Storia di un'eresia anarchica
Introducendo i lavori della VII Conferenza nazionale, convocata
a Genova per il 28 aprile 1956, della Federazione Comunista
Libertaria, nuova denominazione assunta dai Gruppi Anarchici
di Azione Proletaria (GAAP), il relatore, consapevole che quella
sarebbe stata l'ultima assise del gruppo che aveva deciso di
sciogliersi e confluire nel nascente Movimento della Sinistra
Comunista, riassunse succintamente le tappe del loro percorso
politico e organizzativo. L'organizzazione era sorta con l'intenzione
di rinnovare il movimento anarchico in Italia, di portare un
contributo alla rinascita di un movimento operaio rivoluzionario.
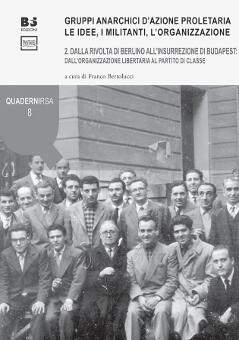 Inizialmente
questo nucleo di compagni aveva lavorato all'interno dell'organizzazione
anarchica esistente, la Federazione Anarchica Italiana, ricostituitasi
nell'immediato dopoguerra. Ben presto però, resisi conto
della confusione politica e ideologica esistente nella Federazione
anarchica, s'indirizzarono verso la definizione e l'organizzazione
un gruppo autonomo, con una propria fisionomia, in polemica
ma sempre all'interno della Federazione; iniziarono a pubblicare
il giornale L'Impulso, per poi procedere alla costituzione
dei Gruppi Anarchici d'Azione Proletaria nel 1951. Ancora era
presente il tentativo di rinnovare e potenziare il movimento
anarchico italiano, di cui si sentivano parte. Fallito questo
proposito, negli anni seguenti aprirono il confronto con altri
gruppi politici minoritari di osservanza bordighista e trotskista,
forti del fatto che alcuni obiettivi erano stati conseguiti:
nel lavoro di critica, connesso alla polemica con gli anarchici,
si era rafforzata l'analisi teorica e storica; nel lavoro politico
e organizzativo si era formato un nucleo di militanti qualificati;
avevano impiantato un'organizzazione con un suo giornale, con
rapporti all'esterno e una vita democratica all'interno. Inizialmente
questo nucleo di compagni aveva lavorato all'interno dell'organizzazione
anarchica esistente, la Federazione Anarchica Italiana, ricostituitasi
nell'immediato dopoguerra. Ben presto però, resisi conto
della confusione politica e ideologica esistente nella Federazione
anarchica, s'indirizzarono verso la definizione e l'organizzazione
un gruppo autonomo, con una propria fisionomia, in polemica
ma sempre all'interno della Federazione; iniziarono a pubblicare
il giornale L'Impulso, per poi procedere alla costituzione
dei Gruppi Anarchici d'Azione Proletaria nel 1951. Ancora era
presente il tentativo di rinnovare e potenziare il movimento
anarchico italiano, di cui si sentivano parte. Fallito questo
proposito, negli anni seguenti aprirono il confronto con altri
gruppi politici minoritari di osservanza bordighista e trotskista,
forti del fatto che alcuni obiettivi erano stati conseguiti:
nel lavoro di critica, connesso alla polemica con gli anarchici,
si era rafforzata l'analisi teorica e storica; nel lavoro politico
e organizzativo si era formato un nucleo di militanti qualificati;
avevano impiantato un'organizzazione con un suo giornale, con
rapporti all'esterno e una vita democratica all'interno.
Era, secondo loro, il coronamento positivo della riscoperta
dell'organizzazione libertaria in polemica col “vecchio”
individualismo anarchico, fatta attraverso una rilettura di
Malatesta, Fabbri, Berneri e poi Gramsci e, sul piano internazionale,
della CNT, della FAI della guerra civile spagnola e Rosa Luxemburg.
Tutto sembrava conciliarsi: l'orientamento rivoluzionario, l'antifascismo
e la lotta partigiana, la battaglia antistalinista, la rifondazione
di un comunismo libertario e consiliarista, a partire dal riconoscimento
del fallimento delle esperienze socialdemocratiche, bolsceviche
e anarchiche passate, per formare un movimento di classe nuovo
e un'organizzazione che non fosse la riproposizione del partito
tradizionale della classe operaia, ma qualcosa di superiore,
di “inedito”.
Una parte di questo “pezzo” di storia dei GAAP è
stato oggetto di estrema attenzione e narrazione nel primo volume
uscito l'anno scorso a cura di Franco Bertolucci (Gruppi
anarchici d'azione proletaria. Le idee, i militanti, vol. 1,
Dal Fronte popolare alla «legge truffa»: la crisi
politica e organizzativa dell'anarchismo, Bfs-Pantarei,
2017). Lavoro che è proseguito con questo secondo volume,
sempre curato da Franco Bertolucci (Gruppi anarchici d'azione
proletaria. Le idee, i militanti, l'organizzazione. Vol. 2 Dalla
rivolta di Berlino all'insurrezione di Budapest: dall'organizzazione
libertaria al partito di classe, a cura di Franco Bertolucci,
Bfs-Pantarei, Pisa-Milano 2018, pp. 784. € 40,00). Entrambi
i volumi, e il terzo promesso che seguirà, sono il frutto
di un impegno preso dal curatore nel 1998 con uno dei principali
protagonisti di quest'esperienza, Pier Carlo Masini (1923 -1998),
quando donò alla Biblioteca Serantini l'archivio politico
dei GAAP e le sue carte personali. Pier Carlo Masini espresse
l'intenzione che dieci anni dopo la sua scomparsa quei materiali
fossero riordinati e resi disponibili per le attività
di studio e di ricostruzione storica.
Impegno ampiamente rispettato, grazie a quasi vent'anni di lavoro.
Difatti i due volumi contengono in appendice una voluminosa
documentazione di materiali di vario genere oggi facilmente
consultabili. In questo secondo volume la documentazione spazia
dalle conferenze nazionali dei GAAP e dell'Internazionale comunista
libertaria, alle circolari di orientamento politico e organizzative
stilate dal comitato nazionale, a saggi storici e teorici e
articoli tratti dal giornale L'Impulso.
Staccatisi dall'area anarchica tradizionale, i GAAP si diedero
per scopo politico quello di inserirsi nel perimetro del dissenso
a sinistra dei partiti parlamentari, ritenevano di poter incidere
nello scontro politico e ideologico al fine di costruire qualcosa
di nuovo che non fosse l'ennesimo piccolo gruppo settario tutto
proiettato su se stesso. Prioritario diventava lavorare per
una nuova organizzazione politica in grado di sconfiggere l'egemonia
del partito comunista, spezzare la sua alleanza col partito
socialista al quale riconoscevano l'originalità di un
percorso indipendente, diverso da quello delle socialdemocrazie
europee. In questo senso, seppure in una dimensione forse più
piccola di quella prevista e/o voluta, qualcosa si mosse a partire
dal 1955, quando una forma di dissenso si palesò dentro
il partito di Togliatti con la corrente che si denominò
Azione comunista. Nella lunga introduzione alle carte, il curatore
ricostruisce con dovizia e pazienza il contesto storico e sociale
di quel periodo, all'interno del quale inserisce le analisi
e le scelte operate dai comunisti libertari. Restituisce così
al lettore il clima di quegli anni, la vivacità del dibattito
politico alla sinistra dei partiti istituzionali del movimento
operaio, portando alla luce esperienze di lotta e correnti politiche
trascurate o cancellate da certa storiografia, tutta tesa a
fare la storia dei partiti maggiori, in particolare di quello
comunista.
Quando gli esponenti di Azione comunista decisero di uscire
allo scoperto pubblicando il periodico omonimo, furono espulsi
dal partito. Questo accadeva nel giugno 1956, in concomitanza
con la diffusione del rapporto segreto di Krusciov nel mondo
occidentale. Pochi mesi dopo vennero i fatti di Polonia e la
rivoluzione ungherese, duramente repressa dall'intervento delle
truppe sovietiche. Fu in quel contesto che, - anche per impulso
dei dirigenti della Federazione Comunista Libertaria, nuovo
nome assunto dai GAAP - si presero o ripresero contatti con
forze politiche del dissenso a sinistra, come dimostra nel libro
il continuo riferimento allo scambio di lettere tra esponenti
di Azione comunista, dei Gruppi Comunisti Rivoluzionari, la
sezione italiana della Quarta Internazionale e il Partito Comunista
Internazionalista (Battaglia comunista).
Sull'onda della crisi di una parte della sinistra tradizionale,
indotta dagli eventi, queste quattro organizzazioni decisero
di costituire un organismo di confronto: il Movimento della
Sinistra Comunista. Si trattò di un accordo abbastanza
generico, né poteva essere diversamente data la persistenza
di analisi e impostazioni di lavoro politico e sindacale non
omogenee, che si sperava però di superare attraverso
un confronto prolungato nel tempo. Non fu così semplice.
Quelli della Quarta Internazionale sollevarono la questione
della natura sociale dell'Urss, stato operaio degenerato, mentre
per gli altri era un paese capitalista e imperialista quanto
gli Stati Uniti; poi del sindacato: aderire alla Cgil? Votare
nelle elezioni per le Commissioni Interne per i loro esponenti
di categoria? Partecipare o meno alle elezioni politiche e amministrative?
E che indicazione di voto dare? Su quest'ultimo punto, già
per le elezioni del marzo 1956, i comunisti libertari avevano
per così dire rotto un tabù.
La parola d'ordine “non votate”, scrissero in un
documento, salvo il caso di un boicottaggio generale delle elezioni,
è “settaria ed utopistica: settaria perché
estrania l'organizzazione rivoluzionaria dalla vita politica
delle masse in una fase in cui queste entrano in movimento;
utopistica perché non realizza il benché minimo
risultato positivo, confonde le poche astensioni coscienti nella
massa delle astensioni incoscienti, preclude ogni possibilità
di lavoro ulteriore di persuasione e di penetrazione”.
La conclusione era che l'organizzazione si proponeva di dare
“una caratterizzazione rivoluzionaria” al voto dei
lavoratori, il quale esprimeva il loro malcontento, la loro
opposizione radicale alla presente società, “sia
pure espresso con una scheda”. Insomma, era ora di uscire
dallo “sterile” astensionismo anarchico e, alla
fine, l'indicazione tattica data ai propri militanti era di
votare i “candidati operai”.
Nel 1957, a fronte del persistere di evidenti divergenze non
appianate, tra “trotskisti” e “bordighisti”,
i comunisti libertari proposero una fusione in breve tempo che
voleva dire sciogliere tutte e quattro le organizzazioni e promuoverne
una nuova. La proposta trovò il consenso della sola Azione
comunista, mentre “bordighisti” e “trotskisti”
uscirono dal movimento. Con la nascita dell'organizzazione della
Sinistra Comunista, si concludeva la storia dei GAAP-FCL. Ma
la stessa nascita del nuovo e “inedito partito”
portava in sé i nodi di contraddizioni che esplosero
l'anno seguente dividendo i percorsi tra una parte degli ex
militanti comunisti libertari e gli altri che rimarranno all'interno
della neonata organizzazione.
Diego Giachetti
Donne in carcere/
Un mondo sospeso
Chi evita l'errore elude la vita.
C.G. Jung
Un paio di mesi fa è uscito, per quelli dell'editrice
Ortica, un piccolo libro che raccoglie storie di donne, il cui
titolo allude alla proibizione di introdurre agrumi all'interno
del carcere femminile di Rebibbia dove sono recluse: I limoni
non possono entrare. Storie di donne dal carcere (Alessandra
Caciolo, Stefania Zanda, Aprilia – Lt 2018, pp. 216, €
12,00).
Tra il 2017 e il 2018, all'interno di un progetto che prevedeva
incontri settimanali di gruppo per tutte quelle detenute che
sentivano la necessità di raccontare e condividere la
loro storia, è stato raccolto il materiale che in seguito
ha preso la forma di libro. Grazie alla disponibilità
di sei o sette di loro è stato possibile raccontare il
carcere, con tutte le sue contraddizioni e i pregiudizi, e aprire
lo sguardo su una realtà che chiamare “luogo dell'oblio”
calza a pennello, un posto dove le vite rimangono sospese e
dove regna l'attesa. Un luogo molto spesso dimenticato.
 Quello
di cui si parla non è genericamente il carcere, ma il
carcere femminile e quello di Rebibbia è uno dei pochi
ad averne uno destinato solo alle donne. Infatti la realtà
carceraria italiana è composta quasi esclusivamente da
istituti maschili con sezioni femminili all'interno –
spesso molto piccole – dove le donne sono lasciate lì,
abbandonate a se stesse; quindi “far ascoltare”
il carcere femminile significa cercare di alzare il volume mentre
si parla di una differenza di genere sostanziale. Significa
domandarsi cosa vorrebbe dire spostare l'attenzione sulle donne
per fare della detenzione femminile il parametro dell'uguaglianza. Quello
di cui si parla non è genericamente il carcere, ma il
carcere femminile e quello di Rebibbia è uno dei pochi
ad averne uno destinato solo alle donne. Infatti la realtà
carceraria italiana è composta quasi esclusivamente da
istituti maschili con sezioni femminili all'interno –
spesso molto piccole – dove le donne sono lasciate lì,
abbandonate a se stesse; quindi “far ascoltare”
il carcere femminile significa cercare di alzare il volume mentre
si parla di una differenza di genere sostanziale. Significa
domandarsi cosa vorrebbe dire spostare l'attenzione sulle donne
per fare della detenzione femminile il parametro dell'uguaglianza.
Nel nostro paese, ma anche nel resto d'Europa la situazione
pare non essere molto diversa, le donne sono poco più
del 4% della popolazione detenuta, delinquono quantitativamente
meno e anche “qualitativamente” sono, per così
dire, inferiori ai maschi; significa che, in buona parte, si
tratta di piccola criminalità proveniente da percorsi
di esclusione sociale dove è frequente la recidività.
Per questo le autrici del libro sottolineano come adottare un'ottica
di genere, sia per leggere il reato sia per determinare la pena
e la sua esecuzione, sarebbe un guadagno per tutte e per tutti.
Il fatto sostanziale del libro sta proprio in questa proposta
sottesa, una proposta che rivoluzionerebbe il modello di pena
tuttora in uso e che potrebbe far pensare ad un carcere diverso,
un carcere – si sottolinea – probabilmente pensato
per la prima volta. L'autenticità delle narrazioni raccolte,
con la loro capacità di coinvolgimento emotivo, non fa
altro che mostrare quanto il bisogno sia impellente, come sia
indispensabile guardare alle storie, e non ai numeri, se si
vuole avere un'autentica comprensione della situazione carceraria.
Di fatto io credo che il carcere mostri macroscopicamente ciò
che accade in tutti gli altri ambiti del nostro vivere sociale,
soprattutto laddove si raggruppano grossi numeri di persone
in condizione di fragilità – vuoi perché
troppo giovani, troppo vecchie o malate – dove la tendenza
all'omologazione, al protocollo, all'appiattimento standardizzato,
è la scelta forte e più facile. Poter rivolgere
attenzione ad ogni individuo per la particolarità che
lo contraddistingue nel genere e nell'esperienza di vita (che
l'ha condotto a delinquere, ad esempio, nel caso specifico di
cui stiamo parlando), presuppone lo sradicamento dell'abitudine
all'indifferenza, all'individualismo esasperato, presuppone
ripensare alla base tutto il nostro vivere relazionale, dalla
coppia alla famiglia fino alla comunità sociale. Lavoro
immenso da cui non possiamo prescindere se scegliamo di percorrere
strade utili a risolvere problemi, a creare salute, benessere
e magari, perché no, anche felicità.
Allora questo libretto diventa un piccolo/grande spunto di riflessione.
Si parte dall'ascolto, dall'empatia, dal provare a mettersi
nei panni dell'altro. Si tratta di vedere umanità in
chi ha sbagliato e di cercare soluzioni alternative che creino
occasioni di vita. Si tratta di uscire dalla logica della violenza
punitiva e dell'abuso di potere.
Si legge così nelle ultime pagine: “la consapevolezza
che, anche se abbiamo commesso degli errori non siamo diverse
dagli altri, anzi abbiamo qualcosa che ci contraddistingue:
la lotta, la sofferenza e la determinazione di andare avanti.
Non si può ridurre l'esistenza di una persona alla somma
degli errori commessi. Gli sbagli avvenuti per motivi diversi
sono degli ostacoli sul cammino, comprenderli può permetterci
di non ripetere gli stessi errori.”
Penso sia un pensiero importante per tutte e tutti, dentro e
fuori dai carceri.
Silvia Papi
Futuri possibili/
Cercare l'utopia (per continuare a camminare)
Se pure l'utopia è irraggiungibile, secondo Eduardo
Galeano è per lei che ci si mette in viaggio: “Mi
avvicino di due passi, lei si allontana di due passi. Cammino
per dieci passi e l'orizzonte si sposta dieci passi più
in là. Per quanto io cammini, non la raggiungerò
mai. A cosa serve l'utopia? Serve proprio a questo: a camminare.”
Il contrario di utopia è distopia, ovvero il luogo “cattivo”
che (ancora) non c'è ma è possibile, forse vicinissimo.
Elisabetta Di Minico ha scritto con Il futuro in bilico.
Il mondo contemporaneo tra controllo, utopia e distopia
(Meltemi, Sesto San Giovanni 2018, pp. 422, € 28,00) un
libro importante, usando la fantascienza come grimaldello per
scardinare il presente e i futuri (ravvicinati) possibili.
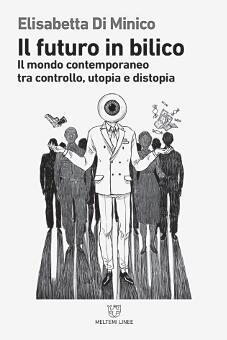 Il
primo capitolo ci introduce ai temi saltellando fra i secoli
per mostrarci come la coppia utopia/distopia abbia genitori
illustri. Il
primo capitolo ci introduce ai temi saltellando fra i secoli
per mostrarci come la coppia utopia/distopia abbia genitori
illustri.
Utopici? I primi nomi che vengono in mente sono Bacone e Voltaire.
Passando per i seguaci di Charles Fourier e per Edward Bellamy
arriviamo all'immeritatamente dimenticato L'anno 2440
scritto (nel 1771) dall'illuminista Louis Sébastien Mercier.
Variamente distopici Erewhon di Samuel Butler, molti
passaggi de I viaggi di Gulliver, alcune opere di Verne,
La macchina si ferma, Rur di Karel Capek e Metropolis
(l'autrice cita solo il film dimenticando il romanzo del 1925
di Thea Von Harbou da cui fu tratto) per arrivare alla fantascienza
propriamente detta letteraria, cinematografica e fumettara.
Chiariamo subito che quasi solo in Italia, per un antico pregiudizio,
romanzi come 1984 o Il mondo nuovo non sono considerati
fantascienza.
Il secondo capitolo – «Distopia e controllo»
– esamina in dettaglio 20 opere. E ci sono recuperi assai
interessanti. Per esempio, il romanzo La notte della svastica
(del 1937) scritto dall'inglese Katharine Burdekin. O Antifona
(1938) della scrittrice e filosofa Ayn Rand. Oppure Kallocaina
(1940) della svedese Karin Boye. Tre donne “rimosse”
dunque: sarà un caso?
Fra i libri citati di sfuggita – sarebbe stato impossibile
analizzarli tutti – anche Qui non è possibile
(1935) di Sinclair Lewis che immagina gli Usa sotto dittatura:
quel titolo a me ricorda i tanti che recentemente di fronte
ai primi segni di ri-fascistizzazione di Polonia, Ungheria o
Turchia avevano sentenziato “indietro non si torna”...
E infatti.
Siamo così arrivati a metà libro. E adesso Elisabetta
Di Minico ci propone i due capitoli finali (risultano più
intrecciati che paralleli) ovvero «Distopia e poteri dominanti»
– cioè le dittature, più o meno mascherate
– e «Distopia e poteri suadenti» insomma i
governi che vengono definiti democratici. Politicamente sono
i due capitoli più interessanti, è ovvio. Il reale
e l'immaginazione a confronto: e il risultato può spaventare
anche le persone più coraggiose. Pur con tutti i distinguo
storici, teorici e pratici, l'autrice giustamente annota: “la
“cancrena” che divora i poteri suadenti è
poco differente da quella delle peggiori dittature”. È
un'osservazione che si può estendere dal caso particolare
al generale. Verso la fine, Elisabetta Di Minico chiarisce:
“il presente studio non vuole screditare i sistemi democratici
[...] almeno non del tutto”. Ma citando Herbert Marcuse
ricorda che comunque “questa società cambia tutto
ciò che tocca in una fonte potenziale di progresso e
di sfruttamento, di fatica memorabile e di soddisfazione, di
libertà e di oppressione”. E più avanti
aveva riportato una delle frasi più famose (e difficilmente
contestabili) di Marcuse: “una confortevole, levigata,
ragionevole, democratica non-libertà prevale nella civiltà
industriale avanzata, segno del progresso tecnico”. Beninteso
è «levigata» in questa parte del mondo perché
altrove (nelle vecchie/nuove colonie) il capitalismo può
togliersi la maschera e mostrarsi – perfino vantarsi –
capace di ogni infamia. Qui è un Occidente che si finge
tollerante, lì cambia una sola vocale e diventa Uccidente.
Un libro che merita, dunque. Difetti? Non potendo dire tutto
in 400 pagine, alcune sezioni storico-politiche sono tagliate
con l'accetta e frettolose; questo forse spiega anche perché
tra le fonti si citano opere più propagandistiche (Il
libro nero del comunismo o Lo scontro delle civiltà
di Samuel Huntingron) che ricche di documentazione.
Auspicabile che, in prossimi lavori, il gruppo di ricerca HISTOPIA
(bellissimo nome) del quale l'autrice fa parte recuperi anche
testi utopici/distopici di area anarchica, qui un po' trascurati.
Si potrebbe partire dall'antologia (del 1948 ma ripubblicata
nel 1981) Viaggio attraverso l'utopia di Maria Luisa
Berneri.
Intanto i più ottimisti fra noi continuano a camminare
verso le utopie e a pensare che le rivoluzioni possano sovvertire
in meglio lo stato presente. Ognuna/o interpretando a suo modo
la frase del bolscevico (poi dissidente) e romanziere Evgenij
Zamjatini: “l'ultima rivoluzione è come l'ultimo
numero: non esiste.”
Daniele Barbieri
Russia 1917/
Da bolscevica a anarchica. Storia di una ribelle
Poche opere letterarie e politiche, prodotte nella Russia degli
anni 20 e 30, danno l'idea di quanto la rivoluzione sia stata
spontanea e partecipata dai lavoratori di città e campagne
come l'autobiografia di Evgenija Jaroslavskaja-Markon, La
ribelle (Ugo Guanda Editore, Milano 2018, pp. 180, €
16,50), pubblicata recentemente.
 Conosciamo
la storia degli anarchici russi e del movimento anarchico russo,
attraverso le biografie di coloro che, nell'800, hanno formulato
il pensiero etico, sociale e politico dell'anarchismo e/o che,
durante gli anni della rivoluzione, hanno militato in Russia
e negli altri Paesi del mondo. Conosciamo di meno o non conosciamo
affatto le figure di coloro che, travolti dal bolscevismo nella
sua versione leninista e stalinista, sono stati cancellati dalla
memoria del movimento. Figure che, pur facendo parte della sua
storia, non hanno mai potuto accedere ad un riconoscimento storiografico.
Il libro apre una pagina nuova relativa agli anarchici vittime
dimenticate della repressione spietata dell'anarchismo in Russia,
durante la progressiva conquista del potere e all'indomani della
definitiva presa del potere bolscevica. Il libro contiene oltre
alla autobiografia di un'anarchica morta a 29 anni nel Gulag
delle isole Solovki, dove era stata imprigionata, fucilata per
le sue idee e per la sua ribellione alla oppressione stalinista,
anche parte della documentazione penale che la riguardò,
la prefazione dello scrittore Olivier Rolin e la postfazione
di Irina Flige. La storia della breve vita di Evgenija Jaroslavskaja-Markon,
vissuta come una meteora fiammeggiante nel cielo nero del comunismo
leninista, è emersa casualmente dal ritrovamento negli
Archivi russi sul Gulag della sua autobiografia, insieme ad
una fotografia, che per la sua espressività difficilmente
si dimentica e che è stata riprodotta sulla copertina
del libro. Il ritrovamento è avvenuto grazie al precitato
scrittore che lavorava negli Archivi in vista della preparazione
di un suo romanzo. Nel quadro costituito dalla spaventosa tragedia
del popolo russo, che ha iniziato la rivoluzione, ma che ben
presto viene piagato e piegato dalla burocratica piramide sociale
che si sta organizzando e costruendo sulle ultime ceneri della
rivoluzione, si leva la voce ribelle di Evgenija Jaroslavskaja-Markon.
Giovanissima entra a far parte integrante di quel grande sogno
di emancipazione universale e dopo un'iniziale adesione al bolscevismo,
la futura autrice dell'autobiografia, delusa, abbraccia le idee
anarchiche. A queste resterà fedele fino alla fine. Tra
la prima dichiarazione di fede e l'imprigionamento nel Gulag,
si snoda una vita affettiva, sociale e militante intensa, ricca
di relazioni sociali e politiche con gli ambienti anarchici
e menscevici dell'emigrazione a Parigi, raccontata nel suo scritto
con accenti vividi e toccanti. Evgenija Jaroslavskaja-Markon
esiliandosi a Parigi potrebbe salvarsi con il suo compagno,
ma condividendo di fatto la sua nostalgia della Russia, vi rientra.
Finiti nel Gulag, entrambi vengono fucilati; per primo il suo
compagno, per aver tentato di fuggire, e successivamente lei,
per averlo aiutato in tale tentativo. Fra l'uno e l'altro evento,
Evgenija Jaroslavskaja-Markon, laureata in filosofia e proveniente
da una famiglia ebrea di studiosi, diventa una ladra, non si
riesce a capire per quale motivo: se per necessità, scelta
ideologica oppure per disperazione. Conosciamo
la storia degli anarchici russi e del movimento anarchico russo,
attraverso le biografie di coloro che, nell'800, hanno formulato
il pensiero etico, sociale e politico dell'anarchismo e/o che,
durante gli anni della rivoluzione, hanno militato in Russia
e negli altri Paesi del mondo. Conosciamo di meno o non conosciamo
affatto le figure di coloro che, travolti dal bolscevismo nella
sua versione leninista e stalinista, sono stati cancellati dalla
memoria del movimento. Figure che, pur facendo parte della sua
storia, non hanno mai potuto accedere ad un riconoscimento storiografico.
Il libro apre una pagina nuova relativa agli anarchici vittime
dimenticate della repressione spietata dell'anarchismo in Russia,
durante la progressiva conquista del potere e all'indomani della
definitiva presa del potere bolscevica. Il libro contiene oltre
alla autobiografia di un'anarchica morta a 29 anni nel Gulag
delle isole Solovki, dove era stata imprigionata, fucilata per
le sue idee e per la sua ribellione alla oppressione stalinista,
anche parte della documentazione penale che la riguardò,
la prefazione dello scrittore Olivier Rolin e la postfazione
di Irina Flige. La storia della breve vita di Evgenija Jaroslavskaja-Markon,
vissuta come una meteora fiammeggiante nel cielo nero del comunismo
leninista, è emersa casualmente dal ritrovamento negli
Archivi russi sul Gulag della sua autobiografia, insieme ad
una fotografia, che per la sua espressività difficilmente
si dimentica e che è stata riprodotta sulla copertina
del libro. Il ritrovamento è avvenuto grazie al precitato
scrittore che lavorava negli Archivi in vista della preparazione
di un suo romanzo. Nel quadro costituito dalla spaventosa tragedia
del popolo russo, che ha iniziato la rivoluzione, ma che ben
presto viene piagato e piegato dalla burocratica piramide sociale
che si sta organizzando e costruendo sulle ultime ceneri della
rivoluzione, si leva la voce ribelle di Evgenija Jaroslavskaja-Markon.
Giovanissima entra a far parte integrante di quel grande sogno
di emancipazione universale e dopo un'iniziale adesione al bolscevismo,
la futura autrice dell'autobiografia, delusa, abbraccia le idee
anarchiche. A queste resterà fedele fino alla fine. Tra
la prima dichiarazione di fede e l'imprigionamento nel Gulag,
si snoda una vita affettiva, sociale e militante intensa, ricca
di relazioni sociali e politiche con gli ambienti anarchici
e menscevici dell'emigrazione a Parigi, raccontata nel suo scritto
con accenti vividi e toccanti. Evgenija Jaroslavskaja-Markon
esiliandosi a Parigi potrebbe salvarsi con il suo compagno,
ma condividendo di fatto la sua nostalgia della Russia, vi rientra.
Finiti nel Gulag, entrambi vengono fucilati; per primo il suo
compagno, per aver tentato di fuggire, e successivamente lei,
per averlo aiutato in tale tentativo. Fra l'uno e l'altro evento,
Evgenija Jaroslavskaja-Markon, laureata in filosofia e proveniente
da una famiglia ebrea di studiosi, diventa una ladra, non si
riesce a capire per quale motivo: se per necessità, scelta
ideologica oppure per disperazione.
A pochi passi dalla fucilazione spiega agli inquirenti, che
stanno istruendo il processo contro di lei, che: “Scrivo
questa autobiografia non per voi, organi inquirenti (se fosse
servita solo a voi, non mi sarei nemmeno sognata di scriverla!).
Semplicemente, ho voglia di “ imprimere” la mia
vita sulla carta, ma di carta non riesco a trovarne, tranne
che nell'Ufficio informazioni e indagini”.
Durante la lettura di questo libro, immaginiamola nella sua
cella, sola, prossima alla condanna capitale che si aspetta,
ma salda, mentre traccia sulla carta e tramanda la passione,
la sensibilità, il coraggio, la curiosità intellettuale
e la ribellione all'ingiustizia, che sono state le caratteristiche
principali della sua straordinaria personalità.
Enrico Calandri
Malattie psichiatriche in aumento/
Fermare l'epidemia è possibile?
“Se disponiamo di trattamenti davvero efficaci per i
disturbi psichiatrici, perché la malattia mentale è
diventata un problema di salute sempre più rilevante?
Se quello che ci è stato raccontato finora è vero,
cioè che la psichiatria ha effettivamente fatto grandi
progressi nell'identificare le cause biologiche dei disturbi
mentali e nello sviluppare trattamenti efficaci per queste patologie,
allora possiamo concludere che il rimodellamento delle nostre
convinzioni sociali promosso dalla psichiatria è stato
positivo. (...) Ma se scopriremo che la storia è diversa
- che le cause biologiche dei disturbi mentali sono ancora lontane
dall'essere scoperte e che gli psicofarmaci stanno, di fatto,
alimentando questa epidemia di gravi disabilità psichiatriche
- cosa potremo dire di aver fatto? Avremo documentato una storia
che dimostra quanto la nostra società sia stata ingannata
e, forse, tradita.”
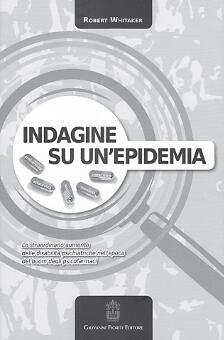 Il
libro di Robert Whitaker Indagine su un'epidemia. Lo straordinario
aumento delle disabilità psichiatriche nell'epoca del
boom degli psicofarmaci (edizioni Giovanni Fioriti, Roma
2013, pp. 392, € 26,00) è un percorso, uno studio
storico e scientifico dalla nascita degli psicofarmaci fino
a oggi. La domanda di partenza è come mai, nell'era del
boom degli psicofarmaci, c'è un aumento delle disabilità
psichiatriche? Il
libro di Robert Whitaker Indagine su un'epidemia. Lo straordinario
aumento delle disabilità psichiatriche nell'epoca del
boom degli psicofarmaci (edizioni Giovanni Fioriti, Roma
2013, pp. 392, € 26,00) è un percorso, uno studio
storico e scientifico dalla nascita degli psicofarmaci fino
a oggi. La domanda di partenza è come mai, nell'era del
boom degli psicofarmaci, c'è un aumento delle disabilità
psichiatriche?
Se davvero sono avvenuti questi progressi ci dovremmo aspettare
una riduzione dei pazienti in psichiatria, che dovrebbe essere
ancor più evidente con l'avvento degli psicofarmaci di
seconda generazione, dal 1988 in poi. Invece il numero dei casi
di persone che hanno una disabilità cronica dopo l'uso
degli psicofarmaci è in aumento. Gli psicofarmaci, oltre
ad agire solo sui sintomi e non sulle cause della sofferenza
della persona, alterano il metabolismo e le percezioni, rallentano
i percorsi cognitivi e ideativi, contrastando la possibilità
di fare scelte autonome, generano fenomeni di dipendenza e assuefazione
del tutto pari, se non superiori, a quelli delle sostanze illegali
classificate come droghe pesanti, dalle quali si distinguono
non per le loro proprietà chimiche o effetti, ma per
il fatto di essere prescritti da un medico e commercializzate
in farmacia.
Le cause biologiche dei “disturbi mentali” sono
ancora lontane dell'essere scoperte; invece sono gli psicofarmaci,
dagli studi scientifici che Whitaker ci mostra, che presi a
lungo andare, portano a gravi squilibri chimici nel nostro cervello.
Nella nostra società è dato per scontato dalla
maggioranza della popolazione che la depressione è associata
ad una mancanza di serotonina, ma come ci spiega bene il libro
“indagine su un'epidemia” non c'è nessuno
studio scientifico che lo dimostra.
Negli ultimi 40 anni, la psichiatria ha rimodellato, in profondità,
la nostra società. Attraverso il suo Manuale Diagnostico
e Statistico (DSM), la psichiatria traccia la linea di confine
tra ciò che è normale e ciò che non lo
è. La nostra comprensione sociale della mente umana,
che in passato nasceva da fonti di vario genere, ora è
filtrata attraverso il DSM. Quello che finora ci ha proposto
la psichiatria è la centralità degli “squilibri
chimici” nel funzionamento del cervello, ha cambiato il
nostro schema di comprensione della mente e messo in discussione
il concetto di libero arbitrio. Ma noi siamo davvero i nostri
neurotrasmettitori?
L'allargamento dei confini diagnostici favorisce il reclutamento,
in psichiatria, di un numero sempre più alto di bambini
e adulti. Oggi a scuola sono sempre di più i bambini
che hanno una diagnosi psichiatrica e ci è stato detto
che hanno qualcosa che non va nel loro cervello e che è
probabile che debbano continuare a prendere psicofarmaci per
il resto della loro vita, proprio come un “diabetico che
prende l'insulina”.
Fermare l'epidemia è possibile? Forse rompendo il legame
fra psichiatria e multinazionali produttori dei farmaci, e se
gli psichiatri ascoltassero i loro pazienti su quello che hanno
da dire sui gravi effetti collaterali, sarebbero in pochi a
proseguire un trattamento psicofarmacologico a lungo termine.
Collettivo Antipsichiatrico Antonin Artaud-Pisa
antipsichiatriapisa@inventati.org
www.artaudpisa.noblogs.org
|

