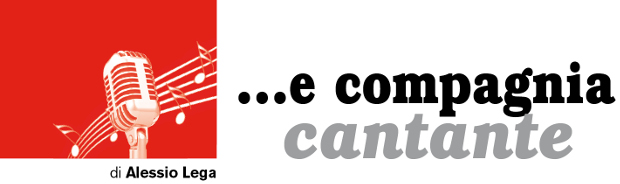
Le canzoni di Michelangelo
Michelangelo Ricci è un sublime orco. Un Bud Spencer
con la coscienza teatrale di Carmelo Bene, e si muove leggiadro
e squassante per le quinte teatrali del suo “Teatro Dell'Assedio”,
la compagnia, scuola e nave spaziale, che ha fondato e dirige
come un capitano di vascello pirata, con dentro tanti bei talenti,
ma senza primi-attori e prime-donne. Col “Teatro dell'Assedio”
Michelangelo propone spettacoli lievi e circensi (pensate che
uno dei loro massimi successi si basa sulle bolle di sapone).
Sono spettacoli corali e coesi, avanguardistici e godibili,
“riviste brechtiane”, monologhi laceranti, balli
sconvolgenti e coinvolgenti, dove si perde il preciso distinguo
fra teatranti e pubblico, irrispettosi e armonici: spettacoli
anarchici.
Per la verità io Michelangelo Ricci l'ho conosciuto
nell'ambito della rassegna del Club Tenco, per il quale ha curato
sovente le regie teatrali: si sa che noi cantanti, in special
modo i cantautori, siamo bestie allergiche alla disciplina del
palco, che in realtà non è che una grammatica
espressiva. Convinti come siamo che il nostro “messaggio”
basti a se stesso, soprattutto se supportato dalla dimensione
essenziale e autonoma del cantante-chitarrista, difficilmente
ci prestiamo alle ragionevoli indicazioni del regista. Alle
prese con tanta indisciplina, Michelangelo riusciva comunque
a conferire un sapore drammaturgico all'insieme delle performances,
aiutato dal suo talento nel giocare con fondali e luci, perché
il suo apparente “casinismo” cela un grande rigore
e una ferrea competenza: figlio di uno scultore, Ricci ha coscienza
plastica e dominio della scenografia. E in ogni caso è
perfettamente in grado di mettersi al servizio delle canzoni,
perché è lui stesso un ottimo autore cantante,
ma questo io l'ho scoperto solo dopo, e ora che è uscito
il suo disco, avete il modo di scoprirlo anche voi.
Michelangelo lo si conosce meglio dopo lo spettacolo, quando
di trattoria in taverna, il suo condensato di apparente severità
e reale dedizione si scioglie in un piglio gaudente e ridanciano,
da ottimo compagnone di mangiate e di bevute. È allora
che ci si accorge che l'omone si è trascinato dietro
per tutto il tempo – al teatro, al bar, in trattoria e
di nuovo in osteria e poi in albergo – una chitarra. Non
si fa pregare, la brandisce e si produce in una serie di canzoni
originalissime, spietate, ipnotiche... alla prima ci si stupisce,
alla terza si dice “però”, alla decima ci
si convince di essere di fronte a un vero autore con una sua
voce, una sua poetica, una sua scrittura, un suo piglio, una
sua musicalità, un suo modo di scandire parole a tempo
o violentare la metrica. Queste canzoni – pur nella loro
autonomia –risentono ovviamente del mestiere drammaturgico
del loro autore, e si configurano spesso come ritratti di personaggi
stravaganti, eccessivi, di cattivi soggetti, con pessime intenzioni,
immersi in un contesto peggiore di loro – il Down, il
Cieco, un'incredibile figlia di genitori drogati e perversi,
un sindaco privo di scrupoli – non attirano su di sé
alcuna compassione, assistiamo incuriositi e un po' rabbrividendo
alla loro evoluzione, a un momento di affermazione prodromo
di un'inevitabile caduta, comete buie che hanno brillato per
un attimo e poi subito si sono schiantate.
È venuto il momento della scuola
Tutti avevano una maestra e io una sola
Tutti che lottavano contro i professori
E io dovevo calmarmi coi dottori
E i ragazzi e le ragazze giocavano un gioco strano
Mentre io restavo da solo con la mia mano
Ero down, molto down, ero veramente molto molto down
(Meno down)

Mia madre si faceva l'eroina
Mio padre la cantina
Ed insieme un po' di crack
Io stavo distesa sulla schiena
E invece della cena
Guardavo la TV
Restavo in silenzio in controsenso
Fra ciò che penso e ciò che sento
Perché non c'è niente che mi va'.
(La figlia)
Tutti questi personaggi parlano in prima persona, tutti gridano
una loro verità. Queste canzoni le abbiamo sentite nei
cori degli spettacoli del Teatro dell'Assedio... altre però
se ne sono aggiunte, dello stesso tenore, o anche con qualche
raro momento lirico emotivo “La canzone del Cambi”,
“Amanti” (forse l'unica canzone d'amore) e tutte
insieme sono confluite, interpretate dall'autore, nel primo
disco appena uscito a nome Michelangelo Ricci, “Questo
lo so”.
Non è un disco perfetto sul piano della realizzazione,
certi arrangiamenti ci paiono affrettati e certi suoni anacronistici,
anche l'interpretazione talvolta ci pare un po' irrigidita sul
metronomo. Ma sono, diciamolo, peccati veniali, soprattutto
se si tiene conto di un'opera prima, nata in regime di autoproduzione.
L'originalità, la poesia, l'unità narrativa di
queste storie cantate compensano ampiamente certa precarietà
di realizzazione, mettendoci ci fronte a un esordio come non
ne sentivamo da tempo.
L'ultimo brano “Il globo industriale”, a mio parere
il più bello del disco, è una cupa martellante
fotografia della società ansiogena nella quel siamo incastrati.
Scavo le unghie me le levo
Il sangue mi consumo
Sudore dentro il fumo (...)
Braccato nei confini del reame
Io fuggo la mia fame
E trasporto sulla schiena
Il sudore e la catena(...)
Seduto davanti ad uno schermo
Io devo stare fermo
E cambiare un mio governo
Di un democratico padreterno
Del globo industriale
Io sono l'animale
Che solo deve contare
Rate in banca e poi votare.
E per la prima e ultima volta nel disco di Michelangelo si leva
l'ipotesi di una grande speranza di rivolta, l'idea che tutti
questi schiavi delle circostanze, della società, delle
famiglie, delle debolezze, riescano ad alzare gli occhi per
cogliere la possibilità di una rivolta, che se fosse
collettiva, potrebbe aprire un'ipotesi di vera libertà,
ovvero di vera vita degna.
Ma nel cielo c'è un pensiero
Che se poi fosse vero
E levasse il velo scuro
Potremmo per davvero
Trovare un altro modo.
Varsavia val bene una mossa. Un manipolo di canta-poeti in Polonia
Ciò che si racconta qui di seguito non è qualcosa
di definito: un artista, un disco, un collettivo musicale...
piuttosto degli appunti, presi sul diario, di qualcosa che mi
è successo quasi per caso, nel mio venire e andare su
e giù per l'Europa nei luoghi del canto, e che meriterà
in seguito maggiori approfondimenti, ma che intanto voglio condividere.
Come forse ricorda qualche mio lettore, sono anni e anni che
inseguo la canzone d'autore dell'Est, quella che ebbe uno straordinario
ruolo di resistenza culturale negli anni bui del Socialismo
di Stato. Ho parlato su queste pagine di artisti poco o niente
conosciuti da noi, ma leggendari in patria: i russi Visockji
e Galich, i cechi Kryl e Nohavica, il polacco Kaczmarski...
e poi ho sovente parlato del mio preferito, Bulat Okudzava,
il padre dei cantautori sovietici che sono anni che studio e
traduco, preparando un sontuoso progetto che vedrà presto
la luce.
In questo lavoro sono stato guidato nell'ultimo lustro dalla
giovane competentissima slavista Giulia De Florio, che ogni
tanto – come ogni studioso che si rispetti – gira
il mondo per convegni e che prova a raccontare che c'è
un cantautore italiano che tanto si dà da fare per diffondere
la cultura musicale e poetica slava.
A giugno Giulia mi fa “ti andrebbe di partecipare a un
paio di concerti collettivi a Varsavia, con cantautori polacchi,
russi e cechi... non ci sono soldi, giusto un rimborso spese,
ma è una bella occasione di diffusione e confronto”...
beh, perché no, dico io, che se c'è da cantare
non mi tiro mai indietro.
Però 'sti polacchi spariscono per un mese, più
volte sollecitati confermano in linea di massima ma danno risposte
evasive quando si chiede più precisamente di cosa si
tratta, e poi dove, e quali sono le distanze e come mai...
Insomma arriviamo a una settimana dalla partenza e io ancora
non so di preciso dove e a che ora canterò. A questo
punto mi vesto di professionismo ferito e dico a Giulia –
che continuava a fare l'intermediaria, rassicurandomi sul fatto
che gli slavi sono fatti così, ma poi gli impegni li
rispettano – che insomma... io devo partire così
alla cieca, e che non è serio tenermi all'oscuro...
In realtà la paura mi fotteva: non conosco ovviamente
il polacco, non conosco il russo (sono giusto in grado di chiedere
acqua, vodka, crespelle e tè verde), parlo perfettamente
il francese (che sarebbe stato utilissimo ai tempi di Tolstoj
e Chopin, ma ormai non più) e tutto il mio lessico inglese
si ferma ai titoli delle canzoni dei Beatles e di Simon e Garfunkel.
Come faremo a capirci? che gli dico io a questi?
E poi l'attuale situazione politica polacca mi preoccupa non
poco... ma, mi dico anche, se uno dovesse giudicare noi italiani
dal nostro Governo, non è che ci faremmo un figurone.
Finalmente in corner arrivano definitive conferme, orari e luoghi
dei concerti, e... vedo che il primo è nel museo della
diocesi e il secondo nel giardino di una chiesa.
Vabbé, chi non va non vede, Varsavia varrà bene
una messa...
Al mio arrivo in aeroporto trovo il cantautore polacco che
organizza tutto l'evento Antoni - Tolek - Muracki... io parlo
italiano e francese, lui polacco, russo, ceco, e un inglese
che, per quel nulla che posso giudicare, non mi sembra oxfordiano.
Scoppiamo a ridere, ci abbracciamo e iniziamo a chiacchierare
per tre giorni ininterrotti (o meglio interrotti solo dai concerti)
di tutto, ma proprio di tutto, e soprattutto di musica. La sua
famiglia mi accoglie, ho l'onore di passare dallo studio della
moglie di Tolek, ottima pittrice con una fissa morandiana per
le finestre, le porte, le case... intanto hanno deciso che,
non avendo ancora fatto colazione, devo mangiare tre (3) uova
col pane nero e i meravigliosi onnipresenti cetriolini, poi
raggiungo Tolek nello studio e cominciamo a suonarci, io in
italiano lui in polacco, le canzoni di Okudzava. Si affaccia
una torma di biondissimi nipoti, figlie, ognuno riprende in
una lingua diversa un ritornello.
Chiedo lumi sulla canzone d'autore in Polonia. Vengo a conoscenza
della straordinaria tradizione del Cabaret musicale che, fino
agli anni Sessanta, ha rappresentato la punta di diamante della
cultura popolare: una boccata di ossigeno e surrealistica intelligenza,
qualcosa fra Karl Valentin e i Gufi, ma più cubista,
con musiche straordinariamente complesse. Era tutto ciò
che di buono passava la televisione ai tempi dell'ottuso Gomulka
(“un cretino totale” mi dice in italiano Tolek,
pescando le parole chissà da dove).
Sono cascato bene, Antoni Muracki è una sorta di enciclopedia
musicale, conosce tutto, compone ogni sorta di canzone in molti
stili diversi: canzoni di protesta, canzoni buffe, canzoni per
bambini, suona la chitarra con grande perizia e con parecchio
swing, mette in musica i più grandi poeti contemporanei,
e ovviamente adatta le canzoni russe e ceche: in particolare
ha dedicato dei lavori di grande rilievo a Jaromir Nohavica,
rendendolo veramente popolare nel suo Paese. Infine scrive delle
bellissime canzoni d'amore... e io spericolatamente, un po'
con l'aiuto dei traduttori online e molto basandomi sull'intuizione,
nella notte ne traduco una breve, semplice e bellissima, che
finiremo per cantare assieme sul palco:
Ti amo da quel tempo là che ogni cosa mi commuove
la curva lenta dell'età di un corpo che si muove
una scintilla un'ovvietà l'odore dei capelli
e dalla notte tornerà col canto degli uccelli
e il Mondo chiama, il Mondo va dal supermercato
alla via lattea e anche più in là, nel cielo
sconfinato
ed io che sto col naso in su, a volte mi ci perdo
e torno solo e vedo il tuo sorriso e mi ricordo
perciò ti amo senza la risposta alle domande
come il silenzio che sa già la strada che ci attende
la ricevuta sul comò della lavanderia
e tu già sai quello che so, della tua vita e della
mia.
Nel frattempo bisogna correre sul luogo del concerto, portarsi
dietro e montare l'impianto – sì, proprio come
facciamo talvolta noi in Italia, paladini dell'autoproduzione
e dell'organizzazione dal basso – cominciano ad arrivare
gli altri musicisti: Jacek Beszczyński, splendido volto
scavato e ieratico, con occhi profondi e ironici e la voce rauca
di un lupo di mare, un Joseph Conrad con la chitarra che canta
la sua versione della tradizionale “Dos kelbl”,
canto yiddish reso noto nel mondo da Joan Baez (“Dona
Dona”) e in italia da Herbert Pagani (“Un capretto”).
In realtà Jacek come autore è specializzato soprattutto
in canzoni per bambini, concepite lavorando a stretto contatto
con la sua compagna pedagogista, ne ha scritte centinaia diventate
popolarissimi fra i bimbi polacchi. Si affaccia anche Tomek
Kordeusz, fenomenale chitarrista compositore, molto attento
a sostenere un gioco di pieni e di vuoti musicali, di notevolissima
raffinatezza. Infine arrivano da Brno il ceco Jiří
Vondrák, che ebbe l'imprimatur dallo stesso Okudzava,
e che con delicatezza celestiale e col candore degno di un Soldato
Svejk della canzone, snocciola strofe di miele e veleno, e il
russo Alexey Kudryavtsev, impressionante interprete di Visockij,
denso, materico ed eccessivo, con un piglio rock-moscovita.
In questa girandola di personaggi e grugni notevolissimi, tutti
con la loro personalità, ma pronti a scambiarsi canzoni
e parole, a duettare, a raccontarsi, io mi ritrovo un po' frastornato,
ma già in famiglia... e il pubblico polacco si lascia
conquistare sia dalla captatio benevolntiae delle canzoni del
loro compianto Kaczmarski che eseguo in italiano, sia dai miei
canti dedicati all'emigrazione.
Si finisce in un trionfo, e si torna alla casa di Tolek, dove
è imbandita una cena collettiva (per la verità
avevamo fatto anche un'abbondante merenda, abbondantemente innaffiata
di birra) alla quale portiamo un contributo alcolico. E qui
nell'entusiasmo accetto la sfida di pasteggiare a vodka. Poco
male, il letto è vicino. Il giorno dopo – come
dicevo – si replica nel cortile di una chiesa, attenti
a non disturbare con le prove la cerimonia matrimoniale che
intanto di svolge dentro... appurato che non solo il mio repertorio,
ma quello di nessuno dei presenti è particolarmente religioso,
chiedo lumi su quella strana location, e mi rispondono che negli
anni della censura le chiese erano fra i pochi luoghi che garantivano
una certa libertà di espressione al loro interno, non
solo per ciò che atteneva al culto, ma anche per canzoni
e performance libertarie, purché nel rispetto reciproco.
Però...
Le ultime chiacchere, le ultime canzoni con Tolek, che mi svela
il lato più intimo del suo repertorio e la metafora dell'aquilone
con la quale ha raccontato la morte della sua mamma... la commozione
è lì a due passi, maledetti slavi emotivi! Riparto
a malincuore per Milano, con una folla di idee per la testa,
con una lingua in più da imparare, e con la precisa sensazione
di aver allargato non solo la famiglia musicale ma anche quella
dei miei affetti.
Alessio Lega
|

