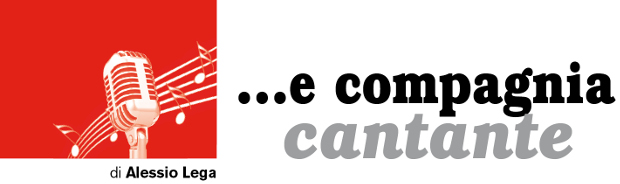
Pierre Mac Orlan/
Dal canto dei marinai al “viaggio immobile”
La tradizione per sfondo
Una delle più grandi tradizioni della musica popolare
dei porti del nord riguarda le “canzoni dei marinai”,
una tradizione di canti di lavoro e di canti narrativi, canti
collettivi di sole voci (talvolta con qualche accenno di elementari
polifonie) e canti individuali di lunghe e tenebrose storie
accompagnate dall'organetto, o più raramente dal violino
e dalla chitarra. La sua origine - come spesso avviene per i
canti di lavoro - nasce dalla necessità professionale
di darsi il ritmo per compiere una serie di operazioni collettive,
di sforzi necessariamente congiunti: issare l'ancora, ammainare
le vele, calare le scialuppe per la pesca alla balena, ecc.
Le “chansons des marines” sono strutturate con un
solista che lancia una frase «C'est Jean-François
de Nantes» e il coro risponde (agendo contemporaneamente
sull'argano) «Oué, oué, oué»,
il solista riprende «Gabier de la Fringante, oh mes bouées»
e il coro «Jean-François».
Sulle navi si cantava per lavorare ma anche per riposarsi, durante
le lunghissime traversate o bonacce si cantavano lunghe epopee
narrative o canto di rivendicazione professionale in equilibrio
fra l'ironia e la protesta, come questo splendido testo relativo
al durissimo lavoro dei “calfattori” (coloro che
impermeabilizzavano il fondo delle navi).
Quando una nave va alla rada
Come quella che vedete là
Non sapete la fatica e la pena
Che si devono dare i ragazzi di sotto
Fra le stoppe incatramate
Guardate bene questi ragazzi
È la mia scialuppa, il mio equipaggio
Sono tutti calfattori
Si vedono dappertutto dei ministri
Senatori e deputati
Carpentieri e falegnami
Persino doganieri in pensione.
Si trovano donne delle pulizie
Nutrici e soldataglia
Manca il lavoro, maledizione
Solo per i calfattori.
Lo giuro sul remo di bordo
Che avevamo tanto da sgobbare
Che vidi la mia scialuppa
Ogni stagione sputare il sangue
Ma oggigiorno, parola mia
Addio mazzuole e gomene
Con tutte le vernici acriliche
Non servono calfattori.
Ora che il bordo è di lamiera
Non c'è più modo di cavare un soldo
Soppressa la calafatteria
Che roba bella questo progresso!
Che schifo di lavori faranno i nostri figli?
Saranno ingegneri o avvocati?
Tanto vale dar fuoco ai remi
Niente più calfattori!
In Francia il luogo d'elezione delle “chansons des marines”
sta in quella costa a Nord-Ovest che va dal fondoschiena della
Bretagna alla fronte martoriata della Normandia, nelle canzoni
stesse abbondano i toponimi costieri: La Rochelle, Lorient,
Concarneau, Brest, Roscoff, Lannion, Saint-Malo, Cancale, Le
Havre, Calais, come quelli di alcune delle principali città
dell'entroterra: Nantes, Rennes, Caen, Rouen. Nella dirimpettaia
Inghilterra si inciampa sovente nelle medesime melodie e nelle
stesse storie, arricchite da canti specifici di pesca e da reminiscenze
della tradizione piratesca (ricordate il celeberrimo “quindici
uomini/sulla cassa del morto/e una bottiglia di rum” dell'Isola
del Tesoro di Stevenson?), il repertorio spesso è
comune e gli scambi anglo-francesi estremamente fluidi, essendo
i marinai sovente poliglotti e arricchendo il loro linguaggio
di infinite influenze, prima fra tutte il gergo specifico dei
porti.
Dalla “chanson réaliste”
ai grandi cantautori
Un repertorio così ramificato e significativo, presente nel patrimonio condiviso della memoria orale, rappresenta un'ineludibile fonte di ispirazione e di confronto: abbiamo già alluso a Stevenson, immenso narratore nutrito dalle leggende popolari, nella tradizione francofona lo ritroviamo dai feuilleton di consumo fino alla letteratura accademicamente riconosciuta, nei versi sghembi del maledetto e anarcoide Tristan Corbière (figlio di un capitano e scrittore di storie di marineria), in quelli dell'onirico Gérard de Nerval, ma anche in un poeta eminentemente urbano come Baudelaire.
Ovviamente è però nella canzone che le “uova poetiche” depositate da Gabbiani e Albatri sono state meglio covate e più si sono dischiuse. Gli ambienti dei porti sono ambienti estremamente equivoci, luoghi per loro natura fuori dal controllo, riverberano dell'ambiguità sessuale che è un topos marinaio, sono fitti di avventurieri, truffatori, giocatori di professioni, contrabbandieri, sono luoghi cosmopoliti, multiculturali, rissosi e frequentati da ogni forma di prostituzione. Una sorta di vivaio di tutto ciò che di più affascinante e spaventoso la borghesia a cavallo fra otto e novecento potesse figurarsi. Non c'è da stupirsi dunque se la “canzone realista”, che conobbe il massimo splendore fra gli anni trenta e quaranta con Damia e Frehel, culminando e finendo con Edith Piaf, riverberi spessissimo atmosfere, reminiscenze e ritmi delle canzoni marinare. I cantautori fioriti fra gli anni cinquanta e settanta tributarono profondi omaggi al genere: Brassens con “La Marine” (da un testo del poeta Paul Fort) e con “Jehan l'Advenu” (Norge-Yvart), Brel con la meravigliosa “Amsterdam” e con la quasi filologica “L'éclusier” (che ricorda molto “Le calfat” che abbiamo citato qualche riga sopra), Ferré con “Rotterdam”, Renaud con “Des Que Le Vent Soufflera” e “Trois matelots”, fino ad arrivare ai giorni nostri col rock dei maledettissimi Noir Desir “Aux sombres héros de l'amer” e la “nuova scena” dei Têtes Raides o della Tordue.
In verità le leggendarie atmosfere brumose della stessa Parigi, i “quai”, ovvero i larghi moli sul Lungosenna, con le centinaia di chiatte che facevano da abitazione, bar, trattoria, trasformavano anche la metropoli per antonomasia in una sorta di città portuale e la sua Bohème in una collettiva avventura salmastra, soprattutto per merito di tre narratori eccezionali quali Simenon, Malet e il loro “maestro” Pierre Mac Orlan.
Dagli anni settanta, con la rinnovata passione del folklore e con la sua strumentalizzazione da parte dei movimenti indipendentisti-nazionalisti, le canzoni dei marinai sono divenute un repertorio molto turistico: le si può ascoltare, in meccaniche versioni banalizzate e oratoriali, in ogni pub della costa francese e in alcuni festival appositamente promossi dalle pro-loco bretoni e normanne.
Percorsi di un avventuriero immobile
Chi più di tutti contribuì a dare nuova linfa
e una precisa identità ai canti dei marinai, alle storie
dei porti, ai canti di argomento militaresco (in particolar
modo relativi alla Legione Straniera), alle atmosfere “montmartrois”,
fondendo tutte queste diverse scenografie in un'unica epopea
culturale - che noi definiremmo globalmente canzoni della “mala”
o della “leggera” - fu una delle più singolari
(e per noi italiani quasi sconosciuta) figure della letteratura
del novecento francese, Pierre Mac Orlan. Lo fece in un buon
numero di romanzi e novelle (e nei film da essi tratti), nei
saggi rievocativi, negli articoli, ma soprattutto in un canzoniere
non piccolo ma nemmeno sterminato (una cinquantina di brani)
che per valore lo collocano all'apice della storia della canzone
d'autore. Un apice a noi ignoto.
Mac Orlan (pseudonimo di Pierre Dumarchais 1882-1970) era un
provinciale della piccolissima borghesia, sbarcato a Parigi
- come tanti suoi contemporanei in cerca di fortuna - per tentarvi
la carriera di pittore. Fu amico di Apollinaire, di Picasso,
del proto-cantautore Bruant, sposò la figliastra del
mitologico Père Frédé (il padrone del Lapin
Agile, ex Chat Noir, il più famoso dei cabaret di Montmartre).
Quando quell'ambiente non ebbe più niente da dare alla
sua immaginazione si trasferì in una casa di campagna
(dopo la morte divenuta la sua casa-museo) e vi restò
tutto il resto della sua lunga vita, uscendo il meno possibile.
Nei primi anni della fame parigina era sopravvissuto scrivendo
romanzi pornografici, il che gli permise di reinventarsi come
scrittore tout-court di storie d'avventura: “Quai
des brumes”, “Il porto delle nebbie” il suo
libro più famoso, divenne anche un film celeberrimo sceneggiato
da Prévert, diretto da Carné e interpretato da
Gabin. La sua narrativa, al contempo guittesca e metafisica,
fu forse - per interessi e qualità letteraria - l'ultima
grande sintesi di quella tradizione che portava da Villon a
Sue e Hugo, benché già impregnata delle inquietudini
novecentesche. Gli si riconosce uno stile impareggiabile, l'editore
Adelphi negli ultimi anni ne ha riproposto qualche libro in
italiano. Da sempre amante delle canzoni e strimpellatore di
fisarmonica, Mac Orlan, fra gli anni cinquanta e sessanta, compose
- con l'ausilio di qualche musicista fidato e per una sceltissima
rosa di interpreti quali Juliette Gréco, Germaine Montero,
Monique Morelli, Catherine Sauvage - il repertorio che in particolare
interessa noi.
|
| La copertina del libro di Pierre Mac Orlan Le chant de l'equipage |
«Mac Orlan inventa ricordi per chi non ne ha»
Questa lapidaria definizione di Brassens, che frequentò Mac Orlan negli anni sessanta, inchioda Pierre al suo ruolo più geniale e subdolo: strappate dal contesto e dall'equilibrio di una pagina letteraria, le storie appena accennate delle sue canzoni scavano qualcosa dentro, comunicano la nostalgia del non provato. Vi si trova la sapienza del miniaturista che in pochi versi dipinge un destino, la finezza psicologica del grande conoscitore di anime, la potenza evocativa del canto popolare. Ecco che il bagaglio condiviso delle “chansons de marines”, della loro semplicità misteriosissima, dei movimenti ritmici e melodici essenziali, diventa il sottofondo su cui si muovono questi personaggi dei quali conosciamo il nome e pochissimo altro. Ma dietro un nome c'è sempre un volto e col volto un destino. Prostitute che hanno smesso di fare quella vita, che si sono vendute a un solo marito che non amano, ma che non hanno più ritrovato la purezza del loro primo giro sui cavallini di legno di una giostra di paese, come nel capolavoro “La chanson de Margaret” (interpretata in modo sublime da Juliette Gréco). Nelly - stesso nome del personaggio femminile del “Porto delle nebbie” - che prende l'ultima sbronza prima di veder sparire nella bruma il suo amore sorto dal nulla, inghiottito da una legione straniera. Rose-de-bois con i suoi occhi ribelli da zingara, che combatte la fame sempiterna raspando nelle gamelle dei soldati.
Mac Orlan sa bene come ogni parola, più che svelare, approfondisce il mistero dell'esistenza. Questo reazionario raccontava solo storie di sottoproletari in rivolta, questo avventuriero - con pochissime eccezioni - non usciva mai di casa, quest'uomo non parlava mai di sé, ma per tutta la vita ha inseguito con la scrittura il fantasma del fratello anarchico, arruolato nella legione straniera e morto in battaglia col cranio trapanato.
Mac Orlan a Sanremo
Le canzoni di Mac Orlan - nemmeno a dirlo - sono in Italia del tutto sconosciute, un continente da esplorare. Su cortese sollecitazione del Premio Tenco, io e i miei collaboratori, abbiamo deciso di presentarne un piccolo florilegio, in versioni cantate in italiano, appositamente approntate per l'occasione. Oltre ai brani di Mac Orlan, qualche frammento di “Chanson des marines” e di canzoni d'autore a quelle ispirate, proveranno a fornire una mappa per quest'ennesimo viaggio nell'isola del tesoro della canzone mondiale. Se il prossimo 18 ottobre passate da Sanremo (dove si terrà la quarantunesima edizione della celebre Rassegna), proveremo a guidarvi in questa scoperta.
Fu più o meno nel ventisei
che Jean della Provvidenza Dei
entrò nel bistrot di soppiatto
la fronte bruciata dal sole
la bocca di poche parole
il sacco pesante sul petto
ma il vento si arrese sui fiordi
nel bar dei miei vecchi ricordi
c'era Langlois, Tizio e anche Coso
e c'ero io: la tipa francese
in cinque eravamo a riposo
nella taverna dell'irlandese
Coso e poi Tizio, al tempo che
c'era Langlois, l'Irlanda e me
*
Il vento che soffia dal mare
ci prende e ci fa navigare
così due ripresero il volo
un giorno dopo molti mesi
nel nulla sparirono quasi
avessero il diavolo al culo
così contemplammo l'assenza
Langlois, io e La Provvidenza
Facciamo i conti: restavo io
Langlois e poi questo Jean di Dio
senza un soldo più per campare
Langlois andò a riprendersi il mare
così restammo lì sulle spese
Jean della Provvidenza e la francese
*
Mi chiamano “Bocca Cucita”
mi disse guardando l'uscita
col cuore a una nave distante
se l'alba s'impone allo scuro
la sfida scavalca ogni muro
le troie si credono sante
puntando la vela sui flutti
partì come fanno un po' tutti
prima Langlois, Coso e poi Tizio
restavo io, sola come un vizio
che cerca compagni e bottiglie
nel bar delle mie meraviglie
ne scolai due per conto mio
per Jean e il resto alla grazia di Dio
*
Ma dove saranno i compagni
i giorni brevi come sogni
che gli anni poi hanno disfatto
Tizio e Coso andarono via
nella vuota scenografia
del vento più isterico e matto
che soffiando sui sogni miei
portò la Provvidenza Dei
e quando il vento fa tremare
quelle taverne dei porti di mare
e gonfia le vele al rimpianto
come un organetto col canto
negli anni venti, nei giorni passati
dove s'incontrano gli innamorati.
Alessio Lega
|

