|
architettura
Né servi né padroni:
utopie realizzabili
di Franco Bunuga
Recentemente sono stati pubblicati in traduzione italiana due libri fondamentali per capire l'opera di Yona Friedman, grande architetto utopico, inventore della Ville Spatiale e propugnatore delle Utopie Realizzabili.
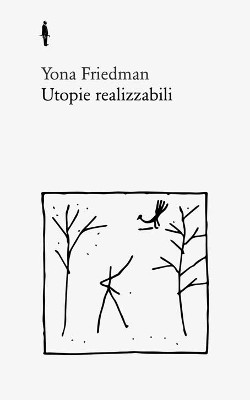
Il primo, fresco di stampa è:
Yona Friedman, Utopie Realizzabili, (Quodlibet Bis, Macerata,
2016, pp. 240, € 14,00) con l'aggiunta di un'importante
postfazione di Manuel Orazi che non era presente nella prima
edizione di Quodlibet del 2003. Il corpo principale del saggio
era apparso per la prima volta in Francia nel lontano 1974 e
viene da molti considerata l'opera più significativa
di Friedman.
Con una prosa semplice, senza note o citazioni specialistiche,
adiuvandosi di molti schemi e diagrammi, Yona Friedman dimostra
come sia possibile organizzare un ambiente urbano partendo dalla
comunità, da piccoli gruppi autogestiti che in autocostruzione
definiscono e formano il proprio ambiente. In questo testo Friedman
supera criticamente l'idea di Ville Spatiale che lo aveva
reso celebre internazionalmente e si sofferma sull'analisi dei
movimenti marginali esistenti nella società che possono
essere produttori di utopie. Mette in guardia dalla differenza
sottile tra utopie positive e negative (distopie o cacotopie)
e considera funzionali al suo progetto urbano quelle utopie
non paternaliste, libertarie ed egualitarie e non gerarchiche.
Yona Friedman, ebreo, nato nel 1923 a Budapest segue i corsi
di architettura con un permesso speciale, come auditore, senza
poter conseguire la laurea a causa delle leggi razziali in vigore
in quegli anni nell'Ungheria fascista alleata con Hitler. Fondamentali
per la sua formazione saranno anche i seminari che seguirà
a Budapest di due grandi intellettuali emarginati dal regime:
Kàrol Kerényi, il grande studioso della mitologia
greca e il fisico Werner Karl Heisenberg. Incarcerato per motivi
politici e poi liberato dall'Armata Rossa nel '45, si trasferirà
ad Haifa in Israele, dove finalmente si laureerà in architettura
e progetterà rifugi provvisori per gli immigrati e, allo
scoppio della guerra con gli arabi, trincee e linee di difesa.
Architetture mobili e provvisorie, la base di tutte le sue teorie
architettoniche ed urbane sino ad oggi.
Ad Haifa verrà in contatto anche con gli architetti del
razionalismo internazionale e con le teorie utopiche e libertarie
all'interno del Sionismo. Orazi ci ricorda che durante il mandato
inglese in Palestina, 1917-1948, “erano però presenti
linee di pensiero e di azione eterogenee e in molti casi alternative,
sia sul piano politico sia su quello architettonico: per esempio
l'opera di Erich Mendelsohn, molto legato al sionismo culturale
di Martin Buber, o ancora l'ideologia anti-urbana della città
giardino favorita nei primi anni Venti, in particolare dai sionisti
tedeschi, poi applicata da Richard Kauffmann e culminata nell'adozione
del piano di Patrick Geddes per Tel Aviv del 1924.” Teorie
che influenzarono le prime ricerche di Friedman. È forse
in questo ambiente che Friedman verrà a conoscenza della
Scuola di Edimburgo nata da Geddes e che risale alle radici
anarchiche di Pëtr Kropotkin ed Élisée Reclus.
Certo Yona Friedman non può essere considerato anarchico,
ma i suoi contatti con Michel Ragon a Parigi, all'epoca divenuto
figura preminente nella Federazione Anarchica Francese, che
lo inviterà nel gruppo di architetti libertari GIAP e
più tardi con Giancarlo De Carlo che lo ospiterà
spesso su Spazio e Società e col quale spesso
viene accomunato per la pratica della partecipazione, fanno
di lui un libertario, tanto che alcuni critici non esitano a
definirlo, in modo un po' superficiale, un anarchico individualista.
Certo, considerando il titolo di uno dei suoi libri Comment
vivre avec les autres sans être chef et sans être
esclave? (Come vivere con gli altri senza essere servi né
padroni) almeno qualche slogan fondamentale con noi lo condivideva.
|
| Brescia, Galleria Minini, 2009 - Franco Bunuga e Yona Friedman |
Autocostruzione e autogestione
Friedman presenta nel '56 il suo Manifeste de l'architecture
mobile al X Congresso Internazionale di Architettura Moderna
di Dubrovnick dove partecipa alla dissidenza del Team X. Si
trasferisce definitivamente a Parigi nel '57, nell'appartamento
che ancora occupa, e lì rielaborerà il suo modello
di Ville Spatiale: una megastruttura a scala sia urbana
che regionale composta da pilastri con ascensori verticali e
una piastra con ascensori orizzontali. Una grande struttura
tecnologica che si sviluppa al di sopra del paesaggio e delle
preesistenze urbane. Una sorta di Megastruttura – progettata
dagli architetti – sulla quale si diffonde una variegata
struttura abitativa progettata in autocostruzione ed autogestione
dai futuri abitanti, una “architettura mobile”.
Questa struttura ovviamente aveva bisogno di una grande fonte
di energia e fu presa molto sul serio dalla amministrazione
francese che negli anni del dopoguerra aveva un grande problema
di insediamenti abitativi e una disponibilità energetica
molto alta grazie al piano delle centrali nucleari, anche se
poi nulla venne realizzato.
La pubblicazione del testo Utopie Realizzabili fu anche
una presa di distanza di Friedman dal nucleare e un recupero
delle tecnologie alternative in un forte senso comunitario.
L'affermazione più importante di Yona Friedman in Utopie
Realizzabili è che solo l'autodeterminazione dell'utente
della struttura, dell'abitante, permette il corretto funzionamento
di un insediamento. L'autodeterminazione dell'abitante è
superiore a qualsiasi pianificazione che venga dall'alto e risolve
i problemi che nessun governo o progettista è in grado
di risolvere.
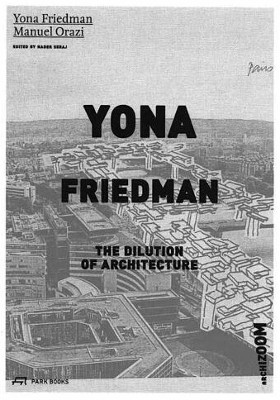 L'insediarsi
(così definisce il processo di autocostruzione da parte
dei settlers) è una sorta di atto rivoluzionario,
è un voto attraverso gli atti. I problemi dell'insediamento
non possono essere risolti da altri se non dalla comunità
degli effettivi utenti. Friedman prevede anche la costruzione
di orti urbani autosufficienti ed introduce il concetto di Urban
Village, il villaggio urbano come entità politica
e sottodivisione di ogni città di grandi dimensioni che
permetta la partecipazione dal basso ed una sorta di federalismo. L'insediarsi
(così definisce il processo di autocostruzione da parte
dei settlers) è una sorta di atto rivoluzionario,
è un voto attraverso gli atti. I problemi dell'insediamento
non possono essere risolti da altri se non dalla comunità
degli effettivi utenti. Friedman prevede anche la costruzione
di orti urbani autosufficienti ed introduce il concetto di Urban
Village, il villaggio urbano come entità politica
e sottodivisione di ogni città di grandi dimensioni che
permetta la partecipazione dal basso ed una sorta di federalismo.
Murray Bookchin proporrà idee molto simili nella sua
teoria della Citification. Tutte queste proposte sono
ancora oggi attuali e veramente rivoluzionarie.
La diluizione dell'Architettura
Nel 2015 era già uscito per i tipi della Park Books di Zurigo il saggio Yona Friedman The diluition of architecture a cura di Nader Seraj e con un doppio autore, Yona Friedman e Manuel Orazi (pp. 582, € 48,00). Un testo indispensabile sia per chi, come me, credeva di sapere tutto su Yona Friedman che per chi vuole accostarsi all'opera del grande maestro inventore della Ville Spatiale, uno dei guru di noi architetti sessantottini e grande riscoperta degli ultimi anni insieme a molti dei rappresentanti dell'architettura utopica e radicale a cavallo degli anni '60 e '70.
Questo libro nasce dalla pubblicazione della tesi di dottorato del 2007 di Manuel Orazi in Storia dell'Architettura e della Città presso la Fondazione di Studi avanzati in Venezia (SSAV) alla quale si aggiunge il testo di Yona Friedman The diluition of architecture nel quale l'architetto espone i principali temi della sua ricerca divisi per tipologie e argomenti. Completano il tutto una lunga intervista dello steso Orazi a Friedman nella sua casa parigina e come introduzione un bel servizio fotografico di Stefano Graziani che riproduce gli interni dell'abitazione, una delle poche opere esistenti dell'architetto che si va trasformando nella sua casa-museo.
Yona risorto (dentro la balena)
Yona, come il suo omonimo, è rispuntato dal ventre della
balena che l'aveva inghiottito per un lungo periodo. Negli ultimi
anni abbiamo assistito ad una riscoperta della sua opera. Più
da parte del mondo dell'arte che dell'architettura. È
stato invitato nel 2009 alla Biennale d'Arte Contemporanea di
Venezia dove all'ingresso delle Corderie venne allestita una
sua installazione sospesa, Visualisation of an idea.
Nello stesso anno alla Galleria Minini di Brescia è stata
allestita una sua personale dal titolo Cartoline postali
dove ho avuto il piacere di intervistarlo.1
Da quel momento è stato tutto un nuovo fiorire di interesse
per la sua opera: ripubblicazione dei suoi libri, studi su di
lui, mostre, installazioni ed eventi. Ultime opere di quest'anno:
No man's Land con Jean-Baptiste Decavéle, un'installazione
a Loreto Aprutino, Pescara e La Montagne de Venise sempre
con lo stesso collaboratore ed un gruppo di studenti di Architettura
e arti visive dello IUAV. Quest'ultima una struttura galleggiante,
una sorta di piccola montagna realizzata con la tecnica delle
space chains, elementi leggeri uniti a catena per formare
strutture tridimensionali circolari.
La montagna galleggiante ha percorso dal 28 al 30 settembre
i canali veneziani, per approdare poi il primo ottobre all'interno
della Biennale di Architettura nel bacino dell'Arsenale. Con
mia grande sorpresa, e piacere, negli ultimi recentissimi anni
sono tornati in voga temi quali partecipazione, autocostruzione,
shelter, spazi collettivi, tecnologie povere, argomenti
che sembravano ormai retaggio di un folcloristico mondo hippy
spazzato via dalla dura realtà del mercato globale. Anche
l'ultima, interessante Biennale di Architettura appena conclusa,
affidata ad Alejandro Aravena, si è aperta a questi temi.
E insieme a Yona, quest'anno è risorto anche Christò,
entrambi profeti di un mondo utopico negli anni '60 e '70 e
riscoperti oggi come puro fenomeno artistico e inseriti nel
circo mediatico dell'arte contemporanea.
|
| Loreto Aprutino (Pe) - No man's land,
di Yona Friedman e Jean-Baptiste Decavéle |
|
L'epoca dei BOX
Ho avuto il piacere di ascoltare la presentazione di Manuel Orazi di questi due suoi bei testi nella mia vecchia facoltà di architettura, lo IUAV ai Tolentini, a Venezia e proprio nell'aula a gradoni, dove ci affollavamo per ascoltare incantati le lezioni ipnotizzanti del grande Manfredo Tafuri di Storia dell'Architettura.
Mentre salivo le scale che ho percorso da studente migliaia di volte cercavo qualche sensazione di nostalgico déjà vu ma non riuscivo a comunicare con gli spazi (con i cessi sì, non sono cambiati negli ultimi quarant'anni...), non affioravano ricordi anche se cercavo qualche luogo noto, qualche aula riconoscibile.
Tutto è stato rimaneggiato. Gli spazi sono funzionali, razionali, ma chiusi. La Biblioteca non comunica con gli altri spazi, i corridoi sono divenuti ambienti di servizio. E tante porte, chiuse. Le vecchie stanze in un'infilata di porte comunicanti sono diventati luoghi privatizzati, dedicati, sono nati nuovi corridoi, separazioni, barriere, materiali e visive, come nei peggiori restauri speculativi dei vecchi palazzi nobiliari; sono diventati spazi rigidi che respingono, intimidiscono e mettono in riga.
I Tolentini che ricordo sarebbero piaciuti a Yona Friedman: le stanze erano ancora quelle quattrocentesche, ampie e comunicanti. Corridoi zero. E dalla fine degli anni '60 ai primi '70 questi ampi spazi luminosi contenevano un villaggio medievale, meglio una Bidonville o una Favela alla veneziana. Qualcuno li definì un Souk.
Per recarsi da una parte all'altra dell'Istituto si percorrevano stretti vicoli risultanti dalle costruzioni abusive realizzate dagli studenti: piccoli spazi con due o tre tavoli da disegno, una porta chiusa da un lucchetto - i furti di materiale erano all'ordine del giorno - e fuori una targhetta con il nome del gruppo e dei suoi componenti. Sopra il cielo luminoso del soffitto. Non si andava noi a mostrare i lavori ai docenti, i docenti e gli assistenti passavano nei Box e nelle stanze occupate (dai gruppi più importanti e numerosi) a discutere e suggerire modifiche.
Un'occupazione che sanciva il rispetto per la vecchia struttura e la creazione di un nuovo ambiente mobile, nomade e collettivo che cambiava forma al cambiare dei gruppi e delle necessità.
Una Piramide Rovesciata (come recitava un testo di De Carlo sull'università di quegli anni) al vertice della quale stavano le esigenze degli studenti/settlers occupanti attivi che piacevano tanto a Friedman. Un'epoca di creatività eccezionale in cui si lasciava spazio alla genialità così come all'opportunismo (gli esami erano collettivi e spesso solo pure formalità).
Poi appena il Movimento Studentesco divenne solo un po' più debole, durante una pausa estiva, si demolirono tutti i box e ai Tolentini si iniziò a dividere gli spazi: mura divisorie, porte chiuse e corridoi. Uno spazio che più non riconosco.
L'architettura di Yona Friedman era possibile in quegli anni con quella fantasia e voglia di cambiare gli spazi e ribaltare le gerarchie, la rivoluzione dei “Boxers dei Tolentini” ne è stato un piccolo esempio. Le architetture di Yona Friedman ci parevano la logica conseguenza della nostra vita quotidiana, erano – e vogliono ancora essere – Utopie Realizzabili. Ma allora esisteva un “popolo utopico” e una forte pulsione al cambiamento sociale.
Quei benefattori di Bill Gates e Silvio Berlusconi
Quali utopie possiamo immaginare oggi? Forse solo lucide e terrorizzanti distopie o meglio cacotopie. I nuovi modelli di abitare collettivo sono le bidonville per rifugiati diseredati. I rifugiati per cui lavorava il giovane Friedman erano volontari e avevano in mente il sogno di Israele e la comunità socialista e spesso libertaria dei Kibbutz. Le idee nascevano dal desiderio di crescita e di comunità. Gli stessi spazi e strutture oggi sono pensati per essere finalizzati alla decrescita, al controllo sociale e alla frantumazione degli individui estirpati dalla propria comunità. La progettazione di case popolari diviene compito di programmi di charity, non più diritto per cui lottare ma beneficenza, concessione del ricco che non vuole essere disturbato troppo “a casa propria”.
Da Bill Gates a scendere, i ricchissimi del pianeta hanno scoperto
il business e l'utilità sociale delle charity
come prevenzione del dissenso radicale. Anche da noi, come testimonia
l'Espresso: “Santo Papi: Berlusconi si lancia nella beneficenza.
Il progetto della più grande charity del mondo.
Finanziata con fondi personali. L'ex Cavaliere offrirà
un tetto agli italiani colpiti dalla recessione. Le residenze
saranno realizzate con criteri avanzati. Una Milano 2 destinata
ai nuovi poveri per cancellare il bunga bunga e le studentesse
bisognose di via Olgettina”.2
Franco Bunuga
- Da: Libertaria, anno 12, n° 1-2, gennaio-giugno
2010
- http://espresso.repubblica.it/palazzo/2016/09/23/news/santo-papi-berlusconi-si-lancia-nella-beneficienza-1.283961?twitter_card=20160929083251
|

