
Sardegna/
In rivolta contro l'assurdità del sistema giudiziario-carcerario
Annino Mele è un detenuto sardo che ha cercato, e trovato, nella scrittura,
un mezzo per rileggere il suo passato e per riflettere sulla
sua attuale condizione di ergastolano, denunciando l'inutile
e ingiusta restrizione a vita a cui è condannato, nonostante
il suo percorso, che potremmo definire di auto-riabilitazione:
poiché Mele, super-latitante ricercato per omicidio e
sequestro di persona, da subito dopo l'arresto, ha cominciato
a prendere le distanze dalle sue scelte violente e criminali,
invitando i compagni della sua banda a rilasciare la vittima
del loro ultimo sequestro (cosa che è prontamente avvenuta)
e lanciando un appello a tutti i banditi e latitanti sardi a
non perseguire più la via dei sequestri e dell'illegalità.
Da quel momento - ed era il 1987 - per Mele è iniziato
comunque, nonostante il suo ravvedimento, il calvario della
detenzione con le angherie, i soprusi, le violenza fisiche e
psicologiche a cui sono sottoposti in gran parte e in ogni carcere,
i detenuti.
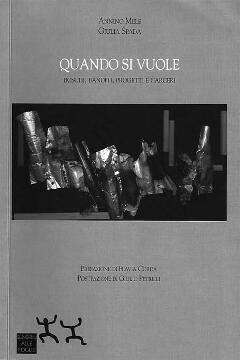 La
sua rivolta all'assurdità di un sistema giudiziario-carcerario
che reclude e non rieduca, che isola e non reintegra, Mele l'ha
concretizzata nella protesta aspra e decisa contro le inadempienze
delle strutture che di volta in volta l'hanno ospitato e nella
richiesta di rispetto dei suoi diritti di detenuto, ma anche
nell'informare, attraverso i suoi scritti, su cosa avviene nel
mondo “di dentro” alle sbarre, nell'universo concentrazionario
delle prigioni, dove si viene privati non solo della libertà
ma anche della dignità. La
sua rivolta all'assurdità di un sistema giudiziario-carcerario
che reclude e non rieduca, che isola e non reintegra, Mele l'ha
concretizzata nella protesta aspra e decisa contro le inadempienze
delle strutture che di volta in volta l'hanno ospitato e nella
richiesta di rispetto dei suoi diritti di detenuto, ma anche
nell'informare, attraverso i suoi scritti, su cosa avviene nel
mondo “di dentro” alle sbarre, nell'universo concentrazionario
delle prigioni, dove si viene privati non solo della libertà
ma anche della dignità.
Eppure, nell'ultimo libro del detenuto Mele, scritto assieme
alla giornalista Giulia Spada, a stupire è innanzitutto
l'ottimistico titolo, Quando si vuole (Sensibili alle
foglie, Roma, 2016, pp. 128, € 15,00), che testimonia la
fiducia nella possibilità di un cambiamento, individuale
e collettivo, che porti ad una società migliore, nella
quale, nonostante tutto, credono sia Mele che la Spada, che,
nella diversità delle loro situazioni e prospettive,
si riconoscono accomunati dall'appartenenza allo stesso popolo,
quello della Sardegna, del quale rivendicano le secolari ansie
di indipendenza ed autonomia e le singolari tradizioni.
Dalla rievocazione di quest'ultime, in particolare dall'attaccamento,
quasi sacrale, dei pastori sardi ai boschi, inizia il racconto
autobiografico di Mele che costituisce la prima parte del libro:
vengono fuori le memorie della latitanza, fatta di fughe e di
soste nei più remoti anfratti dei fitti boschi dell'interno
della Sardegna; le gesta dei banditi con le loro prede umane
in ostaggio, merce di scambio e di riscatto; i ricordi della
strenua lotta dei contadini e dei latitanti contro il fuoco
che divampava a volte, per la disattenzione di qualcuno, e che
rischiava di compromettere il lavoro degli agricoltori e degli
allevatori e al contempo metteva a rischio i latitanti, “smascherandone”
i rifugi e costringendoli a nuovi ripari, lontani dalle fiamme
e dall'esercito di uomini (forze dell'ordine, pompieri, guardie
forestali) impegnati a spegnerle.
E nelle rievocazioni di Mele, tra minute descrizioni della vita
in clandestinità e ricostruzioni storiche-sociali delle
origini e dello sviluppo del banditismo, ampio spazio trovano
alcune proposte, costruttive, di far ripartire l'economia dell'
Isola non da improbabili e dannosi piani industriali, ma proprio
dalla valorizzazione di alcuni aspetti specifici e persistenti
che l'hanno nel tempo caratterizzata, come, ad esempio: l'allevamento
allo stato brado del suino nero, razza rara e pregiata; la tenace
conservazione dell'habitat naturale; la presenza di paesaggi,
suggestivi e unici, ancora intatti e di paesi dalla vita a misura
d'uomo: tutto questo, argomenta con passione e rigore propositivo
Mele, potrebbe richiamare un turismo misurato e sostenibile,
che, lontano dalle mete e dai consumi di massa, troverebbe nell'Isola
cibi genuini e luoghi d'incanto. La visione e la speranza di
Mele, di una Sardegna liberata dal crimine (non più orizzonte
inseguito dai giovani, finalmente occupati in lavori gratificanti
e redditizi), continua nella seconda parte del libro, con la
contestazione della legittimità e dell'esistenza stessa
dei luoghi che il crimine dovrebbero “combattere”
e non lo fanno: le carceri.
Sempre attraverso la narrazione di vicende personali o direttamente
conosciute, dall'interno da Mele, dall'esterno dalla Spada (studiosa
e autrice di inchieste sul carcere e sulle “retoriche
del corpo recluso”), viene vivisezionata la pratica ottusa
del “sorvegliare e punire” che anima la “giustizia”
carceraria, nell'assenza permanente di una qualsivoglia politica
di prevenzione dei delitti e di remissione giustificata delle
pene. I due autori, mostrando l'orrore dei luoghi, anche moderni,
di detenzione, come il carcere di Opera, nel milanese - dove
violenze e umiliazioni sono all'ordine del giorno e il mancato
rispetto dei sacrosanti diritti umani investe non solo i detenuti
ma anche i loro parenti e amici visitatori - provano a immaginare
un uso possibile e creativo del dismesso edificio che ha ospitato
sino al 2015 il carcere del Buoncammino a Cagliari: nei suoi
enormi spazi, dati in gestione a cooperative giovanili, potrebbero
essere ospitate biblioteche, centri di studio e di progettazione
economica, laboratori artistici e musicali, etc.
Il libro di Mele e della Spada è ricco di note storiche
che aiutano a capire genesi e forme del banditismo sardo, come
reazione alle “chiudende” (le leggi di Re Vittorio
Emanuele I, che privatizzarono, nel 1820, le terre demaniali,
da secoli a disposizione dei pastori sardi) e poi via via come
forma di ribellismo selvaggio e individualistico ad ogni forma
di potere centrale e invasivo; ma contiene, soprattutto, la
lucida testimonianza di un detenuto che altro non cerca che
spazi maggiori di autonomia e libertà, dopo una maturazione
umana e spirituale più che evidente e dimostrata, affidando
questa sua più che legittima pretesa alla volontà
degli uomini che possono (“Quando si vuole...”)
“abbattere le barriere di egoismo e di ignoranza che dividono
e allontanano”.
Silvestro Livolsi
Le poesie di Giovanni Marini/
Un poeta dietro le sbarre (e dopo)
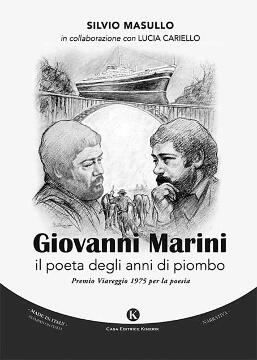 Come
Giovanni Marini, il poeta dei folli e dei giusti, che
vi nasce il 1 gennaio 1942, anche il curatore del libro Silvio
Masullo è nato a Sacco, nel Cilento interno. Questa “compaesanità”
e la constatazione che la poesia e la poetica di Giovanni Marini
sono state dimenticate, lo ha meritoriamente spinto a curare
e a proporre - insieme all'archeologa Lucia Cariello - una nuova
edizione della raccolta E noi folli e giusti, pubblicata
nel 1975 dall'editore Marsilio di Venezia, Premio Viareggio
nello stesso anno, mentre Marini sconta dodici anni di carcere,
inflittigli per omicidio volontario l'11 luglio 1974 dal tribunale
di Vallo della Lucania. La sentenza è attesa nella notte
da centinaia di compagni e compagne venuti da ogni parte d'Italia,
accampati nei giardini di fronte al tribunale (tra loro, anche
chi scrive, che aveva seguito il processo per la stampa anarchica
italiana, spagnola e francese). Come
Giovanni Marini, il poeta dei folli e dei giusti, che
vi nasce il 1 gennaio 1942, anche il curatore del libro Silvio
Masullo è nato a Sacco, nel Cilento interno. Questa “compaesanità”
e la constatazione che la poesia e la poetica di Giovanni Marini
sono state dimenticate, lo ha meritoriamente spinto a curare
e a proporre - insieme all'archeologa Lucia Cariello - una nuova
edizione della raccolta E noi folli e giusti, pubblicata
nel 1975 dall'editore Marsilio di Venezia, Premio Viareggio
nello stesso anno, mentre Marini sconta dodici anni di carcere,
inflittigli per omicidio volontario l'11 luglio 1974 dal tribunale
di Vallo della Lucania. La sentenza è attesa nella notte
da centinaia di compagni e compagne venuti da ogni parte d'Italia,
accampati nei giardini di fronte al tribunale (tra loro, anche
chi scrive, che aveva seguito il processo per la stampa anarchica
italiana, spagnola e francese).
A Sacco, il padre è responsabile del locale ufficio di
collocamento e amministratore comunale con la lista popolare
della Spiga. I contadini vanno a trovarlo a casa anche la sera,
dopo che l'ufficio è chiuso e dopo una dura giornata
di lavoro e, a volte, lo ringraziano per i piaceri che
fa con i prodotti del lavoro e della terra, portandogli un pezzo
di formaggio, ortaggi e le tavolette di cioccolata che mandavano
gli emigranti e che Giovanni - come testimonia il racconto di
Masullo - sottraeva e distribuiva agli altri ragazzi, compagni
di escursione e meno fortunati.
Marini, dopo aver fatto un'esperienza come studente nel lontano
seminario di Vallo della Lucania, con la sua famiglia si trasferisce
a Salerno, dove il padre è stato nominato ispettore del
lavoro. Frequenta l'istituto tecnico-commerciale De Martino,
del quale è preside Raffaele Monaco, originario di Sacco,
ex-partigiano nelle valli di Cuneo. Milita nel PCI e nei gruppi
della sinistra, prima di diventare anarchico attratto - secondo
Masullo - da figure come Camillo Berneri e dalla tragica morte
di Giuseppe Pinelli. Intanto lavora a Monza e a Bologna, poi
rientra a Salerno.
Dopo lo strano incidente della notte del 26 settembre 1970 -
nel quale perdono la vita cinque compagni calabresi diretti
a Roma per consegnare i risultati (spariti nell'incidente) di
un'inchiesta sugli attentati fascisti ai treni che portavano
i lavoratori in Calabria - viene incaricato di indagare sul
camionista salernitano che ha provocato il mortale incidente
e che risulta iscritto al MSI. Salerno, in quegli anni, è
una città con una larga maggioranza fascista e spesso
l'on. Almirante vi teneva comizi. Da allora, per Marini, cominciano
le provocazioni, le minacce e le telefonate anonime e minatorie.
Nella prima serata del 7 luglio 1972, mentre passeggia tranquillamente
sul bel lungomare di Salerno ed è in compagnia di Gennaro
Scariati, viene provocato con una gomitata da un giovane fascista,
ma Marini non reagisce anche perché si è reso
conto che il lungomare è pieno di fascisti, che probabilmente
aspettano la sua reazione per picchiarlo. L'incidente finisce
lì, o almeno così sembra. Più tardi ha
appuntamento con Francesco Mastrogiovanni per andare a teatro.
Percorrendo la strada che li porta a teatro, in Via Velia incontrano
i due fascisti che percorrono l'altro lato. Poco più
sopra c'è la sede del MSI. Marini informa Mastrogiovanni
che sono i fascisti che lo hanno provocato e Mastrogiovanni
lo rassicura: «Non ti preoccupare, adesso ci vado a parlare
io». Attraversa la strada e chiede: «Che volete?
Che vi abbiamo fatto?». Per tutta risposta vede luccicare
la lama di un coltello che lo ferisce alla gamba, sviene e cade
nel sangue. A questo punto interviene Marini, che riesce a disarmare
gli aggressori e, impossessatosi del coltello che ha ferito
Mastrogiovanni, nella colluttazione ferisce Carlo Falvella,
un giovane fascista di 21 anni. I fascisti - di fronte all'imprevista
e coraggiosa reazione - si limitano a soccorrere i due camerati,
mentre Mastrogiovanni, sanguinante per la ferita alla gamba,
ricorre all'autostop per recarsi in ospedale. Poco dopo, Falvella
muore e ai funerali partecipa anche l'on. Almirante, che, pochi
mesi prima, in un comizio a Firenze, aveva invitato i giovani
del Fronte della Gioventù a praticare lo «scontro
fisico».
Marini, costituitosi poco dopo, è dichiarato in arresto
insieme a Mastrogiovanni e Scariati, che si costituirà
dopo alcuni giorni e verrà prosciolto in istruttoria,
mentre Mastrogiovanni sarà scarcerato ma imputato per
rissa, poi assolto.
Il processo, iniziato a Salerno il 28 febbraio 1974, sospeso
il 13 marzo per motivi di ordine pubblico, è spostato
a Vallo della Lucania, dove riprende il 30 giugno e la sentenza
viene pronunziata l'11 luglio 1974. Al processo d'appello -
che si tiene a Salerno dal 2 al 23 aprile 1975 - la condanna
è ridotta a nove anni di carcere. Ne sconta sette.
Durante la dura carcerazione, Marini denunzia le incivili e
aberranti condizioni carcerarie e per punizione è mandato
da un carcere all'altro e nel carcere di Caltanissetta è
rinchiuso in una cella buia e umida.
Nel carcere trova un conforto nella poesia e - con le catene
ai polsi - nel 1975 pubblica il volume E noi folli e giusti,
che ottiene un lusinghiero successo letterario e di pubblico
e vince il Premio Viareggio. Scarcerato nel 1979, continua a
pubblicare per proprio conto dei libricini di poesia, che vende
o dona a un ristretto gruppo di compagni e di amici.
Silvio Masullo e Lucia Cariello hanno il merito di aver riunito,
attraverso un lavoro meticoloso e paziente, in un unico volume
E noi folli e giusti e parte della successiva e introvabile
produzione poetica di Giovanni Marini, che muore a Salerno il
23 dicembre 2001.
La raccolta (Giovanni Marini. Il poeta degli anni di piombo,
Casa Editrice Kimerik, Patti - Me, pp. 234, € 16,00) è
stata presentata a Sacco lo scorso 6 agosto e ha consentito
ai paesani di scoprire la dimensione poetica e umana di quel
loro concittadino finito in carcere. Nell'aula comunale è
presente un numeroso pubblico. Al tavolo, oltre i due autori
e il sottoscritto, il sindaco Claudio Saggese, il dott. Ubaldo
Baldi (che nel 1972 militava ne «Il Manifesto»),
l'ex senatore Alfonso Andria e l'on. Tino Iannuzzi e Mastrangelo
della Banca Cooperativa di Monte Pruno di Roscigno che ha contribuito
alla realizzazione del libro e della manifestazione. Dall'altro
mondo, se c'è, probabilmente l'anarchico Marini ha sorriso
a vedere una banca e esponenti della Democrazia Cristiana di
una volta alla presentazione del suo libro...
Pur apprezzando quest'omaggio e questa iniziativa, mi sia tuttavia
consentito di dissentire da Silvio Masullo quando afferma che
ha voluto solo operare un recupero e una valorizzazione della
poetica di Marini; quando non fa chiarezza sulle responsabilità
dello scontro dichiarando che «non ha alcuna intenzione
di rinvigorire le ferite e le rabbie del passato, offrendo comodi
pretesti a chicchessia, né tantomeno procedere a improbabili
analisi postume delle responsabilità nelle quali era
maturato il delitto»; quando apre la prefazione riportando
l'invito alla pace e alla cessazione di ogni violenza pronunziato
dal padre di Carlo Falvella e quando chiude la cronologia su
Giovanni Marini citando il «Comitato per Carlo Falvella»,
che nel giugno del 2014 ha chiesto di fare del 7 luglio un momento
condiviso per «dare dignità ad una comunità
che si sente spiritualmente legata al ricordo di Carlo Falvella»,
dimenticando che è stato proprio Giovanni Marini ad essere
vittima della violenza fascista, tant'è che la sera dello
scontro Marini e gli altri due anarchici erano inermi e disarmati
e, a differenza dei fascisti, credevano nel valore della parola
e della convinzione e non delle coltellate e Mastrogiovanni
che va a parlamentare con i fascisti viene accolto dalle
coltellate.
Il volume Giovanni Marini. Il poeta degli anni di piombo
può essere richiesto telefonando al n. 0941.21503
o scrivendo all'email redazione@kimeric.it.
Giuseppe Galzerano
Cosa resta dell'Occidente/
Tra decadenza inarrestabile e valori imprescindibili
È uscito per la casa editrice Elèuthera il libro dell'antropologo Franco La Cecla Elogio dell'occidente (Milano, 2016, pp. 176, € 14,00) di cui pubblichiamo l'introduzione.

Intendiamoci, l'Europa, l'Occidente, sono anche la sorgente
di buona parte dei mali del mondo. Una storia di prevaricazione,
di assoggettamento, di schiavismo, di distruzione delle culture
e delle economie altrui. Se si legge la storia dell'Occidente,
non c'è massacro, disastro ambientale ed errore umano
attuale che non abbia già avuto un'anticipazione nella
politica, nell'ideologia, nell'arroganza occidentali.
Da questo punto di vista, i complottisti hanno vita facile.
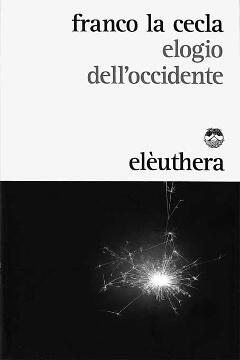 Tutto
ciò che di marcio oggi c'è nel mondo viene in
un modo o nell'altro dall'Occidente. Basta dunque mettersi dall'altra
parte e si è dal lato della ragione, dal lato dell'arrivano
i nostri, dal lato dei buoni contro i sempiterni cattivi
– America ed Europa – accomunati nell'avere creato
il caos che è oggi il mondo, distruttori di paesi che
avevano un loro equilibrio come Iraq, Afghanistan, Libia, tanto
per citare quelli più conosciuti, fautori di distruzione
in buona parte dell'Africa, dell'Asia, dell'America Latina.
E ancora, principali responsabili della crisi ecologica che
il pianeta sta vivendo oggi, orrendi consumatori di risorse
che sarà impossibile rinnovare, inquinatori mai puniti,
esportatori di bubboni e rifiuti tossici, sostenitori della
folle corsa del capitalismo contro il muro del futuro. C'è
parte del mondo più colpevole dell'Occidente? Di fronte
alle responsabilità occidentali, terrorismo, massacri
di fanatici armati, furia devastatrice di folle inferocite sono
tutte azioni giustificabili. Cosa ci si può aspettare
dal resto del mondo quando l'Occidente ha creato l'orrore che
è alla base di buona parte del male odierno? Tutto
ciò che di marcio oggi c'è nel mondo viene in
un modo o nell'altro dall'Occidente. Basta dunque mettersi dall'altra
parte e si è dal lato della ragione, dal lato dell'arrivano
i nostri, dal lato dei buoni contro i sempiterni cattivi
– America ed Europa – accomunati nell'avere creato
il caos che è oggi il mondo, distruttori di paesi che
avevano un loro equilibrio come Iraq, Afghanistan, Libia, tanto
per citare quelli più conosciuti, fautori di distruzione
in buona parte dell'Africa, dell'Asia, dell'America Latina.
E ancora, principali responsabili della crisi ecologica che
il pianeta sta vivendo oggi, orrendi consumatori di risorse
che sarà impossibile rinnovare, inquinatori mai puniti,
esportatori di bubboni e rifiuti tossici, sostenitori della
folle corsa del capitalismo contro il muro del futuro. C'è
parte del mondo più colpevole dell'Occidente? Di fronte
alle responsabilità occidentali, terrorismo, massacri
di fanatici armati, furia devastatrice di folle inferocite sono
tutte azioni giustificabili. Cosa ci si può aspettare
dal resto del mondo quando l'Occidente ha creato l'orrore che
è alla base di buona parte del male odierno?
Eppure, all'interno dello stesso Occidente c'è una storia
e una geografia che parla d'altro. C'è la storia dell'opposizione
a questa follia, la geografia di individui e di movimenti che
si sono battuti per secoli contro la protervia dei potenti,
contro la devastazione capitalista ed economicista.
C'è la storia di pensieri e azioni che hanno contrapposto
alla follia omicida dell'Occidente la dignità umana,
l'idea della irrinunciabile profondità dello stare al
mondo, la difesa del principio spirituale che insieme a quello
materiale muove l'umanità. Chi non vede che l'Occidente
è il male, e al contempo la costante opposizione a esso,
crede di essere innocente solo perché indica il male,
ma poi è incapace di sostenere il vento della lotta,
della solidarietà, della compassione, della sensibilità,
della costruzione di un bene comune. Questa forma di miopia
è forse un male peggiore del male nemico. È quella
che alimenta il nichilismo, il sadismo, il masochismo in cui
viviamo, è l'omicidio di coloro che «comunque»
sperano e vivono per dare un senso alla speranza. Il pessimismo,
l'analisi spietata della «merda» in cui siamo, sono
probabilmente ideologie che fanno solo bene al male, sono, insieme
al vittimismo, la più grande vittoria della spietatezza
del capitale.
Oggi il vittimismo sembra spesso il diritto a incarnare minoranze,
etnie, lingue oppresse, appartenenze, generi e sessi di vario
tipo che sarebbero emarginati ma a cui basta l'esercizio del
vittimismo stesso. È diventata una pratica talmente diffusa
che chiunque può trasformare la propria identità
in una «comunità oppressa». L'Occidente,
l'Europa, il Capitalismo, la Globalizzazione consentono a chiunque
il diritto di esserne vittima. A scapito di analisi più
dettagliate, di denunce di veri responsabili e di complicità
inconfessate.
A rileggere oggi Ivan Illich ci si stupisce di quanto tagliente
fosse la sua analisi delle professioni debilitanti, delle istituzioni
invalidanti, dei servizi e delle erogazioni atte a creare dipendenze.
E proprio perché le sue non erano analisi «generali»,
ma dettagliate, che scoprivano la nostra complicità nel
concreto, nelle dipendenze che ci scegliamo giorno per giorno.
Per sentirsi vittima occorre invece restare «sulle generali»,
adoperando slogan e locandine come bandiere.
Mai come oggi sono attuali le parole di Étienne de la
Boétie nel Discorso sulla servitù volontaria:
Costui che spadroneggia su di voi non ha che due occhi, due
mani, un corpo e niente di più di quanto possiede l'ultimo
abitante di tutte le vostre città. Ciò che ha
in più è la libertà di mano che gli lasciate
nel fare oppressione su di voi fino ad annientarvi.
Da dove ha potuto prendere tanti occhi per spiarvi se non glieli
avete prestati voi? Come può avere tante mani per prendervi
se non è da voi che le ha ricevute? E i piedi coi quali
calpesta le vostre città non sono forse i vostri? Come
fa ad avere potere su di voi senza che voi stessi vi prestiate
al gioco? E come oserebbe balzarvi addosso se non fosse già
d'accordo con voi? Che male potrebbe farvi se non foste complici
del brigante che vi deruba, dell'assassino che vi uccide, se
insomma non foste traditori di voi stessi? Voi seminate i campi
per farvi distruggere il raccolto; riempite di mobili e di vari
oggetti le vostre case per lasciarveli derubare; allevate le
vostre figlie per soddisfare le sue voglie e i vostri figli
perché il meglio che loro possa capitare è di
essere trascinati in guerra, condotti al macello, trasformati
in servi dei suoi desideri e in esecutori delle sue vendette;
vi ammazzate di fatica perché possa godersi le gioie
della vita e darsi ai piaceri più turpi; vi indebolite
per renderlo più forte e più duro nel tenervi
corta la briglia. Eppure da tutte queste infamie che le bestie
stesse non riuscirebbero ad apprendere e che comunque non sopporterebbero,
potreste liberarvi se provaste, non dico a scuotervele di dosso,
ma semplicemente a desiderare di farlo. Siate dunque decisi
a non servire mai più e sarete liberi. Non voglio che
scacciate il tiranno e lo buttiate giù dal trono; basta
che non lo sosteniate più e lo vedrete crollare a terra
per il peso e andare in frantumi come un colosso a cui sia stato
tolto il basamento [Étienne de La Boétie, Discorso
sulla servitù volontaria (1571), Jaca Book, Milano, 1979,
p. 19].
Sono parole di un'apparente ingenuità, di quella seconde
naïveté che Paul Ricoeur riteneva necessaria per
ricominciare a fare una filosofia del presente. Mai come adesso
sembrano attuali, per chi vede nell'Occidente il pretesto per
la rinuncia alla propria libertà.
Chi non coglie nella storia e nel presente dell'Occidente la
resistenza al male riproduce l'alibi di chi si fa servo volontariamente,
di chi pensa che non c'è niente da fare e con il suo
vittimismo si tira fuori dalla storia e dalla geografia, e pensa
di non «entrarci per nulla». L'anti-occidentalismo
è oggi per buona parte un vittimismo di questo tipo,
una comoda depressione che porta alla contemplazione cinica
del disastro del mondo. Oggi il principio speranza viene sbeffeggiato
proprio da coloro che pensano di essere i più realisti
del pianeta.
La grande tragedia del mondo che dell'Occidente fa parte è
di agire per buona parte influenzato dallo stesso atteggiamento.
Le classi dirigenti, ma anche i terroristi di altri mondi, apprendono
il principio del «tanto peggio» dalla viva voce
di coloro che in Occidente sperano nella palingenesi universale
dell'Armageddon e che pensano che solo nella distruzione definitiva
e totale, nel sangue altrui e proprio versato, c'è la
morale che questa nostra storia si merita. Il vittimismo del
resto del mondo somiglia da presso a coloro che in Occidente
se ne stanno con le mani in mano a leggere le notizie e a dire
che ormai non c'è più niente da fare. E si ritirano
bellamente in luoghi sicuri e nel loro magnifico privato.
In altri continenti, in altri paesi, c'è la scusa supplementare
dell'avere ragione. L'Occidente è decadente, è
alla fine, diamogli il colpo di grazia. Come se altrove che
in Occidente non ci fossero le stesse radici del male, della
crudeltà nei confronti degli altri esseri umani, non
ci fosse la soppressione della voce delle donne e dei diversi,
lo sfruttamento di intere fasce di popolazione ridotte in caste
o in etnie e tribù avverse.
Il ritorno ai sacri valori della comunità di cui il mondo
non occidentale sarebbe il garante è una pantomima idiota
creata dallo stesso Occidente. L'idea che altrove la gente sia
meno colpevole di quello che fa è un insulto alla dignità
umana.
Ancora per quanti anni sentiremo la solfa che l'11 settembre
è una creazione dell'intelligence, perché il mondo
arabo sarebbe incapace di pianificare e portare avanti qualcosa
di simile? Come se la complicità e il doppiogiochismo
non potesse essere patrimonio anche del mondo arabo. Tutto questo
è parte dell'idea della superiorità occidentale
anche nel fare il male, del monopolio, se non reale almeno ideologico,
della nefandezza. È ora di farla finita con questo idiotismo
che percorre l'intero pianeta, con la globalizzazione di un'idiozia
colpevole e miope allo stesso tempo.
Buona parte della visione che vuole tutto il male in Occidente
è l'effetto di un'idea dell'essere umano come incapace
di fare gesti liberi, magnifici o atroci che siano. Da una parte
ci sono i cattivi, capaci di tramare contro tutti, dall'altra
i buoni, vittime di tutto (e in mezzo l'Atlantico, lo stretto
di Gibilterra e il Canale di Sicilia).
La deformazione di un certo materialismo dialettico e la cattiva
lettura del peso dell'economia nella storia hanno creato una
lettura meccanicistica e riduttiva della vicenda umana. E hanno
prodotto un'idea deforme dell'umano.
Nessuno è colpevole, ci sono solo circostanze. Se nessuno
è colpevole, non lo è nemmeno l'Occidente, verrebbe
da dire, e allora restiamo fermi a guardare il «pachinko
flipper» del mondo andare verso l'esplosione. Oggi ci
sarebbe bisogno di un dibattito filosofico e di pensiero che
riprenda tutte le tesi sul libero arbitrio e sulla possibilità
che anche l'ultimo schiavo abbia in sé il principio della
libertà.
Per questo non è un caso che mi sono risolto a scrivere
questo pamphlet per gli amici libertari, perché
nessuno come loro sa che sul crinale del presente è solo
la convinzione della libertà profonda dell'essere umano
che oggi fa la differenza.
La libertà di fare il bene o il male, non la libertà
retorica, conclamata politicamente, ma la pratica quotidiana
di essa, nelle routine e negli incontri, nelle convivenze e
nelle adiacenze. È la grande storia dell'anarchismo consapevole,
quello che crede nella grana che tiene insieme la società
e non soltanto nell'individuo come monade; è la storia
– per buona parte occidentale, ma esportata nel resto
del mondo – del principio della volontà e della
speranza, che da Carlo Cafiero in Italia a Pëtr Kropotkin
in Russia e in Europa, a Multatuli in Indonesia, a B.R. Ambedkar
in India, a José Rizal nelle Filippine, è stato
il motore di infinite trasformazioni e della creatività
di chi sa che il male è anche dentro di noi e che però
è addomesticabile – perché umano –
e può essere volto in bene. Bisogna difendere questa
storia e questa geografia che sono antropologicamente molto
occidentali, insieme al patrimonio di resistenza e di vita e
di futuro che l'Occidente rappresenta. Senza l'Occidente la
stessa idea di libertà sarebbe molto più dubbia
e incerta, come la storia attuale ci racconta.
Franco La Cecla
Tomaso Serra/
Un militante anarchico tra antifascismo, Sardegna, Spagna e...
Fonti primarie, documenti, articoli, lettere e memorie alimentano
la trama della vita avventurosa dell'anarchico sardo Tomaso
Serra: ecco un'altra bella narrazione biografica che attraversa
il Novecento (Costantino Cavalleri, L'anarchico di Barrali
(quasi) 100 anni di storia per l'anarchia. Biografia di Tomaso
Serra, detto “Il Barba”, Juan Fernandez, Pinna Joseph,
Tomy Casella... 1900-1985, Guasila - Ca, Editziones de su
Arkiviu-Bibrioteka “T. Serra”, 2016, pp. 1088, €
28,00).
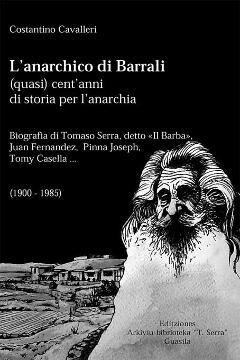 L'opera,
oltre mille pagine basate anche su un epistolario di valore
inestimabile, incorpora un progetto editoriale militante bloccatosi
ad un primo volume uscito nel lontano 1992 (e che fermava il
suo racconto ai primi anni Trenta). Sebbene il libro non paia
esente da difetti “tecnici” (editing che poteva
forse essere alleggerito con un CD allegato; scarso utilizzo
della storiografia nello sviluppo del testo), la sua possibile
funzione di strumento eccezionale di conoscenza, ricco di informazioni
e di suggestioni allo stesso tempo, è più che
evidente. In queste pagine ci sono tante esistenze che si intersecano
con quella del protagonista e, come succede in questi casi,
c'è prima di tutto quella dell'autore che ha seguito
amorevolmente e reso avvincente questa storia. L'opera,
oltre mille pagine basate anche su un epistolario di valore
inestimabile, incorpora un progetto editoriale militante bloccatosi
ad un primo volume uscito nel lontano 1992 (e che fermava il
suo racconto ai primi anni Trenta). Sebbene il libro non paia
esente da difetti “tecnici” (editing che poteva
forse essere alleggerito con un CD allegato; scarso utilizzo
della storiografia nello sviluppo del testo), la sua possibile
funzione di strumento eccezionale di conoscenza, ricco di informazioni
e di suggestioni allo stesso tempo, è più che
evidente. In queste pagine ci sono tante esistenze che si intersecano
con quella del protagonista e, come succede in questi casi,
c'è prima di tutto quella dell'autore che ha seguito
amorevolmente e reso avvincente questa storia.
Le due generazioni – di Cavalleri e di Serra – in
fondo si assomigliano e ciascuna, sebbene in contesti e con
modalità differenti, ha per così dire tentato
a suo modo l'assalto al cielo, “inseguendo la vita fino
in fondo”. Sardegna / Europa / Sardegna: il viaggio che
ci viene proposto evoca emozioni e incontri del secolo scorso.
Ed anche noi abbiamo conosciuto bene “Il Barba”,
quell'uomo piccolo di statura ma d'animo grande, ormai vecchio
ma sempre curioso di confrontarsi con i giovani compagni. Dense,
puntuali, precise le sue lettere che tutti ricordiamo, e le
composizioni che distribuiva ai convegni contenevano sempre
messaggi semplici ma ricchi di vena poetica.
Gli uomini, si sa, sono come gli uccelli, e quando sono stanchi
di volare si lasciano docilmente rinchiudere in gabbia, dimenticando
la loro antica selvatichezza di uomini liberi; si spegne così
in essi ogni spirito di indipendenza e di propria dignità.
Ma per fortuna ogni tanto ce ne sono alcuni che, invece di entrarvi,
spiccano il volo verso più liberi e sconosciuti orizzonti.
Mirano in alto guardando alla vita qualitativamente...
Riassumiamo qui di seguito – pensando di fare cosa utile
per i lettori – alcuni passaggi essenziali della vita
del protagonista. Tomaso Serra era nato il 23 marzo 1900 a Lanusei
(Nuoro) da Silverio e Paola Mameli. Secondo di sette figli,
il padre era ferroviere e la mamma bottegaia. Una malformazione
congenita sul viso lo affliggerà per tutta la vita. Svolge
innumerevoli mestieri: boscaiolo, manovale, operaio metallurgico,
carpentiere, minatore e attore di teatro. Emigra in Francia
nel 1916 per motivi di lavoro. Rientra in Italia dopo due anni
per passare la visita per il servizio militare; riformato, espatria
di nuovo.
Nel 1919-1920 è in Svizzera dove conosce e frequenta,
presso la redazione de «Il Risveglio», Luigi Bertoni
che, ben presto, diventa il suo principale punto di riferimento.
In seguito si stabilisce in Francia: prima a Longwy nella Lorena,
poi a Le Cannet in Costa Azzurra. In questo periodo subisce,
incolpevole, una carcerazione di due mesi con l'accusa di rissa
e violenza privata. Insieme al cugino Paolino Puddu mantiene
contatti assidui con Raffaele Schiavina e Paolo Schicchi. Si
occupa del Comitato pro vittime politiche, aderisce alla LIDU
e partecipa alle varie manifestazioni per Sacco e Vanzetti.
Sostiene e diffonde la stampa anarchica italiana edita a Parigi
come «La Diana» e «Il Monito».
Nel 1927 è arrestato per affissione di manifesti sovversivi
e per detenzione illegale di pistola. Espulso dalla Francia
come sospetto terrorista, ripara in Lussemburgo. L'anno seguente
è costretto a rifugiarsi in Belgio. Qui svolge un'intensa
attività antifascista insieme a Puddu, Lorenzo Gamba
e Angelo Sbardellotto. Secondo le fonti di polizia farebbe anche
parte di un gruppo di anarchici denominato “Gli Espropriatori”
insieme a Carlo Girolimetti ed Enrico Zambonini. Nel 1929-1934
vaga tra Francia, Svizzera (ospite del Foyer des réfugés
politiques antifascistes) e Germania; più volte fermato
ed espulso, inseguito da varie denunce e mandati di cattura.
Nel 1936 è in Spagna per arruolarsi nella Colonna Italiana.
Combatte nelle battaglie di Monte Pelato, Huesca e Almudévar;
è inizialmente inquadrato nella batteria comandata da
Libero Battistelli e poi nella “Michele Schirru”.
Coadiuva Giuseppe Bifolchi nelle funzioni di comando ma assolve
anche agli incarichi di furiere, cuciniere e portaferiti.
Politicamente sostiene nella Colonna posizioni di fattiva collaborazione
tra le componenti libertaria e giellista. Pubblica corrispondenze
sui fatti d'arme a cui partecipa in «Guerra di Classe»
di Barcellona e su «Il Risveglio» di Ginevra. Denuncia
in modo aperto il ruolo reazionario svolto dai comunisti staliniani
durante i fatti del maggio 1937 e le loro responsabilità
nell'assassinio di Berneri e Barbieri. Arrestato, è rinchiuso
in una “prigione segreta comunista”, poi nel Carcel
Modelo barcellonese. Nell'agosto del medesimo anno è
accompagnato alla frontiera francese. Ammalato, in questo periodo
subisce un'operazione chirurgica. Dopo un tentativo fallito
di rifugiarsi in Belgio, nel 1939 è arrestato a Lille
e rinchiuso nel campo di Rieucros in zona pirenaica. L'anno
dopo si trova relegato a Vernet d'Ariège insieme a molti
altri reduci dalla Spagna. Consegnato alle autorità italiane
nel dicembre 1941, è subito tradotto nelle carceri di
Nuoro.
Assegnato al confino di polizia per cinque anni come miliziano
rosso e per attività antifascista svolta all'estero,
è destinato all'isola di Ventotene. Trattenuto come internato
a Renicci d'Anghiari (Arezzo) in epoca badogliana.
Dopo l'8 settembre 1943 fugge verso Roma e qui, messosi in contatto
con il conterraneo Emilio Lussu, partecipa alla Resistenza –
compiendo varie azioni di guerriglia e sabotaggio – inquadrato
in una formazione di Giustizia e Libertà. Torna in Sardegna
nel 1947. Svolge un'intensa attività nel movimento libertario.
Nel 1962 fonda a Barrali (Cagliari) la “Collettività
anarchica di solidarietà” (poi Arkiviu-Bibrioteka
“Tomaso Serra”). Partecipa a congressi e convegni
nazionali della FAI fino agli anni Ottanta. Muore a Barrali
l'8 ottobre 1985.
Il libro, scorrevolissimo e accattivante nella lettura, si suddivide
in quattro corpose sezioni con la Spagna a fare giustamente
da cesura centrale. A seguire la transizione con il lungo dopoguerra
e, infine, l'ultima parte della vita di Tomaso dedicata agli
incontri e alle esperienze comuni con un'altra generazione “contro”.
Giorgio Sacchetti
Tra Spagna e Svizzera/
Una madre, una figlia, la verità
L'amico anarchico e bravo critico fumettistico Boris Battaglia
dice sempre che i fumetti non si leggono: si guardano. Penso
proprio abbia ragione. E la recentissima graphic novel di Lorena
Canottiere, Verdad (Coconino press, Bologna, 2016, pp.
160, € 19,00) lo conferma appieno: senza una certa disposizione
dell'occhio – una pazienza, persino una devozione –
gran parte del fascino dell'opera resta nascosto. 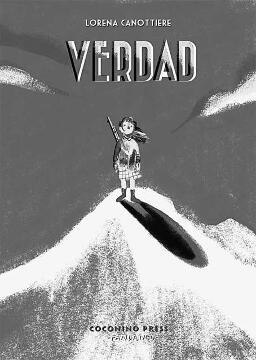 Guardate
dunque, guardate intensamente queste pagine in tempi di soddisfazioni
effimere – godete del suo segno caldo, della varietà
di particolari e di impostazioni delle tavole, del mix di strumenti
usati tecniche usate (acrilico, pastelli, grafica digitale),
e soprattutto dei colori: il rosso scuro, brunito, ramato; il
giallo che vira quasi al verdognolo; gli inserti improvvisi
di celeste. Guardate
dunque, guardate intensamente queste pagine in tempi di soddisfazioni
effimere – godete del suo segno caldo, della varietà
di particolari e di impostazioni delle tavole, del mix di strumenti
usati tecniche usate (acrilico, pastelli, grafica digitale),
e soprattutto dei colori: il rosso scuro, brunito, ramato; il
giallo che vira quasi al verdognolo; gli inserti improvvisi
di celeste.
Insisto su questo elemento perché la storia, in Verdad,
è volutamente e costantemente resa “liquida”
da una gestione della trama che procede per lo più tramite
suggestioni e salti temporali. Protagonista è una giovane
guerrigliera anarchica, impegnata nella guerra di Spagna contro
i franchisti: Verdad, appunto. Il suo nome contiene un omaggio
a un altro luogo classico del cosmo libertario, il Monte Verità
in Svizzera. È qui che la madre della protagonista ha
vissuto, sperimentando nuove forme di aggregazione sociale e
attirando su di sé l'ira e la condanna della famiglia.
Una madre che Verdad non ha mai conosciuto (l'ha abbandonata
quand'era piccola), ma di cui serba il ricordo e l'ispirazione
sia durante l'infanzia sia nei giorni duri del combattimento.
Scrive Ettore Gabrielli su Lospaziobianco.com: “L'adesione
entusiastica e quasi sacrificale alla resistenza antifranchista
diventa quindi non solo la lotta per un ideale di libertà
ma un tentativo di riscatto personale, la ricerca di un proprio
posto nel mondo e un modo per dimostrare alla madre di poter
essere se stessa e di poter essere viva senza scappare dalle
proprie responsabilità.”
C'è però un'ambivalenza. (Tutto questo fumetto
è percorso da ambivalenze, da forze contrastanti, da
solitudini e comunità, da amori e disamori). Enrique,
il suo compagno, non ama quel nome perché ritiene che
la verità sia la fine della ricerca: la posseggono i
preti, i capi, i padroni: “tutti quelli che ti vogliono
comandar la vita!”, grida. E non è un caso che
questo fumetto proceda di continuo senza mai fermarsi, sia come
animato da una forza di fuga continua; è in transito
come sempre in transito dovrebbe essere il momento rivoluzionario,
nelle parole di Enrique. Non contiene verità, e non la
conterrà nemmeno nel finale (ci arriviamo fra poco).
A fungere da sfondo di tutte queste vicende, ma con autentiche
virtù di personaggio, è la montagna del sud spagnolo,
disegnata da Canottiere con una forza e una semplicità
commoventi. I boschi, le caserme dei combattenti, i sentieri,
i villaggi, la grotta dove Verdad si rifugia per continuare
solitaria la sua lotta – è difficile trovare qualcosa
di meglio nella produzione fumettistica recente.
Ma c'è di più. Su questo tronco di realismo –
non c'è nulla di banale o raffazzonato nelle scene di
guerriglia antifranchista – Canottiere innesta un ramo
di fantasia. La storia trascolora nella fiaba, sostenuta da
un mito elementare per cui il mondo è diviso fra predatori
e prede. Verdad stessa si muove su questo bilico. Come spiega
bene Serena di Virgilio nella sua recensione per Panorama.it,
l'indipendenza della protagonista “fa di lei una “volpe”,
una sorta di strega che vive da sola tra i monti, un bandito
a cui non è permesso uscire allo scoperto perché
il regime e la gente le sono ostili.”
Verdad, con la sua fragilità e la sua determinazione,
non sopravviverà al destino che sembra richiudersi sopra
di lei. Ma come dicevo, il finale è caratterizzato dall'assenza
di una verità definitiva, di una morale. Già:
questo racconto di due donne libere, una madre e di una figlia
che non si ritrovano, questa storia di anarchia e autonomia,
non termina in maniera chiara. L'epilogo ci riporta di nuovo
nel mito: una panoramica di valli e foreste, che si stringe
lentamente su una casa abbandonata dentro cui vediamo una volpe
serrare fra i denti una preda. A fungere da supporto c'è
solo qualche didascalia, breve ma estremamente intensa: ciò
che resta è “l'acceso rimorso che lascia solo l'amore
e la vertigine di chi non vuole credere che sia tutto inutile.”
Ostinarsi a non credere che sia tutto inutile: difficile trovare
parole migliori per raccogliere la vita di Verdad – e
per lanciare un monito che suona terribilmente urgente, terribilmente
attuale.
Giorgio Fontana
Quando lo stupro è etnico/
Il caso Serbia
Il saggio di Simona Meriano Stupro etnico e rimozione di
Genere. Le vittime invisibili (Edizioni Altravista, Pavia,
2015, pp. 162, € 18,00) offre uno sguardo antropologico
al fenomeno degli stupri etnici, alle complesse implicazioni
sociali, culturali, politiche e giudiziarie che li portano ad
essere rimossi da tutte le storie di guerra. Gli stupri di massa
vengono altresì considerati nel rapporto tra potere e
memoria.
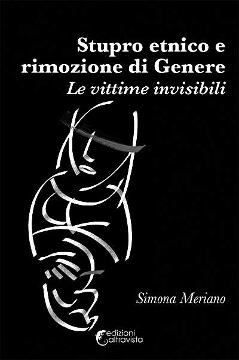 Simona
Meriano inquadra la tematica nel più ampio contesto della
storia del Novecento. Se nel secolo XX lo spostamento delle
azioni violente di stupro è avvenuto passando da “diritto
momentaneo”, concesso dopo le conquiste di un centro abitato,
a strategia politica militare già prestabilita, dopo
la guerra di Bosnia-Erzegovina, gli stupri di guerra costituiscono
un'emergenza planetaria. Simona
Meriano inquadra la tematica nel più ampio contesto della
storia del Novecento. Se nel secolo XX lo spostamento delle
azioni violente di stupro è avvenuto passando da “diritto
momentaneo”, concesso dopo le conquiste di un centro abitato,
a strategia politica militare già prestabilita, dopo
la guerra di Bosnia-Erzegovina, gli stupri di guerra costituiscono
un'emergenza planetaria.
Cinquant'anni dopo Auschwitz, il conflitto nei Balcani si è
tramutato in un piano di sterminio della popolazione civile.
Per creare la grande Serbia, i villaggi vengono depurati dalla
popolazione civile musulmana, gli uomini mutilati e uccisi,
le donne stuprate. Tra il 1992 e 1995, lo stupro di massa, la
violenza sulle bambine, le gravidanze forzate creano l'illusione
di poter modificare la composizione etnica della Bosnia Erzegovina
costringendo le donne musulmane a partorire figli di “razza
pura serba”.
Tuttavia fallisce il tentativo di creare un nuovo stato etnico
puro, poiché i bambini nati dagli stupri sono invisibili,
anche se l'identità abortiva risulta ancora più
perdente dell'identità invisibile.
L'autrice parte dall'assunto che considera lo stupro etnico
espressione sintomatica della finzione identitaria voluta da
un “noi” maschile, sedicente superiore, che sceglie
e definisce l'alterità due volte, in base a criteri etnici
e di genere. Nello specifico, nello stupro etnico in Bosnia-
Erzegovina, l'identità di genere dominante maschile e
l'identità di etnia superiore serba sarebbero arbitrariamente
costruite e armate contro la donna, due volte “altra”.
Infatti, nell'immaginario maschile serbo, le donne bosniache
musulmane assumono le sembianze delle femmine turche. Colpevoli
di tradimento a causa della conversione all'islam da parte dei
loro antenati, sono utilizzate per attuare la pulizia etnica
in nome della vendetta serba.
Interessante la ripresa della questione sollevata dall'antropologo
Ugo Fabietti (1995) sull'ambiguità del concetto di etnia.
Designerebbe, infatti, gruppi dotati in modo fittizio di una
irriducibile identità linguistico-storico-culturale.
Nel momento in cui si crea e definisce un “noi”,
nascono i “loro”, entità sociali costruite,
ma vive, che interagiscono e hanno un ruolo nella storia. Il
processo mentale di differenziazione potrebbe indurre a un allontanamento
fisico e simbolico dell'altro, per spingersi fino alla sua soppressione.
L'origine della violenza di genere andrebbe quindi ricercata
nell'etnicità.
L'uomo serbo che intende conquistare la terra e sterminare il
nemico di fatto si identifica con lui attraverso il corpo violentato
della donna resa madre, colmando così lo spazio che separa
la vittima dal suo carnefice.
Viene messa altresì in evidenza la legittimazione di
pratiche violente pianificate da parte di un'oligarchia politica.
Mosso da odio e desiderio, lo stupro etnico è considerato
sempre uno stupro di gruppo. L'essere collettivo sovrasta l'uomo
singolo. Il gruppo che stupra, connotato etnicamente, si sintetizza
nel mito del centauro: la regressione della mascolinità
al branco animale e alla forza fisica data dal numero, come
risposta allo smarrimento dell'identità maschile. Inoltre,
il gruppo sovrasta l'uomo singolo. È un “noi”
che decide e interagisce, nel quale però si perdono responsabilità
individuali e penali.
Quindi, lo stupro di gruppo non come patologia individuale,
ma come potenziale comportamento nei maschi, rituale collettivo
per ristabilire la gerarchia di genere e la supremazia etnica.
Se il ricorso alla memoria può mantenere viva una cultura
dominante maschile, lo stupro etnico cancella ogni memoria di
emancipazione e libertà femminile: stupratori si accaniscono
contro le donne bosniache musulmane più colte e con ruoli
nel mondo del lavoro, come sindacaliste, burocrati, insegnanti,
segretarie, presenze nei quadri dirigenziali o intermedi.
Parimenti, l'attenzione dell'autrice si focalizza sulle vittime
invisibili. Nonostante nel 1993, la risoluzione n. 827 del consiglio
di sicurezza dell' Onu abbia istituito il tribunale penale internazionale
per la ex Jugoslavia con sede all' Aja, con il compito di giudicare
i responsabili dei crimini contro l'umanità e genocidio
nelle guerre balcaniche, e nel 2001 lo stupro venga riconosciuto
come un crimine contro l'umanità includendo il reato
di schiavitù sessuale, solo nel 2008 il consiglio di
sicurezza dell'Onu assumerà una ferma presa di posizione
contro gli stupri come arma di guerra.
Ma sussiste ancora oggi il problema del riconoscimento dello
status di vittime civili di guerra. Infatti, lo stupro contamina
in modo irreversibile chi lo subisce, distrugge l'identità,
tuttavia non ne crea un'altra: donne bosniache musulmane sopravvissute
allo stupro di massa sono emarginate dalla loro gente, ma nemmeno
vengono accolte nella comunità serba. Gli stessi bambini
nati dalle violenze non incarnano affatto la “pura essenza
serba”, sono individui dall'identità inafferrabile,
rifiutati, spesso abbandonati ai margini della società.
Inoltre, si sottolinea quanto nelle società patriarcali,
come quella balcanica, venga esercitato il controllo sessista
sull'informazione e sui contenuti dei ricordi, favorendo il
perdurare della supremazia maschile, il silenzio e il distacco
della memoria, mezzi di oppressione per privare un gruppo o
una minoranza della propria coscienza identitaria.
Il riferimento al contributo dell'antropologo Arjun Appadurai
(2001) consente di cogliere meglio gli effetti della comunicazione
di massa sull'immaginazione nella costruzione di soggetti sociali
e le connessioni tra la propaganda bellica e immagini dello
stupro.
La riflessione è condotta sugli stupri di guerra documentati
in rete ai quali non corrisponde un adeguato sviluppo dell'empatia,
condizione indispensabile per superare la passività nei
confronti del potere sociale e culturale, ed esercitare la responsabilità
individuale.
Simona Meriano chiama in campo gli obiettivi della Piattaforma
di Pechino approvati nella IV Conferenza mondiale sulle donne
(1995). Nel documento si ribadisce un principio fondante: mantenere
la prospettiva di genere al fine di integrare le tematiche delle
relazioni tra maschile e femminile in tutti gli obiettivi strategici
che si intendono perseguire, dalla soluzione dei conflitti armati,
alla costruzione di politiche per la pace.
A più di vent'anni dalla conferenza di Pechino, seppur
nel variegato e accidentato percorso, la prospettiva glo-cale,
con iniziative promosse dal basso che coinvolgano il quotidiano
in proposte concrete, è da incoraggiare e incentivare,
in un continuo dialogo cercato e coltivato con la componente
maschile. Auspicabile partire, ancora, da un approccio educativo
e formativo mirato, per aiutare a cogliere anche forme occulte
di discriminazione e violenza simbolica veicolate dalla cultura
dominante maschile, segnali anticipatori di aumento progressivo
di violenza agita.
Una pratica per riconoscere e contrastare modelli convenzionali
stereotipati introiettati in modo a-critico nell'immaginario
collettivo, che confermano e rinforzano l'omologazione ai prototipi
tradizionali.
Claudia Piccinelli
Kurdistan/
Per i bambini del Rojava

Il
Kurdistan non esiste, o almeno non sulle carte mondiali
fatte da confini, nazioni e continenti. Il Kurdistan è
soltanto terra, è un vasto altipiano medio orientale
parte di quella regione che un tempo vide fiorire grandi
civiltà, chiamata Mesopotamia.
La questione territoriale curda risale a tantissimi anni
fa: basti pensare che la sua prima spartizione ebbe luogo
nel 1639, con il trattato di Qasr-e Schirin stipulato
tra l'Impero Ottomano e la Persia. La sua dissoluzione
territoriale definitiva ebbe luogo nel 1923 con la modifica
del trattato di Sevres, causata dall'insoddisfazione turca
in seguito alla spartizione dell'impero ottomano.
Con la stipula del trattato non solo la Turchia, l'Iran,
l'Iraq e la Siria diventavano stati nazionali, ma assieme
alla loro nascita si assisteva alla scomparsa dei diritti
per i curdi: questi da allora hanno subito accuse e discriminazioni
da parte dei quattro stati nazionali.
In risposta alla condizione curda, nel 1978, quello che
fino ad allora era stato un movimento diventava un partito
politico: il PKK (Partito dei Lavoratori del Kurdistan).
Sotto la guida di Abdullah Öcalan questo soggetto
politico si rifaceva alle teorie marxiste-leniniste per
avvicinarsi, attualmente, alle posizioni di un socialismo
libertario con il sogno del confederalismo democratico.
Nell'ultimo decennio infatti il movimento per la liberazione
curda ha subito una vera e propria trasformazione ed ha
posto come suoi fondamenti l'autonomia, il femminismo,
la democrazia diretta e l'ecologia.
Nella Rojava, regione del Kurdistan siriano, tristemente
nota per gli attacchi e i massacri compiuti per mano di
Daesh (ISIS per gli occidentali), si sta assistendo ad
una vera e propria rivoluzione rispetto alla partecipazione
popolare e alla creazione di forme di autogoverno.
Proprio per sostenere e raccontare questa resistenza,
questo esperimento rivoluzionario, nasce il progetto “Rojava
Resiste: cuori e mani per il Kurdistan”. Il gruppo
è formato da alcune attiviste e da alcuni attivisti,
artisti di Milano e dintorni appartenenti a diverse realtà
sociali dell'autogestione.
Nell'ottobre 2015 il gruppo decide di compiere un viaggio
nel Bakur, Kurdistan settentrionale, in Turchia, per raccontare
la scelta coraggiosa di un popolo, denunciare le prevaricazioni
del governo turco e portare solidarietà tra le
strade assediate, tra i campi profughi e nelle zone liberate
che hanno proclamato l'autonomia.
Proprio da questa esperienza è nato un reportage
a vignette realizzato da “Rojava Resiste”
e “Vermi di Rouge” dal titolo Cuori e mani
per il Kurdistan. Con la prima edizione, uscita nel
febbraio 2016, ed esaurita in qualche mese, sono stati
raccolti 2.660 euro che sono stati donati al progetto
“Bimbi di Kobane” (www.bimbidikobane.com),
associazione nata per aiutare i bambini della città
di Kobane che hanno perso i genitori combattendo contro
l'ISIS.
A dicembre 2016 è uscita una nuova riedizione di
questo lavoro. L'opera, composta da 46 pagine, è
stata arricchita con nuove tavole che non raccontano solamente
la situazione curda, ma anche alcuni momenti del viaggio:
dai campi profughi al coprifuoco imposto dal governo turco,
fino alle manifestazioni di piazza.
Inoltre il volume reca un piccolo “glossario”
in cui vengono riportate le sigle ed i nomi dei diversi
movimenti che animano la resistenza e i nomi Kurdi di
alcune zone, una mappa che riporta la spartizione del
territorio ed una breve cronologia dei principali eventi
che hanno influenzato la lotta curda negli ultimi due
anni.
All'interno vi sono poi alcune fotografie delle opere
di street art realizzate dall'artista “Vermi di
Rouge” sul territorio italiano nelle sedi di collettivi
ed associazioni. Al centro del volume compare il bellissimo
murale realizzato, o meglio iniziato, durante il viaggio
nel centro culturale curdo di Dicle-Firat di Diyarbakir.
Infatti l'attuazione del dipinto, realizzato a quattro
mani da Vermi di Rouge e da un'artista locale, Yesim,
insegnante d'arte, è stata bruscamente interrotta
dal coprifuoco, imposto per due giorni nella città
vecchia. Comunque l'opera non è rimasta incompiuta:
vedere per credere!
Troverete il volume in vendita durante gli incontri informativi
organizzati da “Rojava Resiste” oppure potete
acquistarlo on-line sul sito del progetto (www.rojavaresiste.org)
o direttamente da quello di “Vermi di Rouge”
(www.vermidirouge.com).
Il costo è di € 5,00 e gli introiti saranno
così divisi: 1/3 per i costi di stampa, 1/3 all'autore,
1/3 a sostegno del progetto (donazioni superiori a €
5,00 verranno devolute interamente al progetto “Bimbi
di Kobane”.)
Per chi già conosce l'artista ritroverà
il suo stile inconfondibile: vermi gialli, arrabbiati,
sfacciati e senza troppi peli sulla lingua. Una satira
di cui ora più che mai abbiamo bisogno non solo
per ridere, ma per riflettere. Riderete... perché
a volte bisogna ridere... per non piangere!
Camilla Galbiati
|
Biografie/
Anarchica, femmina, creativa, animalista, individualista
È uscito da poco un bel fumetto sulla vita-romanzo di
Leda Rafanelli (Leda. Che solo amore e luce ha per confine,
Coconino Press-Fandango, Roma, 2016, 21,5 x 29 cm, pp. 212,
€ 19,50) ispirato dalle sue opere edite e inedite e da
alcuni saggi sulla polimorfa anarchica-futurista-musulmana,
così come ormai veleggia la rapida biografia rafanelliana.
Sara Colaone e Francesco Satta, rispettivamente disegnatrice
e scrittore dei testi, potrebbero essergli stati sulle ginocchia,
ascoltando quanto scrive sul «Corrierino dei Piccoli»
mentre l'altro coautore Luca de Santis, non è ancora
nato quando la protagonista muore a 91 anni a Genova. La storia
su Leda, vera ed evocata, non tralascia alcuno degli elementi
ormai biografati. Qualche dubbio emerge in merito alla asserita
crisi che avverrà con la morte dell'unico figlio e con
i conseguenti dubbi sui suoi fermi convincimenti.
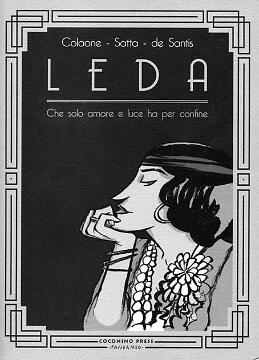 Conoscendola
per averla frequentata, anche se solo da storico, non credo
che Leda ne abbia avuti. Le sue convinzioni sono granitiche
e le contraddizioni, lette dall'esterno, sono per lei forza
e sintesi del suo sentire, e questo vale in politica come negli
affetti. Ha vissuto integralmente la sua vita senza tentennamenti,
gli altri o l'hanno accettata o rifiutata. Questo vale anche
per le scelte spirituali, testimoniate da studi e analisi. L'adesione
al sufismo l'ha, intelligentemente, largamente posta al riparo
da limiti imposti dalle dottrine e dai dogmi, rendendola libera
di darsene, quando ha voluto, chiamandoli “doveri”. Conoscendola
per averla frequentata, anche se solo da storico, non credo
che Leda ne abbia avuti. Le sue convinzioni sono granitiche
e le contraddizioni, lette dall'esterno, sono per lei forza
e sintesi del suo sentire, e questo vale in politica come negli
affetti. Ha vissuto integralmente la sua vita senza tentennamenti,
gli altri o l'hanno accettata o rifiutata. Questo vale anche
per le scelte spirituali, testimoniate da studi e analisi. L'adesione
al sufismo l'ha, intelligentemente, largamente posta al riparo
da limiti imposti dalle dottrine e dai dogmi, rendendola libera
di darsene, quando ha voluto, chiamandoli “doveri”.
I principali protagonisti citati o presenti nel fumetto sono
segnalati con foto e breve biografia in una sorta di “titoli
di coda”. Questa ulteriore opera sulla poliedrica autrice
che da diversi anni sta riscuotendo successi, deborda dalle
carte depositate nel Fondo a lei intestato, presso l'Archivio
Berneri-Chessa di Reggio Emilia dove, anche in questo
caso, la curatrice Fiamma Chessa si è adoperata per la
migliore riuscita del lavoro.
Leda, primadonna dell'Archivio, ha, contrariamente a quanto
scritto da Gino Cerrito, contribuito e contribuisce a far emergere
il proprio, ed anche nostro, anarchismo, dalla stretta cerchia:
e lo testimonia l'ormai interesse pluridecennale. La vita
è un romanzo ricorda l'incipit, e di romanzi
è ricco il suo fondo, che la rappresenta, e che con certezza,
affermiamo, continuerà a far fiorire ricerche, lavori,
e chissà, pièce teatrali e film.
Per i lettori di “A” non ci addentriamo nella biografia,
trattandosi di una figura assai nota, e chi vuole può
agevolmente muoversi fra le schede del Dizionario degli Anarchici,
o del Futurismo cercando elementi che tratteggino più
e meglio che in questa sede, la sua particolare, multiforme,
ed intensa vita. Anarchica, donna e femmina, vegetariana,
creativa, animalista, individualista, militante attivissima,
grande lavoratrice, ha interessato, dai rari lavori di Pier
Carlo Masini di molti anni fa, una folla di storici, in particolare
donne, che via via hanno scoperto la prolifica scrittrice ed
animatrice culturale e politica. Negli anni sono stati prodotti
molti saggi e articoli, racconti e interpretazioni, tesi e mostre.
Il sottotitolo del fumetto del quale oggi parliamo (non mi piace
graphic novel) è preso pari pari dal logo
della Libreria Editrice Sociale, nelle sue diverse versioni,
definizioni e luoghi fisici di attività. Un simbolo di
Arte&Anarchia da lei praticata come tipografa militante
e disegnato come altri, dall'allora pittore anarchico (anni
Dieci del Novecento) Carlo Dalmazzo Carrà, anch'esso
attratto e innamorato di Leda. La LEF, in origine Polli-Rafanelli,
inizia a Firenze per spostarsi a Milano, dove prosegue essenzialmente
con l'apporto, anche affettivo, di Giuseppe Monanni, dal quale
avrà l'unico figlio Aini (Marsilio).
Questa toscana di Pistoia, sposatasi con il fiorentino Luigi
Polli “conosciuto ad Alessandria d'Egitto” in quella
comunità anarchica derivante dai lavori per l'apertura
dello stretto di Suez, ha avuto frequentazioni con Masini, ma
anche con Maurizio Antonioli, Nico Berti e altri, i quali hanno
avuto più volte modo di parlarne e scriverne.
Oggi la incontriamo attraverso una grafica morbida, a pennarello
acquarellato, con copertina bohémien leggermente
nouveau. Il fumetto è stampato su carta pesante,
in grande formato, con 210 pagine in bianco/nero dove solo la
copertina ha leggeri segni di colore, come un femminile piccolo
trucco. Il fumetto vero e proprio si sviluppa su 198 pagine,
con strisce o disegni volanti a pagina intera o frammenti con
dialoghi inseriti in nuvole di forme continuamente diverse,
in qualche caso con scritte fluttuanti, o concentrate in ritmi
ad effetto collage. I disegni, con bordi a pennarello,
sono spesso ampiamente acquarellati e sfumati. Il testo racconta
le sue vicende di vita, di lavoro anche politico, che è
bello vedere e gustare senza alcuna mediazione del recensore.
Ormai novantunenne, “fa le carte” ad una cliente,
e da qui, come in una sorta di flash back, torna più
volte con la memoria al proprio percorso di vita.
Dall'infanzia con l'amato fratello Metello, al lavoro in tipografia,
all'incontro con la politica e la spiritualità, alla
lotta e l'impegno: agli amori. Non ho intenzione di raccontare
un racconto, lasciando libero il lettore, invitandolo a
questo compito. Solo due appunti su tutti i possibili.
Il primo riguarda il “passaggio” da Alessandria
d'Egitto, fonte inesauribile del suo essere donna anarchica
e musulmana Sufi. C'è stata veramente? E quanto? Gli
autori, in maniera sagace, risolvono la questione in questo
modo. Durante un importante e movimentato sciopero a Firenze,
l'emozione, il coinvolgimento, la massa, la folla roboante e
vociante, estrania Leda, che viene catapultata in una felice
Babele di lingue e di figure, di incontri definitivi. Nel dubbio,
gli autori scelgono un viaggio tutto mentale, ed a nostro parere,
la scelta è felice.
Secondo appunto (forse per ragioni di notorietà del coinvolto),
il fumetto si sofferma troppo, rispetto all'insieme, sul rapporto
intrattenuto con Benito Mussolini.
Alberto Ciampi
Il cibo, un diritto per tutti/
Tre volte al dì
Ho iniziato a leggerlo pervaso da un po' di sano scetticismo.
Temevo pregiudizialmente che si trattasse dell'ennesimo trattato
para/universitario, infarcito di una buona dose di saccenteria
accademica. Sono invece stato preso dalla lettura fino a convincermi
che al contrario si tratta di un “gran libro” (Cibo
e utopia – l'eterna lotta tra carnevale e quaresima,
di Pierpaolo Pracca e Edgardo Rossi, Aracne editrice, Ariccia
- Rm, 2015, pp. 332, € 20,00).
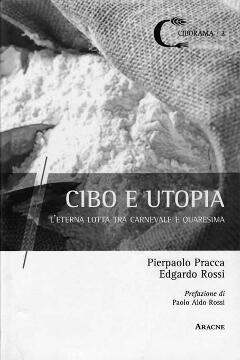 La
sua insita bellezza deriva da ciò che riesce a trasmettere.
Pracca e Rossi, i due compagni autori, non solo si sono accinti
a studiare il rapporto, molto politico ovviamente, tra “utopia”
e “cibo”, ma hanno scritto con tensione e gran passione,
totalmente immersi nell'inquietudine utopica che caratterizza
tutti gli amanti, fanatici come direbbe Bakunin, della libertà,
insoddisfatti, fino a essere incazzati, del presente che continua
a sommergerci tirannicamente. La
sua insita bellezza deriva da ciò che riesce a trasmettere.
Pracca e Rossi, i due compagni autori, non solo si sono accinti
a studiare il rapporto, molto politico ovviamente, tra “utopia”
e “cibo”, ma hanno scritto con tensione e gran passione,
totalmente immersi nell'inquietudine utopica che caratterizza
tutti gli amanti, fanatici come direbbe Bakunin, della libertà,
insoddisfatti, fino a essere incazzati, del presente che continua
a sommergerci tirannicamente.
È un testo dotto senz'essere dottrinario e profondo,
vissuto con mente lucida e intensa emozione. Cerca di scoprire
la “pentola” delle tensioni umane, le quali, sebbene
stimolate dal bisogno biologico di cibarsi, da sempre non si
accontentano semplicemente di riempirsi la pancia, mentre pretendono
e sognano di farlo animati da spirito di emancipazione, spinti
dal desiderio di emergere dagli stati di subordinazione cui,
nei millenni del cammino collettivo della specie, sono stati
costretti e continuano ad esserlo. Una ricerca che conferma
ampiamente ciò che, senza esserlo affatto, può
esser travisato come banale: il sogno di vivere bene; l'utopia
insomma, si combina ed è strettamente legata alla voglia
e al bisogno di mangiare al meglio, perché il vero desiderio
che preme dal profondo delle pulsioni biologiche è proprio
quello di vivere felicemente e di conoscere soddisfazioni il
più possibile.
La connessione tra “cibo” e “utopia”,
come mette bene in risalto il sottotitolo L'eterna lotta
tra carnevale e quaresima, è un rapporto carico di
conflittualità e manifesta tensioni radicalmente opposte
tra loro. Da una parte la ricerca, fin dall'antichità,
di pulizia e purificazione, di bisogno di emendarsi, che si
riconosce in diete vegetariane che rifiutano la contaminazione
delle carni in tutte le loro varianti. Dall'altra la rappresentazione
di succulenti desideri traboccanti opulenza, dove la sovrabbondante
enormità dei cibi sognati manifesta il bisogno di uscire
dall'indigenza e dalla penuria imposti dalla prepotenza dei
potenti.
“Una cosa è certa: il cibo nei mondi Utopici diventa
un marcatore culturale, un principio identitario, in quanto
ciò che si mangia è il riverbero dell'impianto
ideologico sul quale si fonda un determinato immaginario sociale;
il cibo quindi, come insegna Claude Lévi-Strauss (1908
– 2009), deve essere non solo buono da mangiare, ma anche
buono da pensare. Ed è esattamente per questo motivo
che, nella storia dell'umanità, il sogno della riforma
sociale è andato di pari passo con l'idea di una riforma
alimentare” (pag. 31).
Com'è giusto che sia, il viaggio comincia dall'antichità,
dai primordi, dalla mitologica e agognata “età
dell'oro”. Dai cibi dei primi racconti allegorici delle
religioni, “la storia delle religioni è ricca di
riferimenti a bevande magiche, a pozioni, a cibi divini”
(pag. 34), a Esiodo, al Platone de “La Repubblica”,
al ricco cibo effettivamente mangiato dall'aristocrazia romana
opposto a quello povero delle plebi, che di contrasto sognavano
banchetti luculliani. “Pare evidente il netto contrasto
tra la reale vita quotidiana della plebe e l'opulenza della
classe patrizia che da una parte vedeva la miseria e dall'altra
una alimentazione eccessiva capace di cagionare gravi malattie
da eccesso. [...] Il cibo diventa un marcatore culturale, sociale
ed anche politico capace di evidenziare le differenze tra classi.
Non è un caso che a Roma spesso il politico in cerca
di consensi spesso offrisse il famoso panem, talvolta unito
al circenses” (pag. 64).
È un excursus, fondamentalmente incentrato sull'occidente,
che ne attraversa tutte le epoche culturali, confrontandosi
anche di tanto in tanto con altre civiltà. Dal significato
del cibo per gli ebrei, per i quali “l'alimentazione ha
costituito un segno fondante dell'alleanza tra uomo e Dio”
(pag. 73), alle diete della cristianità, dove assume
un'importanza predominante l'utopia agostiniana della “Città
di Dio”: “si passa dall'idea platonica di stato
come governo retto dai filosofi a quello stato inteso quale
strumento della divina provvidenza” (pag. 87). Scelta
sostanzialmente legata alla penitenza, perché tutta l'utopia
cristiana è impregnata del senso del peccato originale,
coincidente con un peccato di gola per aver mangiato il pomo
della conoscenza proibito da Dio.
Un dettato teologico che contraddice in modo vistoso le tavole
dei nobili medioevali, riccamente e viziosamente imbandite,
spudoratamente contrastanti con la povertà dei contadini.
“Per il popolo la razione di cibo giornaliera spesso era
scarsa, la netta divisione sociale si manifestava in maniera
eclatante sulle tavole, o troppo ricche di cibo, o molto povere
[...] se da un lato si inseguivano sogni miranti ad un'alimentazione
pura o benedetta, dall'altra non si esitava a nutrirsi in abbondanza
contravvenendo le regole che la Chiesa imponeva [...] il Medioevo
fu un periodo di eccessi dove carnalità e spiritualità
si confrontavano e si mescolavano dando vita a sogni infiniti”
(pag. 92).
Questa condizione rappresentò una spinta irrinunciabile
per “una contro utopia che si propone immediatamente come
il rovesciamento della concezione quaresimale”. Presero
così forma i vari miti e le diverse fantasie che ostentavano
il sogno di un'abbondanza e di un benessere negati, che assumevano
la forma di magnificenze gastro/culinarie. I più noti
sono il “Paese di Cuccagna” e il “Regno di
Bengodi”. Tensioni e contrapposizioni sovversive che si
perpetuano, attraversano il Rinascimento e continuano a propagarsi
evolvendosi. Significative le smisurate abbuffate dei giganti
Gargantua e Pantagruele descritte da Rabelais nel cinquecento,
che fra l'altro danno forma all'abbazia di Theleme, insuperato
luogo immaginario dove vige una libertà anarchica totale
e in cui l'unica regola è: fa ciò che vorrai.
“L'utopia di Theleme è un attacco in piena regola
all'insegnamento tradizionale” (pag. 142).
Cibo e utopia sottolinea in continuazione come il cibo, approntato
e consumato, mostri in ogni epoca le differenziazioni di classe,
prova prima dell'ingiustizia sociale che beneficia i privilegiati
e condanna i deboli e sofferenti. Allo stesso tempo il cibo
immaginato e desiderato rappresenta una autentica forza sovversiva,
uno stimolo fondamentale per dare forma a utopie sociali dove
si realizzano giustizia e benessere per tutti nella realtà
negati.
Il libro prosegue fino ai giorni nostri, attraversando l'Illuminismo,
le diverse utopie politiche della rivolta moderna e delle tensioni
rivoluzionarie otto/novecentesche. Si addentra con disinvoltura
e colta consapevolezza nella controcultura americana degli anni
sessanta del secolo scorso in uno splendido capitolo, “La
controcultura americana e l'assalto al paradiso - la droga come
cibo degli dei”, che ritengo sia una delle cose migliori
scritte sulla “beat generation”. S'inoltra pure
nel meraviglioso viaggio delle avanguardie artistiche, fino
alle performance della Mail-art e di Fluxus, dove il cibo è
elemento fondante di autentiche provocazioni. “Fluxus
vuole far regredire il mito dell'artista elevando l'arte ad
espressione elementare di un desiderio creativo che non è
più appannaggio di una elite culturale ma è alla
portata di tutti” (pag. 276).
Non poteva che finire dicendo con forza che i due autori hanno
un “desiderio potente”, antitetico al modello di
sviluppo attuale, ma che si protende ugualmente verso un'utopia
che spererebbero possibile. Di fronte al mondo attuale, che
sembra irrimediabilmente finalizzato a soddisfare un'esigua
minoranza che s'impone prepotentemente su tutti gli altri, l'utopia
desiderata è proposta con queste parole: “Vogliamo
un mondo dove a tutti i popoli, a tutti i singoli uomini, donne
e bambini, vengano garantiti tutti i giorni tre pasti, e con
un cibo sufficiente a nutrire il loro corpo e la loro mente.
Un cibo che sia sano, buono e giusto e permetta a tutti di essere
migliori, perché il cibo deve essere un diritto condiviso,
non un privilegio o un lusso e neanche uno strumento di commercio”
(pag. 316).
Andrea Papi
|

