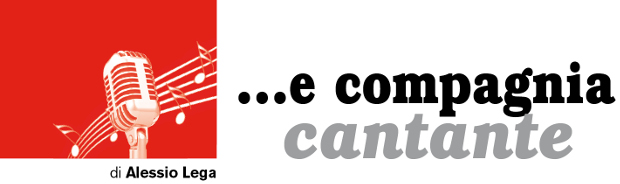
Dylan e il Nobel
Che pasticcio: per la prima volta il Premio
per antonomasia viene assegnato a un grande cantautore che però
non lo rifiuta, ma peggio, lo snobba.
Questa rubrica è nata per parlare di musicisti (per
lo più) stranieri, quelli che non passano mai alle radio,
che non si trovavano mai nei negozi di dischi (quando questa
rubrica è nata, quindici anni fa, ce n'erano ancora parecchi
di questi negozi, ed erano un vettore importante di diffusione
della musica), e così abbiamo parlato di francofoni,
ispanici, slavi, ci ripromettiamo sempre di farlo anche di greci,
di mediorientali (se non lo abbiamo fatto è solo perché
ancora si fatica a superare certe barriere linguistiche per
avere alcune minime informazioni).
Poco o addirittura pochissimo abbiamo fatto per i cantanti di
lingua inglese, non perché non ce ne siano a caterve
che amiamo follemente (così per dire i primi che mi vengono
in mente Phil Ochs, Woody Guthrie, Randy Newman, ecc.), ma nella
convinzione che questa rubrica servisse a rompere il silenzio
su un mondo intero che cantava in lingue la cui musica era per
noi sconosciuta, e che invece chi canta in inglese, anche da
una posizione ribelle, outsider, minoritaria, abbia sempre avuto
modo di contare sulla più potente possibilità
di diffusione.
È per questo che non abbiamo mai sfiorato una vetta imprescindibile
della cultura del secondo novecento: Bob Dylan. Ma ora - in
un momento di frivolezza - vogliamo cogliere proprio l'occasione
dell'assegnazione del Premio Nobel e della surreale sarabanda
mediatica che è seguita sul Premio in sé - per
la prima volta assegnato a un cantante folk e rock - e sulla
stranissima reazione di Dylan, che per un bel po' s'è
reso irreperibile (Sic) e poi ha detto che, pur essendone onorato,
non si sarebbe presentato di persona a ritirarlo, adducendo
pretesti (“impegni precedenti”) che nella loro vaghezza
sono risultati pretestuosi, se non propriamente scandalosi.
Proviamo ad intenderci, Bob Dylan è un genio, un poeta
violento nelle immagini, raffinato linguisticamente e di una
ricchezza creativa persino imbarazzante. Ha rivoluzionato il
linguaggio in cui ha lavorato tre o quattro volte. Ragazzino
ebreo proveniente da una provincia immobile e per nulla florida
dell'America profonda, è arrivato a New York al principio
degli anni sessanta sull'onda di una piena che portava centinaia
di aspiranti artisti a partecipare agli albori di una rivoluzione
di costume che aveva nella musica (e in particolare nella musica
folk) la propria avanguardia. Fame di successo e sincera rabbia
di vivere, affermazione personale e dinamiche generazionali
sono gli inestricabili fattori che hanno fatto di Dylan il cantore
più rappresentativo di un'epoca, l'artista che pur non
svelandoci nulla e rifiutando ogni ruolo, è il prisma
che tutto assorbe e attraverso cui tutto si scompone. Dylan
era della generazione che, cresciuta nella miseria culturale
degli anni del maccartismo (amplificata dall'appartenenza a
una minoranza e dal confine provinciale), aveva percepito la
propria affermazione fisica nel rock and roll di Elvis che presupponeva
un'indicibile radice nera, ma si era poi raffinata e irrobustita
culturalmente e politicamente con la poesia beat, le battaglie
contro la discriminazione, la riscoperta di una controcultura
popolare che aveva nel già malatissimo Woody Guthrie
il proprio mito fondativo.
 Quando
Dylan arriva quell'ambiente già brulica, ma vi è
qualcosa di più radicale nel suo cantare sgraziato e
memorabile, nel suo suonare perentorio e senza virtuosismi,
nella capacità di scrivere in modo allegorico e narrativo
assieme. Un pugno di canzoni di protesta scritte in meno di
un lustro permangono a distanza di oltre cinquant'anni così
solide nell'immaginario da far definire “menestrello sociale”
un artista che ha smesso da allora di assumere posizioni leggibili.
Poi era già il tempo della “svolta elettrica”,
che gli guadagnò l'epiteto di “Giuda”, poi
una ridda di mutamenti che potevano comprendere talvolta un
vago fulmineo ritorno a una battaglia sociale, talvolta conversioni
a qualche setta cristiana. Su tutto un artista inclassificabile,
anticonformista, sfuggente, che certo dagli anni ottanta non
ha più prodotto solo capolavori, ma che ha avuto modo
di dimostrare che qualche capolavoro poteva pur sempre produrlo
(a modesto avviso di chi scrive, l'ultimo fino a oggi “Love
and theft” del 2001). Quando
Dylan arriva quell'ambiente già brulica, ma vi è
qualcosa di più radicale nel suo cantare sgraziato e
memorabile, nel suo suonare perentorio e senza virtuosismi,
nella capacità di scrivere in modo allegorico e narrativo
assieme. Un pugno di canzoni di protesta scritte in meno di
un lustro permangono a distanza di oltre cinquant'anni così
solide nell'immaginario da far definire “menestrello sociale”
un artista che ha smesso da allora di assumere posizioni leggibili.
Poi era già il tempo della “svolta elettrica”,
che gli guadagnò l'epiteto di “Giuda”, poi
una ridda di mutamenti che potevano comprendere talvolta un
vago fulmineo ritorno a una battaglia sociale, talvolta conversioni
a qualche setta cristiana. Su tutto un artista inclassificabile,
anticonformista, sfuggente, che certo dagli anni ottanta non
ha più prodotto solo capolavori, ma che ha avuto modo
di dimostrare che qualche capolavoro poteva pur sempre produrlo
(a modesto avviso di chi scrive, l'ultimo fino a oggi “Love
and theft” del 2001).
Il giorno delle locuste
Se c'era un rocker, uno solo, a cui fosse possibile assegnare il Nobel, questi non poteva essere che lui, non si poteva iniziare che da lui, quasi fosse scontato, quasi lo avesse già vinto e l'annuncio che inevitabilmente ne doveva venire non dovesse che ratificare un'eccellenza che chiunque o quasi si sia occupato di canzoni gli aveva già riconosciuto da così tanto tempo che era quasi scontato sostenerlo. “È come appuntare una medaglia sul monte Everest”, ha commentato con un pizzico di civetteria Leonard Cohen (un altro cui molti ritenevano potesse andare il sommo riconoscimento letterario) pochi giorni prima di morire.
È qui che l'artista che ha sempre scelto di non essere rassicurante, che non concede nulla al suo pubblico stravolgendo, talvolta in modo interessante per lo più straziandole, canzoni fra le più importanti mai scritte, ma che vive letteralmente la sua vita in una tournée “infinita” che non conosce requie dal 1988, è proprio qui che Dylan ha sparigliato ulteriormente le carte, negandosi con quello che molti hanno interpretato, prima in modo quasi divertito poi con un isterico dispetto, come un supremo atto di snobismo, come una mancanza di rispetto inqualificabile.
C'erano forse troppe attese collettive per questo Premio - che ratificava una volta per tutte che la Canzone è letteratura - per poter permettere a Dylan di assumere un comportamento che, a ben guardare, è coerente con la propria storia: questo era un Premio percepito come collettivo, un Premio alle decine di musicisti che hanno influenzato milioni di persone, Dylan sarebbe dovuto essere solo il rappresentante della categoria. Ma lui non rappresenta nessuno, avendo smarrito da lungo tempo persino se stesso.
La posizione a dir poco ambigua di Dylan riguardo ai premi è nota sin dal '63, quando il suo manager Albert Grossman riuscì a collocarlo come ospite d'onore alla cerimonia di consegna del Tom Paine Award dal National Emergency Civil Liberties Committee, un premio importante in un ambiente radical chic e danaroso, una sorta di precoce consacrazione per un artista di 22 anni. Lì, durante il suo discorso di ringraziamento - in cui peraltro diede l'impressione di essere completamente ubriaco - suscitò un vero scandalo: “Vorrei non vedere voi qui davanti, gente senza capelli, che dovrebbe essere in spiaggia a nuotare... dovreste essere a riposo, dovreste essere in vacanza a rilassarvi... questo non è un mondo per gente vecchia... quando i vecchi perdono i capelli dovrebbero togliersi dai piedi... guardo quelli che mi governano e vedo che non hanno capelli in testa... e parlano dei negri, e parlano dei bianchi e dei neri... e parlano di rossi, blu e gialli” e concluse con uno scioccante riferimento all'assassinio di Kennedy avvenuto solo tre settimane prima: “Devo ammettere che l'uomo che ha ucciso il Presidente Kennedy, Lee Oswald, non so esattamente cosa pensasse di fare, ma devo ammettere onestamente che anche io vedo qualcosa di me stesso in lui” finì subissato dai fischi.
La posizione di allergia alle cerimonie fu poi ribadita con veemenza nella canzone “Day of the Locusts” del 1970, nella quale si faceva riferimento alla Laurea ad honorem ricevuta a Princeton: “I banchi erano stinti / per le lacrime e per il sudore / gli uccellini volavano / di albero in albero / non c'era molto da dire / non c'era conversazione / mentre io salivo sul palco / per ricevere la mia laurea / e le locuste cantavano / l'oscurità era dappertutto / si sentiva odore di tomba / dismisi la toga / presi la laurea / e la mia ragazza / ed insieme guidammo / dritto verso le colline nere del Dakota / mentre io ero ben felice / di esserne uscito vivo / e le locuste cantavano / dandomi un brivido”.
Dati questi precedenti noti a tutti, non sarà che allora la spocchia non è in Dylan, ma in chi pensa di piegarlo alla volontà dell'Accademia?
Se lo sai non lo premi, ma se non lo sai perché lo premi?
La prima volta di un cantautore al Nobel, dicevamo, ma Dylan è propriamente un cantautore? Per noi senza dubbio sì, ma è come tale che lui si percepisce?
Il concetto che sta dietro il lemma “cantautore” non è del tutto esportabile: con delle non insignificanti differenze lo potremmo attribuire, oltre che agli italiani, agli spagnoli e ai portoghesi, in modo meno preciso ai latinoamericani, ai francofoni (che sono però più originari), ai cantori dell'Est Europa, con la significativa evidenza dei bardi russi, che senza imbarazzi si attribuivano la definizione di “poeti cantanti” e le cui raccolte di versi, nelle librerie russe, si trovano sullo stesso scaffale di quelli di Puskin ed Esenin. Il pubblico per un cantautore europeo è una cosa che si imparenta con il teatro di avanguardia, con le serate di poesia, col cabaret tedesco, nella versione proletaria col night e i jazz club e che poi, solo negli anni settanta, assume il ruolo di happening musical-religioso-politico.
Il mondo anglosassone, con la significativa eccezione del Canada francofono (proprio Leonard Cohen è un maiuscolo esempio di cantante di lingua inglese, ma di cultura francofona-europea), vive tutt'altri e contrapposti miti.
Negli Stati Uniti Dylan appartiene ancora a una generazione di passaggio che affonda le sue radici nella musica popolare di strada, nei “dritti gerganti” che imboniscono alle fiere: non puoi aspettarti da loro il rispetto per il pubblico, perché l'unica ragione di essere bravi non è aderire a un concetto estetico letterario, ma far piovere le monetine nel bicchiere. Dylan ha qualcosa del predicatore quacchero che arringa in mezzo al paesino, del filosofo hippie, del bluesman che canta la salvazione in chiesa la domenica mattina e poi va a suonare la chitarra nel bordello, molti mondi popolari sono i potentissimi indimenticati modelli della sua cultura. Non è con una medaglia che avresti potuto redimere il bluesman Leadbelly dalla sua condanna per omicidio, c'è alla base di quelle vite (e nella memoria viva dei loro seguaci) un'esperienza durissima, inconciliabile.
Certo il comportamento di Dylan non è mai stato molto urbano, e soprattutto in questo caso non s'è smentito: se Dylan sa da molto tempo di non essere l'eroe della classe lavoratrice Woody Guthrie, non è mai voluto diventare nemmeno un saltimbanco vitaminico come Springsteen, che ha trasformato il concerto rock in un esercizio muscolare e adora il pubblico che lo ricambia. Dylan sta in mezzo irresoluto, più cieco di Omero brancola genialmente sapendo benissimo dove va ma non sapendo perché, senza pace in una tournée infinita. Dylan disprezza il suo pubblico e la sua condanna a suonare eternamente, lo fa come se fosse inseguito dalla miseria, come se ignorasse di essere miliardario. È questo il suo genio, la sua condanna e il suo pessimo carattere.
Dylan si sente imparentato in pari grado con Elvis, con Guthrie, con Rimbaud, con Charley Patton e con... Abramo Lincoln. Non vive la cuginanza/dipendenza dalla Letteratura Accademica né il contrapposto senso di superiorità e meschino rancore economico rispetto al Pop. Invitarlo in Svezia vuol dire invitare tanto un erede di Withman quanto uno di Jerry Lee Lewis - il rocker degli anni cinquanta soprannominato “il Killer” che incendiava i pianoforti per far dispetto a chi suonava dopo di lui.
Dare il Nobel a Dylan è come invitare un madonnaro (col talento di Michelangelo) nel salotto buono della nobiltà letteraria pensando che non sia costitutivamente estraneo e alieno da quel mondo. Lui probabilmente dipingerà la sua peggiore schifezza (perché non lì gli serve dimostrare che è bravo: la bravura in un artista di strada serve solo sulla strada per ricevere più spiccioli di mancia) e in più ruberà l'argenteria e vi lascerà una cacata sul tappeto buono.
Dylan non è Sartre, non boicotta né approva, Dylan è Jokerman: il baro, il ladro, il mercante. Non ha posizioni etiche, lui serve la bellezza e in più è notoriamente uno stronzo (“troppo stronzo per essere corruttibile” disse più o meno Patty Smith, che infatti è andata in Svezia in sua rappresentanza).
Quindi il fatto che non si sia presentato era il massimo della cortesia che gli si potesse chiedere.
Alessio Lega
| Ricordando
Riccardo Schwamenthal. Vi dobbiamo purtroppo comunicare
che il nostro amico Riccardo Schwamenthal è morto
il 4 novembre scorso. È un'altra, l'ennesima, perdita
incalcolabile nel campo della musica popolare e del jazz
(le sue due grandi passioni), a maggior ragione perché
Riccardo di questi mondi era l'occhio della memoria, lo
splendido fotografo. Spesso, praticamente tutte le volte
che abbiamo parlato di questi argomenti, avevamo saccheggiato
il suo archivio, anche recentissimamente, e lui sempre
di buon grado ce lo ha concesso, per passione, per militanza,
per memoria.
a.l. |
|

