|
Nota dell’autore
Scopo di
questa bibliografia è fornire un panorama della produzione
editoriale che negli ultimi anni ha interessato il mondo dell’anarchismo.
Si è considerata sia la bibliografia specifica o prodotta
da case editrici anarchiche, sia quella attinente alle tematiche
generali dell’anarchismo. La selezione proposta non intende
ovviamente essere esaustiva.
La scelta è stata quella di segnalare, oltre ai testi
di carattere storico, quelli basati su materiale documentario
non circoscritto, né settoriale o troppo militante. Di
conseguenza sono rimasti fuori i pamphlets propagandistici,
le autoproduzioni a scarsa circolazione e di difficile reperibilità,
i lavori facenti riferimento ad ambiti di intervento escludenti
e non includenti. Tale criterio può, forse, apparire
un limite “ideologico”, ma corrisponde soprattutto
alla coerenza di una scelta metodologica finalizzata a mettere
in relazione l’anarchismo con il maggior numero possibile
di potenziali lettori.
Quanto ai limiti cronologici, si è preferito attenersi
a criteri non troppo rigidi. La maggior parte dei testi citati
si riferisce all’arco degli anni compresi fra il 1995
e il 2005. Questo non solo per l’attualità dei
testi, ma anche per la loro sostanziale reperibilità.
Si sono inseriti alcuni titoli pubblicati prima del 1995, quando
ritenuti particolarmente importanti e quando dedicati ad argomenti
non altrimenti presenti.
Qualcosa sicuramente è sfuggito, qualcosa, forse, non
è descritto nel modo più appropriato. Si spera
comunque che questa traccia bibliografica possa rivelarsi un
prezioso strumento di lavoro e un utile contributo alla conoscenza
dell’anarchismo, della sua storia, delle sue storie, del
suo pensiero.
Che è quanto ci si era proposti.
Massimo
Ortalli
massimo.ortalli@acantho.it
 Primo
Primo
approccio
Per un primo approccio con la storia del movimento anarchico,
converrà partire dai due volumi di Pier Carlo Masini,
Storia degli anarchici italiani da Bakunin a Malatesta
e Storia degli anarchici italiani nell’epoca
degli attentati (Milano, Rizzoli, 1969 e 1981,
poi più volte ristampati, anche recentemente, dalla stessa
casa editrice), che segnano il coronamento di studi rigorosamente
impostati sul piano scientifico e condotti inoltre con passione
e adesione ideale. I due testi rappresentano, infatti, la prima
tappa di un processo storiografico che ha avuto “l’ardire”
di emanciparsi dagli schemi interpretativi della scuola marxista
e dai relativi inappellabili giudizi, che hanno segnato tradizionalmente
lo studio dei movimenti sociali dell’Italia unitaria.
 Pier Carlo Masini
Pier Carlo Masini
A questi andrà affiancata la più
recente opera di Renato Zangheri, Storia del socialismo
italiano. I volume:
Dalla Rivoluzione francese ad Andrea Costa;
II volume: Dalle
prime lotte nella Valle padana ai Fasci siciliani
(Torino, Einaudi, 1993 e 1997), con la quale l’autore,
rivalutando il ruolo e l’importanza delle correnti libertarie
nel secondo Ottocento, ha fatto giustizia di un’impostazione
storiografica partigiana che aveva sempre sottovalutato, se
non mistificato, il contributo degli anarchici alla nascita
del socialismo italiano.
Nel loro insieme, i tre studi ricostruiscono un quadro pressoché
completo delle origini e del periodo “eroico” dell’anarchismo
di lingua italiana. A margine di questi capisaldi, non per attinenza
scientifica ma per completezza d’informazione, è
possibile segnalare un’altra storia dell’anarchia
di Alessandro Aruffo, Breve storia degli anarchici
italiani. 1870-1970 (Roma, Datanews, 2005). Che
sia breve non c’è il minimo dubbio, visto il numero
delle pagine in relazione alla mole degli avvenimenti presi
in considerazione; che sia anche storia, i dubbi non sono pochi,
considerando i numerosi e spettacolari strafalcioni in cui incorre.
Va invece salutata con soddisfazione la traduzione italiana
dei quattro monumentali tomi di James Guillaume, L’Internazionale.
Documenti e ricordi 1864-1878, finalmente pubblicati,
dopo un’attesa più che centenaria, per le edizioni
Csl Di Sciullo (Chieti, 2004). Si tratta di una raccolta di
documenti di prima mano, dalle risoluzioni assembleari ai verbali
dei congressi, dai volantini di propaganda ai testi di divulgazione,
che consente di avvicinare il modo di pensare, di esprimersi
e di comunicare dei primi nuclei anarchici e internazionalisti
nel lontano Ottocento.
Passando dalla teoria all’azione, va segnalato il testo
Movimenti sociali e lotte politiche. Il moto anarchico
del Matese, a cura di Luigi Parente (Milano, Angeli,
2001), che raccoglie gli atti del convegno di studi sul moto
rivoluzionario del Matese, tenutosi a San Lupo nel 1998. Il
volume ripercorre la storia del primo tentativo insurrezionale,
generoso e sfortunato, che agitò il neonato stato italiano
e che ebbe protagonisti Errico Malatesta, Carlo Cafiero e uno
stuolo di entusiasti “banditi” romagnoli e marchigiani.
Restando ai tempi della Prima Internazionale, un’altra
raccolta, a cura di Giampietro Berti, Socialismo,
anarchismo e sindacalismo rivoluzionario in Veneto tra Otto
e Novecento (Padova, Poligrifo, 2004) raccoglie
le quindici relazioni presentate al convegno omonimo tenutosi,
non a caso, a Monselice, sede di uno dei primi e più
attivi gruppi internazionalisti italiani.
Sempre di quegli anni, il finire del secolo, scrive Valerio
Bartoloni in I fatti delle Tremiti. Una rivolta
di coatti anarchici nell’Italia umbertina
(Foggia, Bastogi, 1996), ricostruendo le drammatiche fasi dell’uccisione
dell’anarchico Argante Salucci, avvenuta al domicilio
coatto, nel corso di una rivolta innescata dalle disumane condizioni
di detenzione.
Restando nell’ambito della storia generale dell’anarchismo,
e proseguendo per tappe cronologiche, dopo il citato contributo
di Masini, che si ferma ai primi del Novecento, va ricordato
l’interessante Il sol dell’avvenire.
L’anarchismo in Italia dalle origini alla Prima guerra
mondiale, scritto a quattro mani da Pier Carlo
Masini e Maurizio Antonioli (Pisa, Bfs, 1999), contenente un
saggio sulla Prima Internazionale e altri studi sull’anarchismo
individualista e organizzatore prebellico.
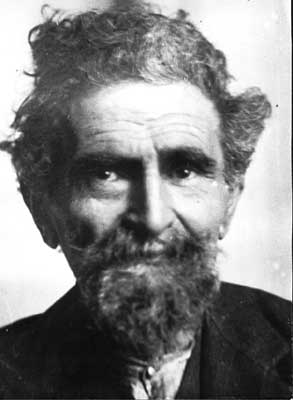
Errico
Malatesta nel carcere milanese di San Vittore (1921)
Un altro studio complessivo è il monumentale
Errico Malatesta e il movimento anarchico italiano
e internazionale di
Giampietro Berti (Milano, Angeli, 2003), frutto di una ricerca
di anni, che ha il pregio di ricostruire non solo la biografia
di uno dei personaggi più importanti dell’anarchismo
internazionale, ma anche la storia di quel fervido e fecondo
movimento che vide Malatesta fra i suoi protagonisti per più
di sessant’anni.
Se quella di Berti è una monografia che potremmo considerare
definitiva su Malatesta e la sua azione rivoluzionaria, desidero
segnalare inoltre, per la prosa accattivante, il vecchio lavoro
di Armando Borghi, Errico Malatesta in 60 anni di
lotte anarchiche, ristampato da Samizdat (Pescara)
nel 1999: un ritratto intenso del periodo “eroico”
dell’anarchismo italiano, vissuto in prima persona.
Guerra di Classe e Lotta Umana. L’anarchismo
in Italia dal Biennio rosso alla guerra di Spagna (1919-1939)
di Gigi Di Lembo (Pisa, Bfs, 2001) rappresenta il primo e più
approfondito studio sulle traversie, raramente interrotte da
qualche momento esaltante, vissute dagli anarchici italiani
dal primo dopoguerra fino alla definitiva vittoria di Francisco
Franco. È la storia del fuoriuscitismo, di anni drammatici
e duri, rischiarati dalla luce della Rivoluzione Spagnola, ma
fatti soprattutto di privazioni, delusioni, dolorose rotture
e difficili ricomposizioni.
Curiosamente, dopo un lungo silenzio storiografico su questo
periodo, è uscito, a poca distanza, un altro lavoro,
Il movimento anarchico italiano nella lotta contro
il fascismo 1927-1945, di Fabrizio Giulietti (Manduria,
Lacaita, 2004) che riprende in considerazione, sostanzialmente,
le stesse tematiche e gli stessi avvenimenti trattati da Di
Lembo, arrivando però alla fine della Seconda guerra
mondiale. Con un apparato documentario arricchito da un’interessante
appendice, il testo contribuisce a descrivere compiutamente
la fase presa in esame.
A complemento di questi, l’opuscolo di Giorgio Sacchetti
pubblicato dalla livornese Sempre Avanti nel 1995, Gli
anarchici contro il fascismo, tratta di alcuni
degli aspetti specifici con i quali si misurò l’antifascismo
libertario, ad esempio il campo di concentramento di Renicci
d’Anghiari o la collaborazione con il movimento di Giustizia
e Libertà.

Confinati
anarchici nell’isola di Lipari (1927)
Ma perché non si pensi che il movimento
anarchico sia rimasto immune, soprattutto nell’ambiente
individualista, dal fascino della sirena fascista, conviene
confrontarsi con l’interessante lavoro di Alessandro Luparini,
Anarchici di Mussolini. Dalla sinistra al fascismo
tra rivoluzione e revisionismo (Firenze, M.i.r.,
2001) che ripercorre le biografie degli anarchici che, passando
per l’interventismo, scelsero di schierarsi con le camicie
nere. Ma nella sostanza il rapporto dei compagni di allora con
la dittatura fascista fu di ben altro tenore, e lo dimostra
l’abbondante letteratura, anche recente, sui reiterati
tentativi di attentare alla vita di Mussolini per liberare l’Italia
dalla sua soffocante dittatura. Ricordiamo il testo di Riccardo
Lucetti, Gino Lucetti. L’attentato contro
il Duce. 11 settembre 1926 (Carrara, Cooperativa
Tipolitografica, 2000); poi Attentato al Duce
(Bologna, Il Mulino, 2000), con il quale Brunella Dalla Casa
ricostruisce le complesse e intricate vicende del “presunto”
attentato bolognese di Anteo Zamboni; la ristampa del libro
di Giuseppe Fiori, Vita e morte di Michele Schirru.
L’anarchico che pensò di uccidere Mussolini
(Bari, Laterza, 1990); quindi Il dito dell’anarchico.
Storia dell’uomo che sognò di uccidere Mussolini
di Lorenzo del Boca (Casale Monferrato, Piemme 2000), sulla
figura di Lucetti; e infine il monumentale e documentatissimo
Angelo Sbardellotto, scritto e pubblicato
da Giuseppe Galzerano (Casalvelino, 2003), che ricostruisce
la tragica vicenda dell’anarchico di Mel fucilato per
aver tentato di uccidere il dittatore di Predappio.
Sulla prima opposizione anarchica al fascismo, segnalo: di Eros
Francescangeli, Arditi del Popolo. Argo Secondari
(1917-1922) (Roma, Odradek, 2000), di Luigi Balsamini,
Gli arditi del Popolo (Casalvelino,
Galzerano, 2002) e di Marco Rossi, Dall’arditismo
di guerra agli arditi del popolo (Pisa, Bfs, 1997),
tre lavori che hanno portato nuovi e interessanti elementi di
conoscenza sull’arditismo popolare e sui suoi protagonisti,
rompendo il sostanziale silenzio della storiografia ufficiale
su questo movimento di resistenza armata contro le squadracce
agli albori del fascismo, praticato dagli elementi più
combattivi del proletariato, entusiasticamente appoggiato dagli
anarchici, ma che incontrò anche l’ostilità
dei dirigenti dei partiti “dell’estrema”.
Ancora sull’arditismo popolare, il lavoro di Pino Cacucci,
a metà strada fra narrazione e contributo storico, che
rievoca felicemente in Oltretorrente
(Milano, Feltrinelli, 2003) le atmosfere proletarie dell’esaltante
lotta dei borghi parmigiani contro gli squadristi di Italo Balbo.
E, sempre su Parma, scritto con l’amore che le portava,
Parma libertaria, di Gianni Furlotti,
l’affresco di una bellissima città popolana affollata
di uomini liberi, volume del quale l’autore non ha potuto
purtroppo vedere le stampe, ma che la Bfs di Pisa ha ostinatamente
voluto pubblicare nel 2001 come ultimo omaggio.
Sulla resistenza opposta dagli anarchici all’azione delle
squadracce, c’è anche l’avvincente L’imboscata.
Foiano della Chiana, 1921: un episodio di guerriglia sociale
(Comune di Foiano, 2000), nel quale Giorgio Sacchetti ricostruisce,
come fosse un romanzo, un’azione di opposizione al fascismo
condotta da un intero paese toscano e coordinata dal locale
gruppo anarchico.
Passando alla Resistenza e alla guerra di liberazione, per un
quadro completo del ruolo degli anarchici nella lotta contro
il nazifascismo, sarebbe sufficiente la riedizione de La
Resistenza sconosciuta. Gli anarchici e la lotta contro il fascismo
(Milano, Zero in condotta, 2005) che raccoglie i saggi di diversi
autori (G. Manfredonia, I. Rossi, M. Rossi, G. Sacchetti, F.
Schirone e C. Venza) sulle vicende “militari” e
politiche che videro impegnati i partigiani libertari, con allegato
un cd contenente fotografie, riproduzioni di documenti della
lotta clandestina, immagini delle lapidi dedicate ai compagni
caduti nella lotta, e alcune canzoni tratte dal repertorio dell’antifascismo
anarchico.
Come esempio di storia locale, va citato il lavoro di Anna Marsilii,
Il movimento anarchico a Genova (1943-1950)
(Genova, Annexia, 2004) che, grazie a un’accurata ricerca
d’archivio e riprendendo gli studi di Guido Barroero,
riporta alla luce le ricche ma sostanzialmente inedite vicende
del forte movimento comunista-anarchico genovese negli anni
cruciali della Resistenza e della ricostruzione.
Per venire ad anni più recenti, le editrici di area anarchica
sono impegnate a promuovere lavori sulla storia (fino a poco
fa in gran parte inedita) del movimento anarchico nel secondo
dopoguerra.
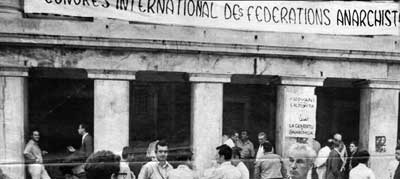
Carrara,
agosto 1968 – Congresso internazionale anarchico
Ecco così la nuova edizione del testo
Il ruolo dell’organizzazione anarchica di
Gino Cerrito (Pescara, Samizdat, 1998), già
uscito nel 1973, che affronta i problemi organizzativi con i
quali si è misurato l’anarchismo italiano, dal
piattaformismo all’esperimento neomarxista dei Gaap, fino
alle complesse stesure dei vari Patti associativi della Fai;
la preziosa integrazione delle fonti operata da Giorgio Sacchetti
sul vecchio lavoro di Ugo Fedeli, Congressi e convegni
della Fai. 1944-1995 (sempre per i tipi di Samizdat,
2002), nel quale sono raccolte le mozioni congressuali più
importanti approvate dalla Federazione Anarchica Italiana negli
ultimi decenni; e infine il recentissimo Anni senza
tregua. La Fai dal 1970 al 1980 (Milano, Zero
in condotta, 2005), col quale due protagonisti palermitani di
quella stagione di lotte, Antonio Cardella e Ludovico Fenech,
scrivono un primo capitolo di quella “storia della Fai”
di cui in molti, ci si perdoni lo spirito di parte, avvertiamo
la mancanza. E, data l’attenzione con la quale è
affrontato il periodo della “rinascita” della Fai
e l’interesse che questa lettura può avere non
solo per i militanti, c’è da augurarsi che questi
volumi segnino l’inizio di una nuova stagione di ricerche.
Visto poi che stiamo parlando degli anni della “contestazione”,
segnalo, soprattutto ai lettori più giovani e curiosi,
due godibilissime opere di Diego Giachetti, Oltre
il sessantotto. Prima, durante e dopo il movimento
e Anni sessanta comincia la danza. Giovani, capelloni,
studenti ed estremisti negli anni della contestazione
(Pisa, Bfs, 1998 e 2002), entrambe capaci di spiegare, anche
emotivamente (soprattutto per chi li ha vissuti) come e quanto
fossero “formidabili” quegli anni, non solo sul
piano politico, ma anche e soprattutto su quello esistenziale
e culturale.
 Piazza
Fontana
Piazza
Fontana
e dintorni
Anni formidabili, incrinati irrimediabilmente, però,
dalla stagione delle stragi, prima fra tutte quella di Piazza
Fontana nel 1969.
Sono più di trenta i titoli usciti da allora sulla Strage
di Stato, sull’assassinio di Pinelli e sulla detenzione
di Valpreda, ma nonostante questa documentazione, una soluzione
giudiziaria non la si è voluta trovare. (Come meravigliarsi,
del resto?!).
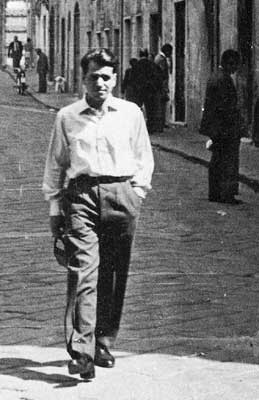 Giuseppe Pinelli
Giuseppe Pinelli
Rimando comunque al testo di Luciano Lanza, fondamentale soprattutto
per la chiarezza, Bombe e segreti
(Milano, Elèuthera, 1997), di cui renderei obbligatoria
la lettura nelle scuole; alla apprezzata ristampa del Pinelli.
Una finestra sulla strage (Milano, Saggiatore,
2004), con il quale Camilla Cederna scese, usando tutto il suo
carisma, la sua intelligenza e la sua sensibilità, al
fianco nostro, di Pinelli e della verità; a La
strage, Piazza Fontana, di Maurizio Dianese e
Gianfranco Bettin (Milano, Feltrinelli, 1999); e infine al recente
La strage con i capelli bianchi,
titolo quanto mai significativo del libro di Paolo Barbieri
e Paolo Cucchiarelli (Roma, Editori Riuniti, 2003).
Anche se muovendo da prospettive diverse, si coglie in tutti
l’indignazione purtroppo impotente nei confronti dell’impenetrabile
muro di gomma contro il quale le istituzioni hanno fatto rimbalzare
le proprie colpe, insieme alla mole di materiale raccolto sulle
responsabilità dei fascisti e degli apparati dello Stato.
Fino alla recente sentenza della Cassazione, vergognosa, indegna
e infame, che ha messo una definitiva pietra tombale su tutta
la faccenda.

Il
giorno di Serantini – La punizione (1973-1974). Disegno
di Orio Melani
Restando a quegli anni e a quel clima, rimando al bel libro-denuncia
di Fabio Cuzzola Cinque anarchici del Sud
(Cosenza, Città del Sole, 2001) sulla “misteriosa”
e tragica morte di cinque compagni calabresi che nei primi anni
Settanta stavano indagando sulle responsabilità fasciste
nella strage di Piazza Fontana; e al bellissimo, duro e struggente
Il sovversivo (Pisa, Bfs, 2002),
ristampa del capolavoro di Corrado Stajano che ricostruisce
la storia di Franco Serantini, il giovane figlio di nessuno,
massacrato di botte dalla polizia e lasciato morire come un
cane nel carcere Don Bosco di Pisa nel maggio del 1972. (Uno
dei libri più belli che abbia mai letto!).
Per restare nel campo delle misure repressive messe in atto
dal potere per reprimere le lotte più radicali di alcuni
settori dell’anarchismo di oggi, è interessante
la ricostruzione fatta da Tobia Imperato, Le scarpe
dei suicidi. Sole Silvano Baleno e gli altri (Torino,
Fenix, 2003), sul drammatico caso di Soledad Rosas ed Edoardo
Massari, impegnati nella lotta contro l’Alta Velocità
e morti suicidi nelle carceri torinesi dove erano stati ingiustamente
ristretti.
Altrettanto “duro” è Achtung
Banditen! Marco Camenisch e l’ecologismo radicale,
a cura di Piero Tognoli (edizioni NN, 2004), dove si riporta
una lunga intervista all’anarchico svizzero, da lunghi
anni prigioniero, dapprima in Italia poi nel suo paese, dove
“paga” la sua estrema tensione ecologista. Per saperne
di più c’è anche Rassegnazione
e complicità. Il caso Marco Camenisch (senza
autore, Salorino, L’Affranchi, 1992).
Venendo ai nostri giorni, fa impressione la lettura del libro
scritto a più mani, Organismi genovesamente
modificati. Piccolo dizionario degli orrori (Milano,
Zero in condotta, 2002), un’ampia documentazione, anche
fotografica, della durissima repressione messa in atto da polizia
e carabinieri in occasione della riunione del G8 nella città
della Lanterna, nel luglio 2001.
Già che siamo in argomento, per una lettura diversa del
cosiddetto movimento no global, segnalo l’interessante
lavoro di Vittorio Giacopini, No global. Tra rivolta
e retorica (Milano, Elèuthera, 2002), una
delle poche voci critiche di sinistra sulle contraddizioni e
i meriti di questo movimento.
 Vite
Vite
di anarchici
Tornando ai temi più propriamente storici, e in particolare
a quelli sugli anni più lontani, i titoli interessanti
usciti in questi ultimi tempi sono tanti, a testimonianza del
rinnovato interesse per la ricerca non solo da parte di studiosi
di area anarchica, ma anche di storici di altre scuole.
Numerose sono, infatti, le biografie e i saggi su momenti specifici
e locali dell’anarchismo.
Va segnalata in primo luogo un’opera complessiva, forse
la più importante mai uscita sul movimento anarchico
di lingua italiana.
Intendo parlare dei due volumi del Dizionario Biografico
degli Anarchici Italiani, opera diretta da Maurizio
Antonioli, Giampietro Berti, Santi Fedele e Pasquale Juso, curata
e stampata dai compagni della Bfs di Pisa. Usciti nel 2003 e
2004 i due volumi contengono oltre duemila biografie redatte
da circa un centinaio di collaboratori sparsi per l’Italia.
Inutile sottolineare – del resto se ne è ampiamente
parlato in numeri precedenti della rivista – l’importanza
di questa opera, la sola che sia riuscita a ricostruire e raccogliere
le biografie di tutti gli esponenti più significativi
di uno dei movimenti della storia sociale del nostro paese.
Accostando il Dizionario ai due volumi sulla stampa periodica
curati in anni lontani da Leonardo Bettini, diventa ora possibile
conoscere “le opere e i giorni” della lunga e ininterrotta
esperienza dell’anarchismo di lingua italiana, anche nei
suoi aspetti più particolari e settoriali.
Di ben altro spessore è il classico Gli Anarchici
di Cesare Lombroso, lo studio con il quale il criminologo ottocentesco
avrebbe voluto ridurre la ricchezza di un intero movimento a
soggetto di uno studio di psicopatologia criminale. Non vedremmo
certo l’opportunità di questa riedizione (Milano,
Claudio Gallone, 1998), se non fosse per l’introduzione
di Francesco Novelli e la testimonianza di Pietro Valpreda.
Entrando nel merito di lavori più settoriali, riguardanti
momenti particolari, entità geografiche o biografie di
personaggi a vario titolo protagonisti della stagione classica
dell’anarchismo, conviene partire da un’opera tanto
importante quanto poco conosciuta in Italia, il bel Addio
Lugano bella. Gli esuli politici nella Svizzera italiana di
Maurizio Binaghi (Locarno, Dadò Editore,
2002), che già nel titolo della nostra più famosa
canzone riecheggia le vicende luganesi vissute dai numerosi
internazionalisti italiani esuli nell’ospitale Ticino.
Di personaggi del “mitico” internazionalismo scrive
anche Claudia Bassi Angelini che, nel suo Amore
e anarchia. Francesco Pezzi e Luisa Minguzzi, due ravennati
nella seconda metà dell’ottocento
(Ravenna, Longo, 2004), ricostruisce le vicende umane e politiche
di questi due romagnoli, coppia nella vita e nell’impegno
sociale intensamente profuso a Firenze al nascere delle prime
sezioni dell’Internazionale. Luigi Campolonghi, nel suo
Amilcare Cipriani. Memorie, antico
testo ristampato da Samizdat (Pescara) nel 2003, racconta la
vita avventurosa di questo che fu, senz’ombra di dubbio,
uno dei sovversivi più emblematici dell’Ottocento,
il riminese legionario, garibaldino, comunardo, internazionalista,
a lungo detenuto per fatti di sangue e di onore “rivoluzionario”.
Passando alle storie locali, daremo la precedenza a Carrara,
la “capitale” riconosciuta dell’anarchismo
di lingua italiana, sulle cui vicende libertarie non mancano
mai nuovi contributi.
 Alberto Meschi
Alberto Meschi
Ecco allora l’aggiornata edizione di una vecchia tesi
di laurea di Gian Maria Andrenucci, L’anarchia
a Carrara dall’Unità alla crisi di fine secolo
(Carrara, Società Editrice Apuana, 2005), poi la ristampa
di uno dei tanti lavori di Ugo Fedeli, Anarchismo
a Carrara e nei paesi del marmo (Pisa, Bfs, 1995),
e il lavoro di Massimiliano Giorgi su Alberto Meschi
e la Camera del Lavoro di Carrara (1911-1915)
con il quale la Cooperativa Tipolitografica di Carrara, nel
1998, ha reso omaggio alla limpida figura del sindacalista fidentino
Meschi, che nella città del marmo seppe dare impulso
e forti forme organizzative al vivacissimo movimento anarchico
locale.
Restando a Carrara, ma spostandoci al secondo dopoguerra, fa
piacere vedere la ristampa di un vecchio lavoro di Rosaria Bertolucci,
completamente dedicato alla figura di Ugo Mazzucchelli
(Carrara, Società Editrice Apuana, 2005), senza dubbio,
per la sua lunga e avventurosa esistenza, uno dei personaggi
centrali e più costruttivi del movimento libertario carrarese.
Sempre dalla Toscana, terra dove l’anarchismo non ha mai
mancato di far sentire la sua forte voce, popolare e rivoluzionaria,
provengono il recente lavoro di Giorgio Sacchetti, Presenze
anarchiche nell’aretino dal XIX al XX secolo
(Pescara, Samizdat, 1999), dove spicca la biografia del sindacalista
imolese Attilio Sassi, ancora oggi ricordato dai figli dei minatori
e degli antifascisti di Cavriglia, e l’originale opuscolo
di Alberto Prugnetti, Potassa. Storia di sovversivi
(Roma, Stampa Alternativa, 2003), sospeso fra la ricostruzione
storica e la narrazione romanzata di straordinarie esistenze
ribelli della ribelle Maremma.
Prima di abbandonare questa regione, segnalo il libro di Lelio
Lagorio, Ribelli e briganti nella Toscana del Novecento.
La rivolta dei fratelli Scarselli e la banda dello Zoppo in
Valdelsa e nel Volterrano (Firenze, Olschki, 2002),
la storia di una famiglia di anarchici portata, per la sua irriducibile
opposizione allo Stato e all’avanzante fascismo, a condurre
una battaglia tanto disperata quanto avventurosa.
Restando alla storiografia locale, va segnalato La
polveriera d’Italia. Le origini del socialismo anarchico
nel Regno di Napoli (1799-1877), di Giulio De
Martino e Vincenzo Simeoli (Napoli, Liguori 2001), dal quale
escono a tutto tondo le figure di Carlo Pisacane e Mikhail Bakunin,
assieme a quelle dei loro seguaci che dettero vita al primo
nucleo internazionalista italiano.
Mi piace poi segnalare il prezioso lavoro dei compagni abruzzesi
che curano le edizioni Samizdat di Pescara e Csl Di Sciullo
di Chieti.
Sono molti i testi dedicati all’Abruzzo, a dimostrazione
che nelle zone “periferiche” dell’anarchismo
non mancarono mai storie e personaggi talmente significativi
da meritare di essere portati alla considerazione storica. Sono
di Edoardo Puglielli Abruzzo rosso e nero
(Chieti, Csl Di Sciullo, 2003), alla riscoperta di importanti
figure di attivisti quali Carlo Tresca, Francesco Ippoliti e
Umberto Postiglione, e Luigi Meta. Vita e scritti
di un libertario abruzzese (Chieti, Csl Di Sciullo,
2004), la biografia, con prefazione di Gaetano Arfè,
di un militante a lungo vissuto in America dove conobbe, tra
gli altri, Salvemini, Cianca e Tarchiani,

Camillo
Di Sciullo
Di Fabio Palombo l’esemplare biografia di Camillo
Di Sciullo anarchico e tipografo di Chieti (Pescara,
Samizdat, 1996) continuamente alle prese con la strisciante
repressione umbertina, fra i sequestri delle sue pubblicazioni
e quelli della sua persona,
sempre e solo per reati d’opinione, ritenuti evidentemente
molto pericolosi.
Poi, di Francesca Piccioli, Virgilia D’Andrea,
storia di un’anarchica (Chieti, Csl Di Sciullo,
2002), la più accurata biografia di questa fervente poetessa
e propagandista dell’ideale, morta esule nella lontana
America, ancora in giovane età, dopo un’esistenza
segnata da grandi passioni e sofferenze; di Maria Lucia Calice,
Gli anarchici abruzzesi nel periodo giolittiano
(Pescara, Samizdat, 1999), e infine La presenza
anarchica nell’aquilano, di Silvio Cicolani
(Pescara, Samizdat, 1997).

Virgilia
D’Andrea
Passando alla Romagna, altra terra dalla forte impronta libertaria,
vanno segnalati due lavori di Alessandro Luparini, il primo
sul tentativo rivoluzionario di poco precedente lo scoppio della
Grande guerra, Settimana Rossa e dintorni
(Ravenna, Istituto Storico della Resistenza, 2004), il secondo,
a tratti perfino commovente nel ritrarre splendide e pressoché
sconosciute figure proletarie, Terra di libertà.
Anarchici in provincia di Ravenna (Ravenna, Montanari,
2005), volume ricco, tra l’altro, di un apparato iconografico
in gran parte inedito e molto interessante. Se parliamo della
Settimana rossa, dell’opposizione alla guerra di Libia
e della Romagna, arriviamo al lavoro di Laura Di Marco, Il
soldato che disse no alla guerra. Masetti (Santa
Maria Capua Vetere, Spartaco, 2003), la biografia del muratore
persicetano che per non partire per la Libia sparò al
colonnello mentre concionava i soldati, la cui detenzione e
le lunghe traversie giudiziarie furono da stimolo per i tentativi
insurrezionali nelle Marche e nelle Romagne.
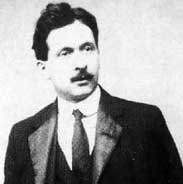 Armando Borghi
Armando Borghi
Restando in questa terra sanguigna, segnalo, anche
se uscito da tempo, Armando Borghi e l’Usi
di Maurizio Antonioli (Manduria, Lacaita, 1990), in cui lo studioso
affronta uno dei momenti cruciali dell’esperienza sindacalista
anarchica del primo Novecento, vista attraverso l’instancabile
opera organizzatrice del suo primo segretario.
Continuando con le biografie, veniamo alle più importanti.
Tralasciando quella di Berti su Malatesta, già citata,
torniamo ad Antonioli, che nel suo Pietro Gori.
Il cavaliere errante dell’anarchia (Pisa,
Bfs, 1996) disegna un ritratto a tutto tondo (accompagnato da
un’antologia di testi goriani sul Primo Maggio) di quello
che forse è stato il più amato e venerato fra
i poeti dell’ideale, come testimonia del resto la bella
raccolta di poesie a lui dedicate, qui presentata per la prima
volta.
 Pietro Gori
Pietro Gori
Ricordo anche la ristampa del breve profilo biografico
di Pietro Gori scritto da Carlo Molaschi
(Pescara, Samizdat, 1999), amico e compagno di lotta dell’elbano.
Di Antonio Gamberi, un poeta meno noto ma interessante come
prototipo del proletario autodidatta, scrivono Franco Bertolucci
e Daniele Ronco nella lunga introduzione al suo Poesie
per un liberato mondo (Pisa, Bfs, 2004).
Ancora di Giampietro Berti, Francesco Saverio Merlino
(1856-1930) (Milano, Angeli, 1993), altro corposo
lavoro che ripercorre le tappe della vita e del pensiero di
uno dei più originali e interessanti esponenti dell’anarchismo
prima e del socialismo libertario poi, coetaneo e compagno di
lotta e di polemiche di Errico Malatesta.
Un’altra bella biografia è quella che Luce Fabbri,
a coronamento di una vita segnata dalla continuità con
l’esperienza paterna, ha scritto su Luigi
Fabbri storia di un uomo libero (Pisa, Bfs, 1996).
Non solo la vita travagliata di questo grande anarchico, continuatore
del pensiero di Malatesta, ma anche le vicende, condivise dall’autrice,
di una irripetibile generazione di militanti tenacemente impegnata
a combattere il fascismo e l’oppressione in nome della
libertà. Particolare è il ritratto che Fabrizio
Montanari traccia in Voci dal Plata. Vita e morte
di Torquato Gobbi (Reggio Emilia, Bertani, 1997),
ricostruendo le drammatiche vicissitudini di questo anarchico
emiliano, morto suicida nel 1936 a Montevideo dove condivideva
l’esilio con l’amico e compagno Luigi Fabbri.
È un’altra figura “minore” quella riportata
alla luce da Giuseppe Galzerano in Vincenzo Perrone.
Vita e lotte, esilio e morte dell’anarchico salernitano
volontario della libertà in Spagna (Casalvelino,
Galzerano, 1999), che la morte nella battaglia di Monte Pelato
rende emblematica della sorte collettiva di un’intera
generazione di militanti.
 Luigi Bertoni
Luigi Bertoni
Segnalo poi la biografia della nobile figura
di Luigi Bertoni. La coerenza di un anarchico
(Lugano, La Baronata, 1997), con la quale Gianpiero Bottinelli
percorre l’esemplare e ammirevole vita dell’anarchico
ticinese, fondatore e redattore, per oltre mezzo secolo, del
bilingue giornale ginevrino «Il Risveglio – Le Reveil».
Anche questa diventa la monografia di un movimento vivace e
ricco di iniziative antifasciste e antimilitariste quale fu
quello svizzero, di cui fu parte attiva anche un’altra
figura di cui Gianpiero Bottinelli traccia le linee biografiche
nel suo Giovanni Devincenti. Il sogno di un emigrante
(Lugano, La Baronata, 2001).
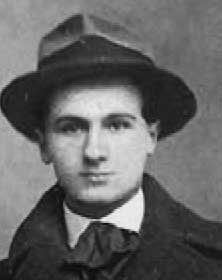 Camillo Berneri
Camillo Berneri
Va ricordato poi l’ultimo lavoro su Camillo
Berneri, di Carlo De Maria, Camillo Berneri tra
anarchismo e liberalismo (Milano, Angeli, 2004),
con il quale, in tempi di revisionismo storico imperante, mi
sembra si intenda perseguire lo “strano” disegno
di fare del rivoluzionario Berneri, ucciso anche e soprattutto
per la sua intransigenza rivoluzionaria dai sicari di Stalin
in Spagna, un eroe del pensiero liberale e un affossatore dell’anarchismo
“tradizionale”. (Ma così, a quanto pare,
dev’essere per queste nuove scuole storiografiche!).
Nessuna materia di revisionismo storico dovrebbe essere offerta
(ma non si può mai dire!) dalle figure di Giovanni
Passannante e di Gaetano Bresci,
alle quali si è dedicato Giuseppe Galzerano (Casalvelino,
Galzerano, 1997 e 2001). Due monumentali opere nelle quali l’autore
ha passato al setaccio tutto quello che è stato scritto,
all’epoca dei fatti, sui due attentatori all’augusto
re d’Italia Umberto I: il primo mancato, il secondo decisamente
meno. Mentre sul secondo è famoso (troppo) il lavoro
di Arrigo Petacco, L’anarchico che venne dall’America.
Gaetano Bresci (ultima ed. Milano, Oscar Mondadori,
2000), e meno noto il sorprendente saggio di Leone Tolstoj,
Per l’uccisione di Re Umberto
(Chieti, Csl Di Sciullo, 2003), su Passannante non si sa molto,
per cui è apprezzabile la curiosa pièce teatrale
di Ulderico Pesce, L’innaffiatore del cervello
di Passannante (Possidente, Pz, Pianetalibro 2003),
che ha contribuito a riaprire il caso dei resti cerebrali del
povero cuoco lucano, ancora barbaramente conservati sotto formalina
al museo criminale di Roma – come i lettori di “A”
hanno avuto modo di leggere – e dei quali ora si auspica
una “normale” sepoltura nel paese natale.

Il
regicidio di Gaetano Bresci in un dipinto di Flavio Costantini
Di un altro attentatore al re, anch’esso
mancato e quindi meno conosciuto, scrive Luigi Balsamini, Antonio
D’Alba. Storia di un mancato regicida (Chieti,
Di Sciullo, 2004), corredandone la biografia con le ricerche
sugli ambienti romani nei quali ebbe origine l’idea di
sparare al sovrano.
Restando nel campo dell’“azione diretta”,
che fra Ottocento e Novecento fu la risposta di non pochi anarchici
alle violenze del potere, è avvincente la lettura delle
Memorie di Jules Bonnot, ristampate
dall’Arkiviu Serra di Guasila nel 2001 e scritte, con
stile pittoresco, da Un Copain, pseudonimo del famoso giornalista
Paolo Valera. Sulle avventure di Bonnot e della sua famosa banda
di “rapinatori in automobile” (pare siano stati
i primi, agli inizi del Novecento, a usare la macchina nel loro
“lavoro”) ricordo il romanzo storico di Pino Cacucci,
In ogni caso nessun rimorso (rist.
Milano, Feltrinelli, 2003), sulle emozionanti vicende e i controversi
sentimenti di questi banditi tragici, votati alla morte.
Di altri banditi e ribelli irriducibili scrive Massimo Novelli
in Cavalieri del nulla. Renzo Novatore, poeta. Sante
Pollastro, bandito (Casalvelino, Galzerano, 1998),
tracciando le arroventate biografie del poeta ucciso in uno
scontro a fuoco con i carabinieri nel 1922 e del bandito che
scontò trent’anni nelle carceri francesi e italiane.
Restando ai primi del secolo, ma spostandoci a Milano, dove
particolarmente vivace fu la presenza degli anarchici individualisti
di formazione stirneriana, sono quattro i libri usciti recentemente
su quel periodo e quell’ambiente. Di Francesco Pellegrino,
per i tipi di Derive Approdi di Roma, è uscito nel 2004
Libertà estrema. Le ultime ore dell’anarchico
Bruno Filippi, il giovanissimo attentatore morto
nel 1920, vittima del suo stesso ordigno, mentre cercava di
farlo brillare in un lussuoso locale della Galleria di Milano.
C’è poi il famoso saggio di Vincenzo Mantovani,
Mazurka Blu (rist. Pescara, Samizdat,
2002), un lavoro frutto di lunghe ricerche, che ricostruisce
le disgraziate vicende del disgraziato attentato al Teatro Diana
nella Milano del 1921, e le tremende vicissitudini dei suoi
autori, in particolare di Mariani, Boldrini e Aguggini, che
pagarono la follia del loro gesto con la morte in carcere o
con lunghissime detenzioni.

Leda
Rafanelli
Ma, ricordandoci che non tutto l’anarchismo
milanese si muoveva su queste direttrici, conforta leggere l’originale
e a tratti commovente epistolario Lettere d’amore
e di amicizia. La corrispondenza di Leda Rafanelli, Carlo Molaschi
e Maria Rossi. Per una lettura dell’anarchismo milanese
(1913-1919) (Pisa, Bfs, 2002), nel quale Mattia
Granata ricostruisce la complessità e l’eterodossia
dei milieu culturali anarchici nella capitale morale
d’Italia. Restando a Leda Rafanelli, l’affascinante
“zingara” dell’anarchia, uno dei più
originali personaggi di quegli anni, il recente libro curato
da Alberto Ciampi, Leda Rafanelli – Carlo
Carrà. Un romanzo (Venezia, Centro Internazionale
Grafica, 2005), propone documenti originali e autografi conservati
presso l’Archivio Chessa-Berneri di Reggio Emilia, sul
fugace amore fra Leda e il giovane simpatizzante anarchico,
e grande pittore, Carlo Carrà.
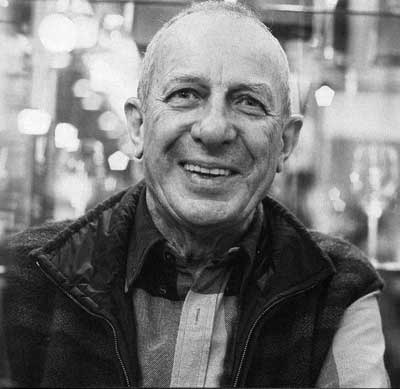
Luigi
Veronelli
Tornando in terra emiliana, segnalo alcune curiosità,
a dimostrazione che spesso la storia, anche la grande storia,
trova fondamento nell’insieme di cose più piccole,
di fatti e momenti segnati dalla più semplice quotidianità.
Sono usciti gli atti del recente convegno Le cucine
del popolo. Atti del convegno di Massenzatico
(Milano, Zero in condotta, 2005), con interventi di Fiamma Chessa,
Alberto Ciampi, Federico Ferretti, Gian Andrea Pautasso, Marco
Rossi, Giorgio Sacchetti e Luigi Veronelli, sulle modalità
e l’inventiva con le quali le culture proletarie, anche
e soprattutto in situazioni di lotta, riuscivano a soddisfare,
gustosamente, le necessità alimentari di tutti i giorni.
Altrettanto interessante il materiale uscito dalle giornate
di studio organizzate dal Csl Pinelli di Milano sulle infiltrazioni
e le provocazioni poliziesche nei confronti degli anarchici.
I contributi di Cesare Bermani, Giampietro Berti, Piero Brunello,
Mimmo Franzinelli, Aldo Giannuli, Lorenzo Pezzica, Claudio Venza,
raccolti in Voci di compagni. Schede di questura
(Milano, Csl, 2002), rappresentano una sorta di istruttivo manuale
sui sistemi di controllo dell’universo sovversivo che
ancora può insegnarci molte cose.
Di argomento simile, il saggio di Giorgio Sacchetti, Sovversivi
agli atti (Ragusa, La Fiaccola, 2002), che ricostruisce
la storia della schedatura politica, nella fattispecie quella
utilizzata fino ai giorni nostri nei confronti dei militanti
libertari. Un lavoro che illustra, anche con divertente ironia,
le pratiche demenziali e grottesche messe in atto dal potere
statale per “controllare”, in Italia come dovunque,
il movimento anarchico e gli altri movimenti sovversivi.
Terminiamo la parte storica con le biografie di tre personaggi
che hanno contribuito a mantenere vivo e vitale il movimento
anarchico in questo secondo dopoguerra. Tre militanti nati agli
albori del Novecento che hanno dato un forte senso alla loro
attività non solo durante la Rivoluzione spagnola e la
lotta al fascismo, ma anche, con uguale intensità, negli
anni della crisi del movimento che non si incancrenì
irrimediabilmente anche grazie al loro impegno e alla loro presenza.
Costantino Cavalleri ha scritto, con affetto quasi filiale,
il profilo del sardo Tomaso Serra, L’anarchico
di Barrali (Guasila, Arkiviu Serra, 1992), esule
antifascista, combattente in Spagna e nella Resistenza francese
e, nel dopoguerra, animatore della Comunità di Barrali,
nella sua Sardegna, un vero e proprio esempio di autogestione
realizzata.
Scheda
segnaletica di Alfonso Failla
Paolo Finzi ha ricostruito la vita di un Insuscettibile
di ravvedimento. L’anarchico Alfonso Failla (1906-1986)
(Ragusa, La Fiaccola, 1993), riportando nelle sue pagine non
solo le esperienze di lotta di un genuino ribelle, di un uomo
libero che pagò la voglia di libertà per sé
e per gli altri subendo incessantemente la repressione statale
(Failla è l’antifascista che ha passato il periodo
più lungo al confino), ma anche i tratti umani che abbiamo
potuto apprezzare quando abbiamo fatto nostre le sue idee.
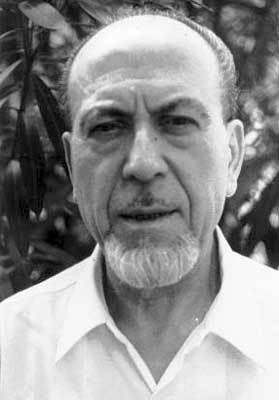
Umberto
Marzocchi
E, per finire, la recentissima monografia Senza
frontiere. Pensiero e azione dell’anarchico Umberto Marzocchi
(1900-1986) (Milano, Zero in condotta, 2005) il
libro con cui Giorgio Sacchetti, a lungo suo affezionato collaboratore
negli impegni internazionali, ricostruisce la vita eccezionale
di un militante “come tanti”, che fino alla fine
seppe trasmettere il suo prezioso, a volte determinante contributo,
per affrontare e superare le travagliate vicende del nostro
movimento.
Tre libri insostituibili per comprendere appieno non solo la
storia, ma anche e soprattutto l’anima dell’anarchismo
di lingua italiana.
 Fucina
Fucina
di idee
La bibliografia sul pensiero anarchico, ovvero sulla storia
delle idee, deve riferirsi in primo luogo ai primi pensatori,
i cosiddetti “classici”, coloro che dettero sostanza
e struttura al pensiero ribelle, antiautoritario e antistatale
che ha poi preso il nome di anarchismo.
Innanzitutto William Godwin, il grande pensatore radicale inglese,
da molti considerato il pioniere dell’anarchismo. Elèuthera
ha riproposto opportunamente, nel 1997, alcuni dei suoi testi
più sintomatici, raccolti sotto il titolo L’eutanasia
dello Stato, arricchiti da un interessante profilo
biografico.

Pierre-Joseph
Proudhon in un celebre quadro di Gustave Courbet
Di Pierre-Joseph Proudhon, colui che può essere ritenuto
l’antesignano, segnaliamo Che cos’è
la proprietà. Ricerche sul principio del diritto e del
governo (Milano, Zero in condotta, 2000), il famoso
lavoro con la famosa domanda, la cui semplice risposta, «la
proprietà è un furto», avrebbe determinato
e formato la coscienza egualitaria e solidaristica di tutti
i movimenti sociali della sinistra. Sempre del pensatore francese,
nel 2001 è uscito per Elèuthera, Critica
della proprietà e dello Stato,
una corposa raccolta di saggi curata da Giampietro Berti, che
dimostrano l’importanza che il pensatore di Besançon
avrebbe avuto per il pensiero socialista, nonostante le sue
non poche contraddizioni.
Passando a Mikhail Bakunin, è doveroso iniziare con il
famosissimo Stato e Anarchia (Milano,
Feltrinelli, 2000) se non altro perché, mi si passi la
notazione personale, fu il primo libro che, nei lontani anni
Sessanta, contribuì alla mia formazione libertaria. Sempre
di Bakunin, va segnalata una ricca miscellanea curata da Luca
Michelini, Là dove c’è lo stato
non c’è libertà (Verona, Demetra,
1996), che raccoglie testi da tutte le sue opere più
importanti, e Considerazioni filosofiche sul fantasma
divino, il mondo reale e l’uomo (Lugano,
La Baronata, 2000), un’altra selezione di brevi testi
e saggi, particolarmente utile per comprendere la personalità
e la ricchezza filosofica del rivoluzionario russo, e inoltre
Tre conferenze sull’anarchia,
pronunciate a Saint Imier nel 1871, introdotte da Anselm Jappe
e uscite per Il Manifesto nel 1996, non a caso nella collana
“I grandi discorsi”.
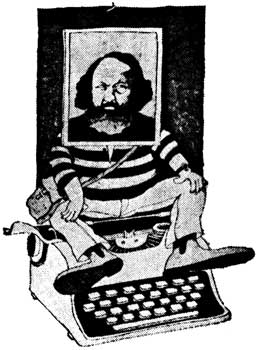
Mikhail
Bakunin visto da Xavier Poiret |
Infine, La libertà degli uguali,
a cura di Giampietro Berti (Milano, Elèuthera, 2000),
dove vengono riproposti e commentati numerosi saggi estratti
da alcune delle opere più importanti e significative
del pensatore russo, tra le quali Dio e lo Stato,
Catechismo del Rivoluzionario e Stato
e Anarchia. Di e su Bakunin segnalo l’edizione
finalmente disponibile del lavoro di Arthur Lehning, Bakunin
e gli altri. Ritratti contemporanei di un rivoluzionario
(Milano, Zero in condotta, 2002) che raccoglie lettere, testimonianze,
notizie biografiche e curiose tranche de vie del vecchio Michele,
raccontate dai grandi personaggi dell’Ottocento che incrociarono
la sua strada: per citarne alcuni, Herzen, Bielinskij, Turgenev,
Engels, Sand, Wagner, Marx, Reclus; mentre, su Bakunin, il suo
pensiero e la sua azione, va ricordato il libro di Roberto Giulianelli,
Bakunin e la rivoluzione anarchica
(Casalvelino, Galzerano, 1998).
A dimostrazione, infine, dell’interesse che il rivoluzionario
russo suscita ancora, e non solo fra i militanti, il ponderoso
L’etica (Torino, Ananke, 2003):
una raccolta di scritti prefati, commentati e chiosati con attenzione
e competenza da Carlo Genova.
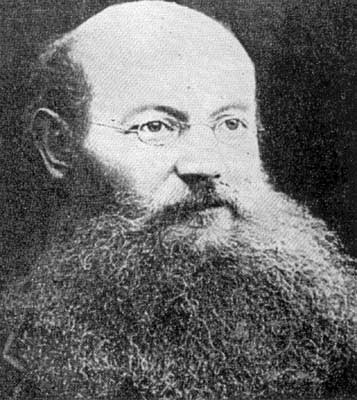
Piotr
Kropotkin
Dopo Bakunin, Piotr Kropotkin, il principe russo che, grazie
anche alla solida formazione scientifica, cercò di dare
sistematicità alle teorie anarchiche. Due i testi, relativamente
recenti, stampati in questi anni: il primo è il noto
Ai Giovani, una sorta di accorata
invettiva e incitamento morale, del quale la Fiaccola di Ragusa,
nel 1997, ha ristampato l’ennesima edizione italiana.
Sempre dello stesso anno, ma per i tipi di Stampa Alternativa
di Roma, è uscito un altro dei suoi piccoli capolavori,
Morale anarchica, un testo quanto
mai sedimentato fra i compagni anarchici, presso i quali non
ha mai mancato di far sentire i suoi effetti benefici. Dell’anno
successivo, per Elèuthera, Scienza e anarchia,
anche questa un’antologia curata da Giampietro Berti,
che evidenzia quanto il pensiero scientifico fortemente deterministico
del nostro ne influenzasse – a volte troppo, stando a
Malatesta – le teorie politiche e sociali.
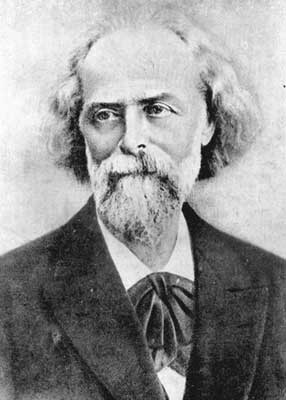
Elisée
Reclus
Per restare ai grandi, Natura e società.
Scritti di geografia sovversiva è l’unico
testo di Elisée Reclus uscito in questi anni (ma siamo
in attesa delle celebrazioni del centenario), e ne va dato atto
ad Elèuthera che, nel 1999, ha riproposto alcuni scritti
(tra i quali il bellissimo A mio fratello contadino)
del grande geografo, rivoluzionario e protagonista della Comune
parigina. Non di Stirner, ma su Stirner, La città
degli unici. Individualismo, nichilismo, anomia
(Torino, Giappichelli, 2001) di Enrico Ferri, apprezzato studioso
di questo eretico filosofo hegeliano, che analizza l’influenza
dell’individualismo stirneriano sull’anarchismo
del primo Novecento, anche in rapporto con i suoi critici e
con le altre correnti filosofiche individualiste.
L’elaborazione teorica non fu opera solo di pensatori
stranieri; anche in Italia fu notevole il contributo dato alla
sistematizzazione dell’anarchismo, nella ricerca del necessario
incontro fra teoria e pratica.
In questo senso è doveroso citare l’ennesima edizione
de Il compendio del Capitale di Carlo
Cafiero (Roma, Editori Riuniti, 1996), una sorta di bibbia volutamente
divulgativa, apprezzata per la semplicità espositiva
anche da Marx, e strumento indispensabile di approfondimento
teorico per intere generazioni di militanti dell’Otto
e Novecento.
Pietro Gori, il poeta dell’anarchia, di cui un tempo erano
assai diffusi opuscoli e raccolte, oggi non gode della stessa
fortuna editoriale. Se il suo anarchismo, intriso di idealismo
e poesia, può sembrare superato, resta pur sempre molto
efficace nella denuncia dei mali sociali e nella proposta di
soluzioni coerentemente libertarie, come si evince anche da
Addio Lugano Bella. Scritti scelti
(Milano, M&B Publishing, 1996).
Veniamo ora a Malatesta, certamente la figura più importante
per la vita e la storia dell’anarchismo italiano: come
dimostrano, del resto, le numerose edizioni dei suoi scritti
che continuano a vedere la luce. Andando in ordine cronologico,
partiamo dai classici Anarchia e Il
nostro Programma, ristampati da La Fiaccola di
Ragusa nel 1993 e da Datanews di Roma nel 1997. Si tratta, come
si sa, di due capisaldi del pensiero organizzativo anarchico,
soprattutto il secondo, tuttora a base dei principi della Federazione
Anarchica Italiana. Nel 1999, per i tipi di Elèuthera
e la cura di Giampietro Berti, è uscita l’antologia
Il buon senso della rivoluzione,
una raccolta commentata degli scritti degli ultimi anni, i più
maturi.
Segue la ristampa di L’autodifesa davanti
alle Assise di Milano e altri scritti (Roma, Datanews,
2002), vibrante arringa trasformatasi, come sovente accadeva,
in un possente atto d’accusa contro i guasti della società
borghese, pronunciata davanti ai giudici milanesi nel 1921,
periodo in cui Malatesta era detenuto con Borghi e Quaglino.
Piero Brunello e Pietro di Paola hanno curato Autobiografia
mai scritta. Ricordi (1853-1932) (Santa Maria
Capua Vetere, Spartaco, 2003), un’insieme di brani impostato
in maniera originale – vi figurano infatti solo quelli
caratterizzati da accenni autobiografici – che diventa
così quella sorta di autobiografia che Malatesta, nonostante
i solleciti, non scrisse mai. Segnaliamo inoltre ancora una
collazione, Bakunin e altri scritti
(Roma, Datanews, 2004) e, per le edizioni Le nubi, In
vista di un avvenire che potrebbe diventare realtà
(Roma, 2004) dove, come dice il titolo, la concretezza e la
solidità del pensiero malatestiano si evidenziano non
solo sul piano della critica all’autoritarismo e allo
statalismo, ma anche su quello delle proposte operative, capaci
di trasformare dalle radici le basi della società. Da
ricordare infine Individuo, società, anarchia:
la scelta del volontarismo etico (Roma, Edizioni
e/o, 1998), un’altra raccolta di scritti tutti centrati,
come ha voluto il curatore Giampietro Berti, su uno dei momenti
centrali della riflessione malatestiana.
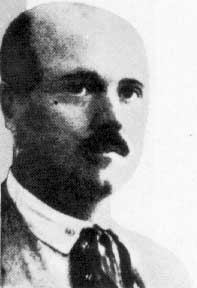 Luigi Fabbri
Luigi Fabbri
Se Malatesta fu il maestro, Luigi Fabbri fu l’allievo
che seppe onorare, con lucida coerenza, le lezioni del “padre”.
Opportunamente le edizioni Zero in condotta hanno riproposto
due suoi scritti, entrambi particolarmente interessanti e attuali
anche ai giorni nostri. Il primo è L’anarchismo,
la libertà, la rivoluzione (Milano, 1997),
il secondo è Le influenze borghesi sull’anarchismo.
Saggi sulla violenza (Milano, 1998), che raccoglie
per la prima volta i quattro articoli usciti nei primi anni
del Novecento su «Il Pensiero», nei quali Fabbri
attaccava con dura intransigenza i germi dell’individualismo
amoralista e borghese e di quel cosiddetto “ravacholismo”
che inquinava non pochi ambienti libertari, soprattutto milanesi,
allontanandoli dall’obiettivo della Rivoluzione sociale.
Per finire con i classici, Camillo Berneri, l’antifascista
più espulso d’Europa, “l’anarchico
sui generis”, l’uomo d’azione, il combattente
contro il fascismo in Italia e in Spagna, ma anche l’acuto,
sorprendente ed eterodosso intellettuale. Qui ricordo la raccolta
Umanesimo e anarchismo (Roma, Edizioni
e/o, 1996) e un’altra interessante antologia, utile per
comprendere il non conformismo che Berneri sapeva mettere in
tutte le sue riflessioni, Anarchia e società
aperta, a cura di Pietro Adamo (Milano, M&B
Publishing, 2001).
 Antologie e
Antologie e
studi complessivi
Venendo alle antologie e agli studi dedicati a vari autori,
segnalo la scorrevole e utile miscellanea Aforismi
dell’anarchia (Verona, Demetra, 2002), suddivisa
per argomenti da Emanuele Del Medico e Andrea Dilemmi, che raccoglie
brevi frasi, brani e citazioni dei più noti pensatori
per una lettura immediata e fruibile.
Di tutt’altro spessore i due volumi di Giampietro Berti,
Un’idea esagerata di libertà. Introduzione
al pensiero anarchico (Milano, Elèuthera,
1994) e Il pensiero anarchico dal Settecento al
Novecento (Manduria, Lacaita, 1998). Si tratta,
in questo caso, di lavori di approfondimento e di analisi sulle
idee, le riflessioni filosofiche e le proposte operative elaborate
in quasi due secoli dai maggiori pensatori dell’anarchismo,
dai precursori fino agli epigoni. Comunque, per lo stile piacevole
e per il grande interesse degli argomenti, libri destinati non
solo agli specialisti.
Di lettura più agevole, ma altrettanto formativa, l’ottimo
lavoro di Angel J. Cappelletti, L’Idea anarchica.
Dalle origini ai giorni nostri (rist. Milano,
Zero in condotta, 2003), nel quale, affrontando il pensiero
di Godwin, Proudhon, Bakunin, Kropotkin, Stirner e Malatesta,
si dà conto della evoluzione dell’idea libertaria,
della sua complessità e capacità di adattarsi
al mutare delle condizioni sociali, senza perdere la coerenza
delle istanze antiautoritarie.
Allo stesso contesto appartiene la ristampa di L’anarchismo
attraverso i secoli (Pescara, Samizdat, 1996),
il vecchio e introvabile capolavoro di Max Nettlau, “l’Erodoto
dell’anarchia”, che probabilmente rappresenta il
primo tentativo di dare sistematicità agli studi sull’anarchismo.
Un’altra fortunata e istruttiva antologia sull’anarchismo,
che rende molto efficacemente la ricchezza della storia e del
pensiero anarchico, è il classico di Daniel Guerin, L’anarchismo
dalla dottrina all’azione, che ebbe grande
fortuna editoriale negli anni Sessanta ed è stato opportunamente
ristampato (Pescara, Samizdat, 1998).
Molto utile anche Il Pensiero anarchico. Alle radici
della libertà, curato da Filippo Pani e
Salvo Vaccaro (Verona, Demetra, 1997), che ripercorre tutte
le tappe attraverso le quali si sono sviluppati il pensiero
e il movimento anarchico, analizzate per tematiche e descritte,
il che non guasta, in modo scorrevole.
Di tutt’altro carattere e anche di minore spessore, comunque
utile, l’antologia del pensiero libertario conservatore
di matrice anglosassone, Anarchici senza bombe,
curata da Alberto Mingardi e Guglielmo Piombini (Roma, Stampa
Alternativa, 2001). Al di là del titolo un po’
stupido e superficiale, l’opuscolo consente di dare un
rapido sguardo alle “strane” ed eterodosse teorie
di Rothbard e company, che si richiamano costantemente all’anarchia
ma con le quali, nonostante le strumentali intenzioni dei loro
sostenitori, l’anarchismo classico e... classista ha ben
poco a che spartire.
Sulle contraddizioni del “libertarismo di destra”
anglosassone e sulla confusione interessata fra liberismo e
libertarismo creata dagli assertori del libero mercato, interviene
opportunamente Luigi Corvaglia con Psicopatologia
della libertà. Lineamenti di una psicologia anarchica
del sociale (Pescara, Samizdat, 2000), una “proposta
di lettura trasversale e alternativa dei concetti di libertà
e di dominio”.
 Diverse
Diverse
angolature
Come ogni altro complesso di idee che si proponga di cogliere
e analizzare tutti gli aspetti della vita sociale, anche l’anarchismo,
nelle sue differenti manifestazioni, si è proposto come
sistema particolare e organico di analisi e di proposte.
Ispirandosi all’anarchismo e alla sua attitudine a sviscerare
le tematiche sociali muovendo da differenti spunti di analisi,
non sono pochi gli studi e i contributi critici, più
o meno militanti, che si propongono di affrontare da diverse
angolature l’interpretazione dei fenomeni sociali e offrire
soluzione al problema dell’autorità e della libertà.
In questa sezione si cercherà in tal senso di passare
in rassegna il “vecchio” e il “nuovo”
stampato in questi anni.

Luce
Fabbri
Molto interessante, innanzitutto, l’antologia degli
scritti di Luce Fabbri, figlia di Luigi, morta da pochi anni
dopo una vita passata in esilio in Uruguay, Una
strada concreta verso l’utopia. Itinerario anarchico di
fine millennio, che Samizdat ha dedicato alla
acuta e intelligente saggista (Pescara, 1998). Si tratta, in
gran parte, di articoli tratti da «Opcion Libertaria»
– il periodico da lei fondato e che ancora esce nella
capitale uruguayana – nei quali spicca la sua sorprendente
capacità di riflettere sul nuovo e di cogliere implicazioni
libertarie anche in fenomeni sociali apparentemente lontani.
Un’altra analisi sulle dinamiche che interagiscono soprattutto
con il mondo del lavoro e i suoi rapporti sociali, è
l’opuscolo di Cosimo Scarinzi, L’enigma
della transizione. Conflitto sociale e progetto sovversivo
(Milano, Zero in condotta, 2000), una raccolta di articoli usciti
su «Umanità Nova», mai banali e sempre stimolanti,
sulle teorie che vanno nella direzione della trasformazione
radicale dell’esistente.
Scendendo in Sicilia, si segnala la pubblicazione del Programma
per l’intervento politico e sociale stilato
dalla Federazione Anarchica Siciliana (Ragusa, La Fiaccola,
2004). Si tratta delle analisi sulla “fase” compiute
recentemente dai compagni siciliani e opportunamente assemblate
in un testo organico e maneggevole.
Un’altra raccolta di articoli, che comprende i corsivi
feroci e irriverenti a firma di Sciruccazzu, è I
Corsivi di Sicilia Libertaria (Ragusa, La Fiaccola,
2004), puntuali nel denunciare ogni mese, sul giornale che esce
con regolarità da circa trent’anni, le malversazioni
del sistema di potere siciliano. Fermandoci in Sicilia, segnalo
il meritato omaggio che La Fiaccola, nel 1999, ha dedicato a
uno dei suoi padri fondatori, Franco Leggio, raccogliendo in
Avanti avanti con la fiaccola nel pugno e con la
scure i caustici e incendiari “fuoritesto”
degli innumerevoli opuscoletti da lui stampati negli anni Sessanta.
 Luigi Galleani
Luigi Galleani
Restando alle raccolte di articoli, ricordo il classico Faccia
a faccia col nemico di Luigi Galleani, la cui
prima edizione risale al 1914 e che è stato recentemente
riproposto da Galzerano (Casalvelino, 2002). I lettori meno
giovani ne conoscono lo stile declamatorio e ridondante, ma
efficace nella virulenza contro il “nemico” e nell’esaltazione,
a volte acritica, di quanti hanno dato vita e pensiero all’ideale
anarchico. Di tutti i lavori di Luigi Galleani, questo resta
forse la testimonianza più chiara, anche se un po’
datata, di come egli intendesse e interpretasse l’anarchismo.
Di tutt’altro segno, come stile e approccio alla realtà
sociale, il testo di Salvo Vaccaro, Cruciverba.
Lessico per i libertari del XXI secolo (Milano,
Zero in condotta, 2001), una sorta di lemmario ragionato con
il quale l’apprezzato studioso di filosofia della politica
affronta con acume le “voci” che esprimono i concetti
cruciali da cui “muovere verso una genealogia del pensare
libertario contemporaneo”. Sempre di Vaccaro, vanno segnalati
altri due testi, il primo Anarchia e progettualità.
Per l’autogoverno extra-istituzionale (Milano,
Zero in condotta, 1996), nel quale le proposte autogestionarie
sono pensate non come una realizzazione futura, ma come strumenti
d’azione sociale, per vivere e trasformare l’immediato;
il secondo, Anarchismo e modernità
(Pisa, Bfs, 2004) rappresenta una complessa e approfondita sistematizzazione
del rapporto fra il pensiero anarchico, tradizionale e innovativo
al tempo stesso, e le sfide poste dal continuo mutare dei rapporti
e delle dinamiche sociali. Sempre nel campo della filosofia
politica si colloca il lavoro curato da Franco Riccio, Spazi
eccentrici. Mappe del molteplice sociale (Pisa,
Bfs, 2003) che raccoglie, tra gli altri, i saggi di Cardella,
Castoriadis, Lucido e Riccio stesso.
Sulla modernità del pensiero anarchico e sulla sua ininterrotta
capacità di interpretare e intervenire nel presente,
ricordo il testo dell’irlandese Séan M. Sheehan,
Ripartire dall’anarchia. Attualità
delle idee e delle pratiche libertarie (Milano,
Elèuthera, 2004), una sorta di viaggio d’esplorazione
che, partendo da Seattle, scopre le sensibilità libertarie
che percorrono l’oggi senza soluzioni di continuità.

Colin
Ward
Sempre Elèuthera, nel 1996, ha ripubblicato un altro
classico dell’anarchismo moderno, La pratica
della libertà. Anarchia come organizzazione,
di Colin Ward (la prima edizione risale al 1973), nel quale
lo scrittore inglese, giocando sul paradosso, interpreta l’anarchia
come efficace organizzazione sociale non solo sul piano ipotetico
ma, anche e soprattutto, su quello fattuale. Per venire a uno
dei nomi più conosciuti del pensiero libertario, segnalo
il testo di Noam Chomsky forse più attinente con questa
bibliografia, Anarchia e libertà
(Roma, Datanews, 2003). In questa raccolta di saggi e interviste,
il filo conduttore è l’analisi di quanto sia preminente
il tema della libertà all’interno del pensiero
e del movimento anarchico e come tale preminenza faccia dire
a questo “guru” mondiale del pensiero radicale,
di essere e sentirsi anarchico.
Sempre di Chomsky, Alla corte di Re Artù
e Illusioni necessarie (Milano, Elèuthera,
2002 e 2003), altri due testi di questo “inguaribile guastafeste
dell’intellighenzia americana”, critico sempre spiazzante
dei luoghi comuni del potere.
Infine, di Vittorio Giacopini, La comunità
che non c’è. Paul Goodman, idee per i movimenti
(Trento, Nonluoghilibere, 2003), sul pensiero di una delle più
significative figure intellettuali del Nord America, già
riferimento per i movimenti giovanili degli anni Sessanta.
 Né stato
Né stato
né chiesa
Prendiamo ora in considerazione le materie più specifiche
che hanno caratterizzato la riflessione e l’azione militante
degli anarchici.
Forse anche per una certa predisposizione personale, partirò
dalle tematiche antireligiose e anticlericali, e dal rapporto
conflittuale che il movimento anarchico ha sempre intrattenuto
con le strutture chiesastiche e le sovrastrutture religiose.
Come si vedrà, le edizioni siciliane de La Fiaccola si
dimostrano particolarmente interessate a mantenere attuale la
“lotta alla superstizione religiosa”.
Lo dimostra la ristampa del vecchio e fortunatissimo testo di
Nicola Simon Viaggio umoristico attraverso i dogmi
e le religioni (Ragusa, 1996). È l’ennesima
edizione di questo feroce e irriverente pamphlet francese dell’Ottocento,
con il quale, in pieno positivismo e materialismo, si mettevano
in ridicolo le credenze e le assurdità comuni a tutte
le religioni. Di Walter Siri, le edizioni Sempre Avanti hanno
pubblicato Senza dio senza padroni
(Livorno, 1997), chiara ed efficace la prosa del compagno bolognese,
fra gli animatori dei meeting anticlericali svoltisi recentemente
in varie località italiane e attento critico dell’invadenza
clericale e dei rapporti di potere fra capitale e Chiesa.
Di Mimmo Franzinelli, studioso quotato in campo nazionale, Il
clero del duce, il duce del clero. Il consenso ecclesiastico
nelle lettere a Mussolini (1922-1945) (Ragusa,
La Fiaccola, 1998), una interessante, sorprendente e a tratti
divertente antologia della “corrispondenza”, sempre
rispettosa e spesso affettuosa fra le gerarchie ecclesiastiche
e il duce del fascismo, che da ateo, mangiapreti e anticlericale
quale era, si trasformò, opportunisticamente, nell’ossequioso
sacerdote del privilegiato rapporto fra Chiesa e potere.
Sempre La Fiaccola, nel 1999, ha edito La Santa
Inquisizione, di Maurizio Marchetti, dove l’autore,
senza giri di parole, compila un’ordinata cronologia dei
misfatti compiuti nei secoli da questa “santa” istituzione.
“Reverendo, giù le mani!”. Clero e reati
sessuali negli anni 30 e negli anni 90 è
il titolo di un volume senza indicazione di autore, forse un
po’ greve nel taglio e per certi aspetti datato, che resta
comunque interessante nel testimoniare la continua benevolenza
del potere verso i “crimini” sessuali sacerdotali,
sia durante il fascismo sia in piena legalità repubblicana
(Ragusa, La Fiaccola, 2000).
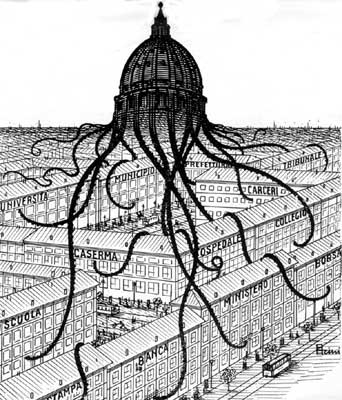
La
piovra vaticana vista da Giuseppe Scalarini
Del libro di Vittorio Giorgini, Le religioni plagiano
(Ragusa, La Fiaccola, 2002) si può dire che l’apoditticità
del titolo non ha bisogno di commenti. Originale è la
riproposta di due testi di uno dei massimi poeti dell’Ottocento,
l’inglese Percy B. Shelley, La necessità
dell’ateismo. La mascherata dell’anarchia
(Salorino, L’Affranchi, 2004), talmente radicali, nei
loro contenuti rivoluzionari, da essere costati all’autore
l’espulsione da Oxford, alla faccia della libertà
d’espressione. Di tutt’altro taglio La
piovra vaticana di Pippo Gurrieri (Ragusa, La
Fiaccola, 2004). Editore da un trentennio del combattivo «Sicilia
Libertaria» e da sempre propagandista efficace e convincente,
l’autore non si è mai sottratto all’impegno,
sia come militante sia come editore, di tenere accesa la “fiaccola”
del pensiero libero e libertario contro i tentacoli onnipresenti
della “piovra vaticana”.
Per finire, lo studio quanto mai interessante e istruttivo di
Emanuele Del Medico, All’estrema destra del
padre. Tradizionalismo cattolico e destra radicale
(Ragusa, La Fiaccola, 2004), un inquietante documento sulle
connessioni, non solo ideologiche ma anche operative, tra il
tradizionalismo cattolico e la destra radicale. Connessioni
che si manifestano nella affermazione di valori che non tengono
conto delle mutazioni culturali delle nostre società,
ma anzi le rifiutano.
 Contro
Contro
le camicie nere
L’antifascismo è stato senz’altro uno degli
aspetti più significativi e caratterizzanti, in certi
momenti addirittura centrale, nell’azione e nella riflessione
dell’anarchismo.
In particolare in questo periodo, quando sembra affermarsi quel
sottofenomeno definito “revisionismo storico”, che
si propone di rivalutare il fascismo, per lo meno in molti dei
suoi aspetti, è opportuno insistere con testi che facciano
chiarezza sull’abissale distanza che separa il fascismo
dalla pratica della libertà; e anche da parte nostra
si contribuisce ad arginare questa tendenza alla rivalutazione
della dittatura.
Ecco dunque un classico di Camillo Berneri, Mussolini,
psicologia di un dittatore (Pescara, Samizdat,
2001). Impegnata a rimettere in circolazione gli introvabili
classici anarchici, l’editrice abruzzese ha reso accessibile
lo studio con il quale Berneri, documenti alla mano, diede conto
della pochezza morale di Mussolini – il più grande
statista del secolo, come ha avuto a dire Fini – surrogata
solamente dalle sue grandi e volgari doti istrioniche e demagogiche.
Sullo stesso piano, Mussolini, la maschera del dittatore,
di Pier Carlo Masini (Pisa, Bfs, 1999), praticamente l’ultima
fatica dell’autore. Riprendendo e completando il precedente
lavoro di Berneri, ancora una volta Masini ha colto i tratti
essenziali del suo oggetto di studio, smascherando e irridendo
i tratti più paradossali e truffaldini di colui che arrivò
a credersi il naturale erede di Giulio Cesare.
Venendo a tempi recenti, e ai nuovi fascisti, va segnalato il
libro di Alain Bihr, L’avvenire di un passato,
l’estrema destra in Europa (Pisa, Bfs, 1997),
nel quale si analizzano le molteplici forme in cui si manifesta
il risorgere delle organizzazioni della destra europea, dal
Front National di Le Pen ai numerosi movimenti xenofobi e sessuofobi.
Di taglio simile il testo di Marco Rossi I fantasmi
di Weimar, Origini e maschere della destra rivoluzionaria
(Milano, Zero in condotta, 2001). Un lavoro di indagine e denuncia
in cui l’autore, attento ed esperto studioso del fenomeno
neofascista, mostra la varietà, a volte solo apparentemente
contraddittoria, con cui si presenta e si manifesta il pensiero
autoritario e oppressivo che chiamiamo comunemente fascismo.
Marco Coglitore e Claudia Cernigoi, ne La memoria
tradita. L’estrema destra da Salò a Forza Nuova
(Milano, Zero in condotta 2002), compiono un lungo viaggio attraverso
gli epigoni del più violento estremismo neofascista,
fra coloro che in questi sessant’anni di repubblica hanno
contribuito a rappresentare, con allarmante continuità,
settori non secondari, ma a volte addirittura determinanti,
della cultura reazionaria e tradizionalista italiana. A cura
dell’Archivio Antifascista, è uscito Forza
Nuova. I ragazzi venuti da Salò (Milano,
Zero in condotta, 2003), un utile dossier di controinformazione
sulla più aggressiva delle attuali formazioni della destra,
frutto dell’ormai decennale attività di un gruppo
di compagni dediti a studiare il fenomeno neofascista in Italia
in tutte le sue forme.
 Signornò!
Signornò!
E veniamo ora all’antimilitarismo, un altro dei temi
forti, sul quale non è mai mancato l’originale
contributo dell’anarchismo. Il primo testo da cui partire
è Di fronte alla guerra. L’obiezione
presentata al Tribunale militare di Losanna nel 1940
di Lucien Tronchet (Lugano, La Baronata, 1996), sul rifiuto
di due antimilitaristi svizzeri di indossare la divisa; oltre
ad essere condannati a parecchi mesi di prigione, essi furono
trattati da vigliacchi e traditori, proprio quando il loro gesto,
in piena guerra, mostrava un grande coraggio civile.
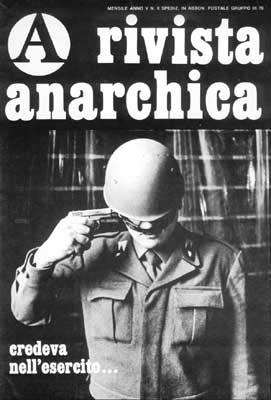
Restando nell’ambito della difficile arte dell’obiezione
al servizio militare, l’Archiviu-Bibrioteka Tomaso Serra
di Guasila ha pubblicato, nel 1997, L’obiezione
di coscienza anarchica in Italia di Piero Ferrua.
È il primo volume (siamo in attesa del secondo) dedicato
alle complesse vicende dell’obiezione, dagli anni pionieristici
dopo la guerra, fino agli anni Novanta. L’autore fu protagonista
di una delle prime dichiarazioni di rifiuto, e pertanto questa
è una storia-cronaca descritta dall’interno: un
documento che mostra come i giovani anarchici siano stati i
precursori di un atto che avrebbe visto una “esplosione
demografica” solo nei politicizzatissimi anni Settanta.
A cura della Assemblea Antimilitarista e Antiautoritaria, è
uscito l’opuscolo Per un futuro senza eserciti
(s.l. [ma: Carrara], A.A.A., 2004). Si tratta del lavoro collettivo
di una rete di gruppi e individui attivi sul territorio nella
critica radicale ad ogni forma di autoritarismo, che si propone
come utile strumento di analisi e di lavoro per una sana pratica
antimilitarista. Antimilitarismo è anche guerra alla
guerra, ed è quanto propone Peter Schrembs, nel suo La
pace possibile (Lugano, La Baronata, 2004). L’autore,
sull’onda dell’invasione americana in Irak, riflette
sulle possibilità di dare sistematicità alle potenzialità
offerte dall’antimilitarismo e dall’antiautoritarismo
propri del pensiero anarchico.
Tornando indietro nel tempo, segnalo la prima edizione italiana
del libro straordinario di Ernst Friedrich, Guerra
alla guerra. 1914-1918. Scene di orrore quotidiano
(Milano, Mondadori, 2004), un testo che rappresenta uno dei
più impressionanti e agghiaccianti manifesti antimilitaristi,
come volle che fosse, nel lontano 1924, il suo autore, un ex
soldato anarchico testimone, suo malgrado, degli orrori della
Grande guerra. Le numerose foto che mostrano morti e orribili
mutilazioni sono di una tale crudezza da denunciare gli orrori
della guerra e del militarismo più di qualsiasi parola.

Maria
Luisa Berneri
Termino l’argomento antimilitarista citando, di Marie
Louise Berneri e Vera Brittain, Il seme del Caos.
Scritti sui bombardamenti di massa (1939-1945)
(Santa Maria Capua Vetere, Spartaco, 2004). Nella Londra martoriata
dalle V-2 tedesche si levò la voce ostinatamente antimilitarista
e nonviolenta di queste due donne dai percorsi differenti ma
che, dalle pagine di «War Commentary» e di innumerevoli
opuscoli, trovarono una profonda assonanza nella denuncia, politica
e morale, della bestialità bellica che stava distruggendo
l’Europa.
 Astensionismo
Astensionismo
e federalismo
Astensionismo e federalismo sono temi quanto mai cari agli
anarchici, ma il fatto che siano ormai profondamente sedimentati
nel loro sentire spiega come mai in questi anni la nostra editoria
se ne sia curata poco.
Sull’astensionismo segnalo, di Massimo Varengo, Astensione.
Arma rivoluzionaria contro governo e parlamento
(Livorno, Sempre Avanti, 1994). L’autore, consapevole
dell’importanza ricoperta dalla pratica astensionista,
affronta, con competenza “militante”, aspetti e
conseguenze del rifiuto della delega, integrando il suo saggio
con una ricca appendice documentaria. Sul federalismo segnalo
una sorta di piccolo manuale ad opera di Gigi Di Lembo, Il
federalismo libertario e anarchico in Italia dal Risorgimento
alla Seconda guerra mondiale (Livorno, Sempre
Avanti, 1994).

Per chi non avesse ancora chiara la differenza abissale che
intercorre fra il federalismo escludente di bassa lega e quello
ugualitario e solidale dell’anarchismo, figlio di Cattaneo
e Pisacane, questa lettura si rende davvero indispensabile.
Restando in tema di federalismo e Lega Nord, segnalo, di Maria
Matteo, Marco Rossi e Cosimo Scarinzi, Le armi della
Lega. Razzismo, xenofobia e populismo in Val Padana
(Livorno, Sempre Avanti, 1998). Uscito quasi un decennio fa,
il testo conserva ancora la sua attualità per la chiarezza
e l’efficacia con cui denuncia l’estremismo razzista
dei “padani”, sostanziale puntello di quel potere
statale che questi beceri individui affermano, invece, di voler
combattere.
 Sindacalismo
Sindacalismo
rivoluzionario
E veniamo ora al sindacalismo, al mondo del lavoro e alla necessità
di costruire un’organizzazione orizzontale e non verticistica
con i lavoratori più coscienti. Il movimento anarchico
ha sempre marciato a fianco degli sfruttati, nella consapevolezza
che l’eliminazione dello sfruttamento è premessa
indispensabile e necessaria per realizzare una società
liberata. Ecco allora il significativo Il sindacalismo
autogestionario. L’Usi dalle origini ad oggi,
di Gianfranco Careri (Roma, Unione Sindacale Italiana, 1991),
che ricostruisce la storia dell’Unione Sindacale Italiana,
il sindacato anarchico autogestito che ha vissuto, soprattutto
nel primo dopoguerra, una stagione di grandi lotte, consensi
e successi. L’autore, per anni segretario generale di
questo sindacato, ma anche militante di base, offre una rara
testimonianza specifica su una delle organizzazioni più
interessanti del panorama libertario. Di Maurizio Antonioli,
il più competente storico dei movimenti sindacali, va
ricordato Azione diretta e organizzazione operaia.
Sindacalismo rivoluzionario e anarchismo tra la fine dell’Ottocento
e il fascismo (Manduria, Lacaita, 1990), dove
si affrontano gli intensi e continui rapporti intercorsi fra
avanguardie sindacali e movimento anarchico, a smentita del
vieto luogo comune sull’individualismo e sul presunto
disinteresse degli anarchici per la lotta di classe e sindacale.
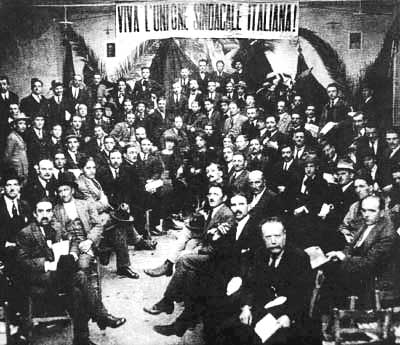
Roma,
10-13 marzo 1922 – Il 4° congresso dell’Unione
Sindacale Italiana
Le edizioni Zero in Condotta hanno poi pubblicato i vecchi
ma sempre interessanti articoli che Alibrando Giovannetti scriveva
sul giornale americano «Il Proletario» negli anni
Venti. Il sindacalismo rivoluzionario in Italia.
L’azione diretta, le lotte e le conquiste proletarie
(Milano, 2004) offre la puntigliosa ricostruzione degli avvenimenti
legati alla “rivoluzione mancata” del primo dopoguerra,
consentendo una riflessione quanto mai attuale sulle strategie
di lotta dei movimenti sindacali e rivoluzionari.
 Una scelta
Una scelta
ecologista
Anche nel campo ecologista e dello sviluppo urbano sostenibile,
non mancano interessanti contributi, stimolati soprattutto dalla
linea editoriale scelta da Elèuthera.
Attenta a queste tematiche, l’editrice ha creato una vera
e propria collana saggistica, con caratteristiche di alta qualità
scientifica e di facile fruibilità, anche per i non addetti
ai lavori. Innanzitutto va segnalata la seconda edizione di
uno dei “testi sacri” di Murray Bookchin, Democrazia
diretta. Idee per un municipalismo libertario
(Milano, Elèuthera, 2000), ispiratore di quel concetto
di cittadinanza, intesa come “partecipazione attiva e
diretta dei cittadini alla politica”, che ha stimolato
la riflessione e l’azione del movimento anarchico in questi
ultimi anni.
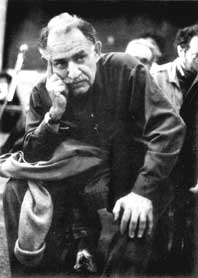 Murray Bookchin
Murray Bookchin
Di Franco Bunçuga sono le Conversazioni
con Giancarlo De Carlo. Architettura e libertà
(Milano, Elèuthera, 2000), la penetrante testimonianza
lasciataci dal grande urbanista da poco scomparso, attento intellettuale
libertario vicino al movimento nel secondo dopoguerra, che ha
sempre improntato il suo lavoro alla realizzazione di progetti
di forte impegno sociale. Colin Ward, in Acqua e
comunità. Crisi idrica e responsabilità sociale
(Milano, Elèuthera, 2003), affronta uno fra i problemi
più drammatici del prossimo futuro, quello della conclamata
scarsità delle risorse idriche. Drammatico per le politiche
di rapina e di sconsiderato sfruttamento praticate ovunque dai
poteri che condizionano i destini del mondo, il problema potrebbe
trovare risposte razionali e praticabili nelle semplici soluzioni
prospettate dallo studioso anglosassone.
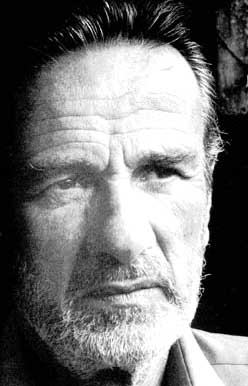 Giancarlo
De Carlo
Giancarlo
De Carlo
Sempre a testimonianza dell’attenzione con la quale
Elèuthera segue queste tematiche, è stato pubblicato,
nel 2003, La città imprevista. Il dissenso
nell’uso dello spazio urbano, di Paolo Cottino,
un giovane esperto di pianificazione del territorio, che contribuisce,
con questo tassello, all’illustrazione di un’ipotesi
di migliore vivibilità quotidiana non utopistica ma realizzabile
e supportata da esempi concreti. Della stessa casa editrice,
Progettare per abitare (Milano, 2003),
di Adriano Paolella, al quale si deve inoltre Abitare
i luoghi (Pisa, Bfs, 2004).
 Pedagogia
Pedagogia
libertaria
“Lasciate che i bambini vengano a me” disse chi
era consapevole del valore dell’educazione nella formazione
delle coscienze degli adulti. Anche per bilanciare e contrastare
gli strumenti educativi autoritari e coercitivi del potere,
gli anarchici hanno posto particolare attenzione al problema
educativo, cercando strade che portassero alla formazione di
coscienze libere e consapevoli.
Della grande ricchezza e varietà delle esperienze pedagogiche
promosse dagli anarchici, e dell’importanza che è
sempre stata attribuita all’insegnamento, inteso come
formazione libera e libertaria del fanciullo, tratta Francesco
Codello nel suo recente La buona educazione. Esperienze
libertarie e teorie anarchiche in Europa da Godwin a Neill
(Milano, Angeli, 2005): un ricco e documentato studio sulle
esperienze educative che hanno visto all’opera pensatori
e maestri libertari e che mostra i tentativi, a volte falliti
ma sempre generosi e intelligenti, di sottrarre l’educazione
dei giovani alla chiesa e allo Stato.
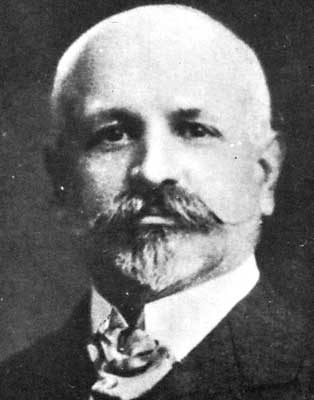
Francisco
Ferrer
Dell’esperienza forse più famosa, anche per la
drammatica sorte del suo promotore, tratta Giuliana Iurlano
in Da Barcellona a Stelton. Ferrer e il Movimento
delle Scuole Moderne in Spagna e negli Stati Uniti
(Milano, M&B, 2000), un importante studio su Francisco Ferrer,
sulla formulazione della sua teoria e della sua pratica pedagogica,
profondamente innovativa rispetto ai tempi e caratterizzata
da fortissime tensioni razionaliste e libertarie. Talmente libertarie
da causare la morte per fucilazione del suo protagonista –
fortemente voluta dai preti – nella Spagna del 1911.
Di un altro grande pedagogista libertario scrive Sabrina Pulvirenti
in Paul Robin (Catania, Coop. Univ.
Editrice Catanese di Magistero, 1999), un testo interessante
non solo perché ricostruisce l’esistenza di un
personaggio centrale nell’esperienza pedagogica libertaria,
ma anche perché è l’unico pubblicato in
Italia su questo personaggio vissuto a cavallo fra Ottocento
e Novecento, molto noto e apprezzato in Francia.
Elèuthera ha ricordato Lamberto Borghi, il più
grande pedagogista italiano, pubblicando nel 2000 La
città e la scuola, un’antologia di
testi fondamentali usciti sulla rivista «Scuola e città»
dai primi anni ’50 fino agli anni ’90, curata da
Goffredo Fofi, a cui si deve anche la prefazione.
Va poi segnalato, di Rino Ermini, Per una pedagogia
libertaria (Livorno, Sempre Avanti, 1998), un
breve studio sulla possibilità di dare un senso libertario
e di trasformazione radicale all’insegnamento, una proposta
e un’ipotesi indirizzate al sensibile e attento mondo
degli insegnanti e un invito a infondere contenuti rivoluzionari
anche dietro l’apparenza della normalità. Infine,
di Filippo Trasatti, Lessico minimo di pedagogia
libertaria (Milano, Elèuthera, 2004), nel
quale l’autore offre una prospettiva di lettura delle
idee-forza dell’educazione libertaria per come si sono
espresse negli anni. Passando dalla teoria alla pratica, va
segnalato Gli anarchici di Clivio e la Scuola moderna
razionalista, a cura di Amerigo Sassi (Varese,
Macchione, 1998), testo che ripercorre, anche con l’aiuto
di numerose fotografie, la storia di una delle più originali
esperienze pedagogiche messe in atto agli inizi del Novecento
dagli anarchici: in questo caso, significativamente, nel bianco
Varesotto.
 Per una critica
Per una critica
radicale
Veniamo, ora, alla critica radicale della società e
alla prospettiva di una trasformazione profonda, in grado di
coniugare le tensioni utopistiche del pensiero libertario con
prospettive oggettivamente praticabili. Curata da Salvo Vaccaro
nel 1999, Elèuthera propone Il pianeta unico.
Processi di globalizzazione, una raccolta di testi
sul processo di globalizzazione apparentemente inarrestabile,
rispetto al quale, però, gli autori contrappongono l’idea
che questo sia ancora in divenire e che, pertanto, sia possibile
creare spazi alternativi e liberati. Sempre in contrapposizione
all’idea che “questo” progresso sia ineluttabile,
interviene più volte John Zerzan, sia con Ammazzare
il tempo, sia con Futuro primitivo
(Torino, Nautilus, 1995 e 2001). Si tratta di due testi esemplari
di questo originale teorico del primitivismo, molto seguito
negli Usa, che prospetta una società “altra”,
nella quale sia abolito lo scambio a favore del dono e del gioco,
dove sia possibile emanciparsi dalla tecnocrazia, e dove la
liberazione dallo sfruttamento coincida con l’esaltazione
della creatività degli individui. Sotto lo pseudonimo
di Odoteo e Crisso, è stato pubblicato Barbari.
L’insorgenza disordinata (Pont St. Martin,
NN, 2002). Gli autori, critici delle argomentazioni pseudo-rivoluzionarie
oggi a là page e attenti alle loro implicazioni,
propongono questo efficace e irriverente ribaltamento libertario
dell’ultimo best seller di Toni Negri, Impero,
rilevando la sottile ambiguità del teorico della “moltitudine”
e l’altrettanto sottile esaltazione del capitalismo e
del suo ruolo.
Per finire citiamo, di David Goodway, Conversazioni
con Colin Ward. Lo sguardo anarchico (Milano,
Elèuthera, 2003), una sorta di libro-intervista nel quale
l’autore, docente di storia sociale all’università
di Leeds, evidenzia nell’anarchismo anglosassone di Colin
Ward, insegnante, pubblicista e filosofo, la peculiare espressione
dell’anarchismo pragmatico di un osservatore attento a
cogliere “il seme dell’anarchia reale” nelle
cose che vengono fatte e nel modo in cui vengono fatte.
 Sebben che
Sebben che
siamo donne
Termino questo excursus sulle tematiche dell’anarchismo
segnalando i testi usciti in quest’ultimo decennio, dedicati
ad approfondire la conoscenza del ruolo femminile nel movimento
libertario, sia come presenza militante sia come apporto di
idee.

Emma
Goldman
Due sono le biografie al femminile uscite in questi anni.
La prima è di Emma Goldman, Vivendo la mia
vita, di cui Zero in condotta ha pubblicato, nel
1993, il quarto e ultimo volume (dopo i tre usciti per La Salamandra
negli anni Settanta). Da questa straordinaria autobiografia
dell’anarchica russo-americana di origine ebrea esce un
quadro suggestivo, non solo delle vicende dell’autrice,
ma anche degli avvenimenti più importanti della prima
metà del Novecento dei quali “red Emma” fu
protagonista. Rudolf Rocker è autore di Zensl
Elfinger Mühsam. Una libertaria in lotta contro i totalitarismi
(Ragusa, La Fiaccola, 2002), in cui narra la drammatica parabola
di vita di questa limpida militante libertaria, compagna di
Erich Mühsam ucciso in un lager nazista, e lei stessa drammaticamente
passata per i gulag sovietici, a dimostrazione di quanto sia
stata irriducibile l’etica anarchica rispetto ai totalitarismi
che insanguinarono il secolo passato. Spartaco ha poi pubblicato,
di Mary Wollstonecraft, Tempo di rivoluzioni. Sui
diritti degli uomini e delle donne (Santa Maria
Capua Vetere, 2004), con una bella introduzione della Goldman
sul pensiero di questa antesignana del femminismo, moglie di
William Godwin e vissuta ai tempi della Rivoluzione francese.

Il
calvario dell’anarchico ebreo tedesco Erich Mühsam
in un disegno di George Grosz
Di tutt’altro tenore, ma sempre legato alle tematiche
femminili, è il testo di Chiara Gazzola e Laura Siddi,
Il desiderio, il controllo e l’eresia. Approcci
critici alla bioetica (Ragusa, La Fiaccola, 2003).
Scritto a quattro mani, ma frutto di un ricco dibattito tutto
fra donne, svoltosi al 18° meeting anticlericale, il saggio
offre un’inedita e interessante possibilità di
confronto con quanto il pensiero anarchico può dire su
problemi quali la bioetica, la fecondazione assistita e la sperimentazione
dei farmaci su donne e bambini.
 Al cinema
Al cinema
Se, come visto, non sono poche le opere relative agli aspetti
politici e militanti dell’anarchismo, altrettante sono
quelle che fanno riferimento alle frequenti e felici “contaminazioni”
con il mondo della cultura. E non c’è alcun ambito
artistico che non registri lavori interessanti e innovativi.
Iniziando dal cinema, da segnalare sono soprattutto i lavori
di Pino Bertelli, critico anticonformista dal forte afflato
libertario. Luis Buñuel il fascino discreto
dell’anarchia (Pisa, BFS, 1996) traccia
un profilo della vita e dell’opera di questo grande regista
spagnolo, tanto surrealista sul piano dell’estetica quanto
sovversivo su quello dell’impegno politico; Cinema
e anarchia. Nell’età della falsificazione e del
conformismo sociale (1992-1998) (Ragusa, La Fiaccola,
1998) raccoglie una serie di scritti e recensioni apparsi su
varie testate; e infine Glauber Rocha. Cinema in
utopia. Dall’estetica della fame all’estetica della
libertà (Ragusa, La Fiaccola, 2002) è
un interessante lavoro sul regista brasiliano e sulla grande
tradizione “innovativa” del Cinema Novo del paese
sudamericano. Da citare, infine, Il cinema libera
la testa. Elogio della ribellione nella macchina/cinema,
di Fratel Luther Blissett (Ragusa, La Fiaccola, 2004). Arricchito
dalla prefazione di Guy Debord e dall’introduzione di
Raoul Vaneigem, è un trattato sulla ribellione libertaria
nella storia del cinema, con particolare attenzione alle opere
di Vigo, Buñuel, Rocha, Truffaut e Pasolini.
 Arti figurative
Arti figurative
Nel campo delle arti figurative, ricordo lo studio di Eva Civolani,
La sovversione estetica. Arte e pensiero libertario
tra Ottocento e Novecento (Milano, Elèuthera,
2000), dove sono messi in luce i numerosi e felici momenti di
contatto tra le correnti artistiche più sovversive, dal
dadaismo al simbolismo, dal futurismo al surrealismo, e la “forma
più estrema di sovversione sociale”, l’anarchismo.
Curato sempre da Eva Civolani e da Antonietta Gabellini è
Mio caro Lucien. Lettere al figlio su arte e anarchia
di Camille Pissarro (Milano, Elèuthera,
1998), che raccoglie la copiosa corrispondenza intercorsa fra
il grande pittore impressionista e il figlio, ricca di riferimenti
non solo ai problemi legati all’estetica pittorica, ma
anche ai grandi temi politici e sociali a cui partecipò
Pissarro, come dimostra la collaborazione a numerose pubblicazioni
libertarie e la splendida raccolta di disegni Turpitudes
Sociales.
Ricco di spunti è Baj Bakunin, Ascona. Atti
del convegno 1996 (Lugano, La Baronata, 2000),
testo che raccoglie gli atti di un convegno interessante e per
tutti i gusti, che si tenne in Svizzera in occasione dell’inaugurazione
dello “smonumento” a Bakunin, e si svolse nel solco
della migliore tradizione patafisica di cui il pittore milanese
era maestro.

Cacacazzo,
personaggio realizzato da Enrico Baj
Ancora di Baj e Paul Virilio, Discorso sull’orrore
dell’arte (Milano, Elèuthera, 2002),
stimolante confronto e dialogo fra l’artista e l’urbanista
francese, che vede i due interrogarsi reciprocamente sulla percezione
dell’arte e dei luoghi che la ospitano e la espongono.
Nel 2000, per le edizioni del Centro Internazionale della Grafica
di Venezia, è apparso un curioso opuscolo di Alberto
Ciampi, Forma e forme. I colori dell’anarchia
nelle pubblicazioni periodiche, dove l’autore,
indagando sulle forme artistiche coniugate all’anarchia,
analizza l’uso del colore, e i suoi significati non detti,
nelle pubblicazioni anarchiche.
Per finire con le arti figurative in senso lato, veniamo a un
testo più propriamente militante, quello curato da Massimiliano
Giorgi, Gli anarchici non archiviano
(Carrara, Germinal, 2002). Si tratta del catalogo dei manifesti
conservati presso il Circolo Culturale Anarchico di Carrara,
molti dei quali stampati dalla Cooperativa Tipolitografica ed
esposti nella mostra tenutasi nella città del marmo.
Una cavalcata sorprendente e stimolante lungo trent’anni
di comunicazione “gridata” dai muri italiani, che
consente di cogliere con immediatezza i modi e i settori d’intervento
degli anarchici.
 A teatro
A teatro
In campo teatrale, cominciamo con Dal cabaret alle
barricate (Milano, Elèuthera, 1999), una
antologia dei feroci testi satirici di Erich Mühsam, il
geniale intellettuale ebreo tedesco impegnato nella lotta contro
il totalitarismo nazista, torturato e ucciso in uno dei primi
campi di concentramento tedeschi nei quali Hitler rinchiuse
i suoi oppositori politici. Un testo sorprendente e coinvolgente,
capace di attrarre il lettore per il suo irriverente anticonformismo.

Judith
Malina
Venendo ai nostri giorni, ricordo, di Cristina Valenti, Intervista
con Judith Malina. L’arte, l’anarchia, il Living
Theatre (Milano, Elèuthera, 1995) la lunga
e intensa conversazione fra la studiosa di teatro e una delle
massime icone del teatro rivoluzionario del Novecento. Attraverso
il dialogo fra le due donne, appassionato e ricco di momenti
emozionanti, si ricompone la storia di una delle più
importanti avventure artistiche e intellettuali del Novecento,
quella del Living Theatre, sempre a cavallo fra la provocazione
artistica e il forte impegno sociale e non violento.
Non su, ma di Judith Malina, Love and politics
(Roma, Stampa Alternativa, 1998), un Millelire curato da Cristina
Valenti che raccoglie alcune delle più belle poesie della
fondatrice, con Julian Beck, del mitico Living Theatre, tenacemente
ispirate al progetto di costruzione della Bella Rivoluzione
Anarchica Non Violenta. Sul Living Theatre, da segnalare Quattro
spettacoli del Living Theatre (Lecce, Manni, 2000),
un testo bilingue che raccoglie gli ultimi lavori del regista
e drammaturgo Hanon Reznikov, tra cui Il Metodo Zero
e Anarchia.
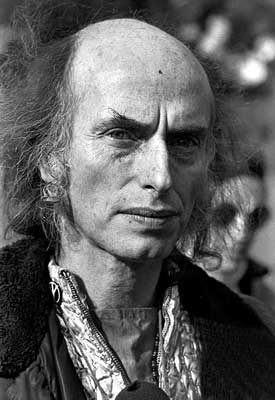 Julian Beck
Julian Beck
Si parla ancora di Living Theatre, ma anche di Gori, Brecht
e Peter Brook, in Maschera e rivoluzione. Visioni
di un teatro di ricerca, a cura di Fernando Mastropasqua
(Pisa, Bfs, 1999), testo che ospita i saggi di vari studiosi
interessati alle numerose esperienze “rivoluzionarie”
espresse in campo teatrale.
 Musica
Musica
e canti
Dal teatro alla musica, quella popolare e militante delle canzoni
di lotta, e quella dei colti e sofisticati cantautori dalla
impronta libertaria. Iniziamo con Il canto anarchico
in Italia nell’ottocento e nel novecento
di Santo Catanuto e Franco Schirone (Milano, Zero in condotta,
2001), frutto della tenace e lunga ricerca condotta dai due
compagni della Federazione Anarchica Milanese, che vede raccolti,
per la prima volta e in modo pressoché completo, tutti
i testi e quasi tutte le partiture delle canzoni, delle strofe,
dei brani musicali della tradizione anarchica e libertaria,
dalle origini ottocentesche fino a oggi. Ogni pezzo è
opportunamente accompagnato da un apparato documentario, mentre
l’introduzione illustra metodi e finalità della
ricerca. Praticamente in sedicesimo, rispetto al precedente,
è il Nuovo canzoniere dei ribelli
di Donato Landini (Livorno, Sempre avanti, 1996), un’antologia
ragionata, anche dal punto di vista musicale, di alcuni dei
testi più famosi della tradizione libertaria.
Nel cuore della bestia. Storie personali nel mondo
della musica bastarda (Milano, Zero in condotta,
1996) è opera di un artista, Stefano Giaccone, e di un
conoscitore della “musica bastarda” senza uguali,
Marco Pandin, ai quali si deve un’intelligente raccolta
dei materiali prodotti dal variegato e affollatissimo universo
delle autoproduzioni, sempre vicino, per tematiche e comportamenti,
a quello libertario.

Fabrizio
De André
Dicevamo dei cantanti autori dalla spiccata sensibilità
libertaria. Su Fabrizio De André segnalo, in questa bibliografia,
solo De André e Napoli. Storia d’amore
e d’anarchia di Federico Vacalebre (Milano,
Sperling & Kupfer, 2002) e Gli occhi della memoria
di Romano Giuffrida (Milano, Elèuthera, 2002) perché,
fra i tanti titoli usciti dopo la sua morte, evidenziano più
di altri l’impronta fortemente libera e libertaria dell’ispirazione
artistica del cantautore. Di Mauro Macario sono i saggi dedicati
a Leo Ferrè, l’arte della rivolta
(Milano, Selene, 2003), un piacevole testo in cui si colgono
l’amore e l’ammirazione per il grande poeta e chansonnier
anarchico che ha composto alcune delle nostre canzoni-poesie
più belle di questi decenni, e Il cantore
dell’immaginario (Milano, Elèuthera
2000), che vede raccolte alcune delle sue opere più significative.
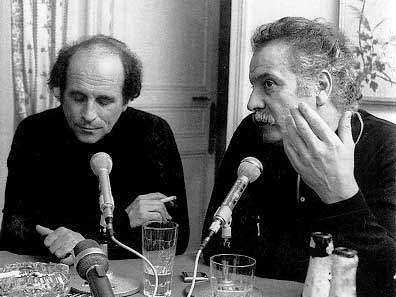
Leo
Ferré (a sinistra) e George Brassens
 Letteratura
Letteratura
Veniamo ora all’ambito letterario, il più frequentato
dagli autori che hanno trovato nelle storie degli anarchici
e dell’anarchia un’evidente fonte d’ispirazione.
Sono parecchi i testi da segnalare, per cui la cosa migliore
è procedere in ordine cronologico.
Iniziamo con Luigi Regoli anarchico
di Angelo Toninelli (Firenze, Shakespeare and Company, 1995),
un romanzo molto bello, ambientato nella Maremma selvaggia e
nell’industrializzata Piombino agli inizi del ’900,
in cui emergono i caratteri degli spiriti ribelli e sognatori
del secolo scorso. Una storia d’amore e di lotta contro
i fascisti che vede impegnato un intero paese, temprato nelle
lotte di fabbrica delle acciaierie piombinesi, giunto all’anarchia
sulle “alate” parole di Pietro Gori, deciso a conservare
la sua anima proletaria e libertaria senza cedere alla violenza
e alla reazione.
Trattando di anarchismo e letteratura, centrale è l’opera
di Paco Ignatio Taibo II, che in Rivoluzionario
di passaggio (Milano, Tropea, 1996) tratteggia
la straordinaria figura di un irriducibile rivoluzionario spagnolo
che, nel Messico degli anni ’20, incarna, con il rifiuto
di normalizzare la propria vita, l’essenza di quello spirito
libero e ribelle caro a tanti compagni di ieri e di oggi.
Restando in Sud America, ricordo Un caffè
molto dolce di Maria Luisa Magagnali (Torino,
Bollati Boringhieri, 1996), che rievoca le vicende di Severino
Di Giovanni, uno dei personaggi più controversi dell’anarchismo
argentino. La sua vita avventurosa, fatta di azioni quasi sempre
ai limiti o fuori della legalità e finita tragicamente,
è anche quella di un anarchico a tutto tondo, che dette
tutto di sé per la causa, vivendo anche un’appassionata
storia d’amore con una giovanissima compagna.
Il francese Michel Ragon è autore de La memoria
dei vinti (Milano, I nostri, 1997), un complesso
romanzo che ripercorre la storia dell’anarchismo, dalla
Banda Bonnot alla guerra di Spagna, da Kronstadt al Sessantotto,
mescolando personaggi reali e figure di fantasia, e costruendo
tanto il ritratto di un’epoca quanto un’intensa
storia sentimentale.
Restiamo in Francia con Il grido del popolo
di Jean Vautrin (Milano, Frassinelli, 2001). Premio Goncourt,
Legion d’Onore, giallista di fama, Vautrin, al suo primo
romanzo tradotto in italiano, ci porta ai tempi della gloriosa
Comune del 1871, con una trama avvincente a mezza via tra le
forti tinte del feuilleton ottocentesco e la denuncia sociale
delle miserie del proletariato insorto.
 Pino Cacucci
Pino Cacucci
Poi ci sono i Ribelli!
di Pino Cacucci (Milano, Feltrinelli, 2001): Sacco e Vanzetti,
Secondari, Marius Jacob, Sabaté e tante altre figure
quasi leggendarie accomunate dall’inesauribile amore per
una vita libera e ribelle.
Tornando in patria, esclameremo, con Toni Iero, Forza,
Italia! 2001-2005 una nazione alla deriva in un mondo in tempesta
(Milano, Zero in condotta, 2002). Un racconto avvincente, composto
nel solco della migliore tradizione della fantapolitica libertaria,
con la prefigurazione delle future scadenze sociali, economiche
e politiche che ci attendono – ma speriamo di no –
nei prossimi anni. Un altro romanzo curioso, a tratti onirico
e surreale, è Zero maggio a Palermo
di Fulvio Abbate (Milano, Baldini & Castoldi, 2003). L’autore
torna alle sue esperienze giovanili, vissute dentro i movimenti
della Palermo sessantottesca, una città attraversata
da pulsioni libertarie e da sette metafisici Salvatori anarchici,
una città magica e affascinante nella quale tutto appare
finalmente possibile.
Il secondo romanzo di ispirazione anarchica di Angelo Toninelli,
scrittore decisamente innamorato dell’anarchia e delle
sue coinvolgenti storie, è Un sogno d’amore
(Pisa, Ets, 2003). In una popolana Firenze ottocentesca si incontra
una folla di personaggi, storici e di fantasia, impegnati nella
costruzione dell’Internazionale e convinti assertori della
necessità di un’organizzazione sociale che crei
le premesse dell’emancipazione. Il racconto delle tribolazioni,
ma anche degli entusiasmi dei primi militanti proletari.
Di tutt’altro tenore, ma non meno avvincente, Itala
scola. I delitti di una scuola azienda (Milano,
Zero in condotta, 2004), un vero e proprio thriller di Dario
Molino, insegnante e militante del sindacalismo di base. Un
racconto dove gli elementi tipici del noir si mescolano, con
feroce ironia, ai problemi pressanti che affondano, giorno dopo
giorno, una scuola sempre meno scuola e sempre più azienda.
Il dolore perfetto (Milano, Mondadori,
2004), che è valso a Ugo Riccarelli il Premio Strega
2004, è un bellissimo romanzo che narra la saga struggente
ed eroica di una famiglia e di un’intera generazione di
anarchici, trascorsa fra la poesia del padule maremmano. Nella
drammaticità di vite sconvolte dalla violenza del potere,
solo la solidarietà fra emarginati riesce a lenire e
a rendere superabili le dolorose difficoltà della vita.
Di Franco Bernini è uscito La prima volta
(Torino, Einaudi, 2005), curioso ma non straordinario romanzo
ambientato nel 1898, nel quale si intrecciano rocambolescamente
le vicende del primo campionato di calcio, quelle dei moti milanesi
soppressi nel sangue da Bava Beccaris e le mene attentatrici
di improbabili anarchici idealisti e di cinici anarchici ancora
più inverosimili.

Gianna Manzini
Saluto anche con piacere la ristampa del Ritratto
in piedi di Gianna Manzini (Pistoia, Libreria
dell’Orso, 2005). Era, infatti, ormai introvabile questo
libro – senz’altro una delle più belle opere
letterarie dedicate a figure anarchiche – nel quale la
famosa scrittrice tratteggia la splendida ed amata figura del
padre, anarchico pistoiese, amico di Gori e Malatesta, che mai
si piegò di fronte alle avversità famigliari e
politiche.
Termino questa “rassegna letteraria” con l’ultimo
nato, Lo zio anarchico di Pier Francesco
Gasparetto (Reggio Emilia, Aliberti, 2005). Ancora una volta
storie di anarchici e attentatori, in trasferta dalla provincia
piemontese a Paterson, New Jersey. A un primo sguardo, questo
libro sembra avere come unico pregio la bella riproduzione in
copertina di un quadro di Costantini.
 I situazionisti
I situazionisti
Termino la sezione culturale con una serie di testi che, pur
non interessando il mondo delle arti in senso stretto, testimoniano
però una corrente intellettuale che affrontò,
in modo originale e felicemente provocatorio, le tematiche legate
alla critica culturale. Intendo parlare del situazionismo.
Partiamo, doverosamente, da L’amara vittoria
del situazionismo. Per una storia critica dell’Internationale
Situationniste 1957-1972, di Gianfranco Marelli
(Pisa, Bfs, 1996), un testo ormai indispensabile per comprendere
quanto vicine, ma anche quanto distanti siano state le strade
percorse, negli stessi anni, da situazionisti e anarchici. In
questo saggio, senza dubbio il più importante in Italia,
Marelli ricostruisce il percorso teorico dei situazionisti che
aveva l’obiettivo di reinventare la rivoluzione e liberare
la vita quotidiana dalla passività alienante della società
dello spettacolo. Sempre di Marelli, L’ultima
Internazionale. I situazionisti oltre l’arte e la politica
(Torino, Bollati Boringhieri, 2000), un altro studio sulla peculiarità
del situazionismo, l’ultima internazionale del secondo
millennio, in bilico fra il recupero agiografico della sua critica
radicale e dei suoi “profeti”, e la capacità
di allestire un habitat per “l’illimitato dispiegamento
delle nuove passioni”. Sullo stesso argomento è
uscito Breve storia dell’Internazionale Situazionista
(Torino, Nautilus, 1999), a cura della Nottingham Psychogeographical
Unit, col corredo di rare immagini fotografiche.
Molto interessante è anche Potlach, Bollettino
dell’Internazionale lettrista 1954-57, che
la piccola e vivace editrice torinese Nautilus, in sintonia
con la sua linea editoriale, ha stampato nel 1999. È
l’unica edizione italiana degli introvabili documenti
di questa Internazionale, il movimento francese d’avanguardia
capostipite della “editoria selvaggia”, che si proponeva
di operare la difficile riunificazione della creazione culturale
d’avanguardia con la critica rivoluzionaria della società.
Per finire, altri tre testi esemplari pubblicati da Nautilus,
Urla in favore di Sade (Torino, 2000),
di Guy Debord, uno dei fondatori e padri nobili del situazionismo;
Avviso agli studenti (Torino, 1996),
dell’altro “mostro sacro” Raul Vaneigem; e
infine La rivoluzione dell’arte moderna e
l’arte moderna della rivoluzione (Torino,
1996), antico e illuminante documento del 1967 proveniente dalla
Sezione inglese dell’Internazionale Situazionista.
 Spagna ’36
Spagna ’36
A conclusione di questa traccia bibliografica gettiamo uno
sguardo oltre le frontiere e occupiamoci dell’anarchismo
degli altri paesi. Naturalmente l’attenzione sarà
concentrata soprattutto sulle due grandi esperienze rivoluzionarie
del Novecento, nelle quali gli anarchici ebbero una parte importantissima:
la libertaria rivoluzione spagnola e la rivoluzione, un po’
meno libertaria, che sfociò nella fondazione della prima
repubblica sovietica.
Per l’affetto che ci lega, partiamo dalla Spagna, seguendo
in questo caso l’ordine cronologico delle pubblicazioni
segnalate.
Zero in condotta ha pubblicato Chi c’era racconta.
La Rivoluzione Libertaria nella Spagna del 1936
(Milano, 1995), le intense testimonianze in presa diretta di
una ventina di militanti spagnoli che dettero vita alla rivoluzione
comunista libertaria. Parole che valgono quanto e più
di una ricostruzione saggistica, ricordi partecipi di un’esperienza
esaltante e, temiamo, irripetibile. Sempre Zero in condotta
ha curato, con altre quattro editrici internazionali, Durruti
1896-1936 (Milano, 1996), una bella edizione fotografica
commentata in cinque lingue, che permette di cogliere, grazie
alla ricca iconografia, tutti i momenti della “eroica”
e avventurosa vita di Durruti, ucciso mentre difendeva, con
i suoi miliziani, le conquiste rivoluzionarie del proletariato
in armi in terra di Spagna. Di Carlos Semprun Maura, Libertad!
Rivoluzione e controrivoluzione in Catalogna (Milano,
Elèuthera, 1996). È la seconda edizione (dopo
quella milanese dell’Antistato del 1976) di questo studio
critico sui problemi interni alle forze rivoluzionarie e al
movimento anarchico, nati dalle difficoltà e dalle contraddizioni
che caratterizzarono i primi mesi della rivoluzione, là
dove prese forma il comunismo libertario della Cnt.
 Buenaventura Durruti
Buenaventura Durruti
A seguire, di Abel Paz, Spagna 1936,
un anarchico nella rivoluzione (Manduria, Lacaita,
1998). In questa autobiografia Abel Paz (nom de plume
di Diego Camacho), giovanissimo combattente rivoluzionario sulle
barricate di Barcellona, ripercorre con grande partecipazione
le vicende esaltanti e le tragedie immani che segnarono quella
che può essere considerata l’esperienza senza ritorno
del ventesimo secolo. Sempre di Abel Paz, Durruti
e la rivoluzione spagnola (Pisa-Ragusa-Milano,
Bfs, Fiaccola, Zero in condotta, 1999-2000, 2 voll.). Da questa
biografia, frutto di una documentazione imponente e scritta
con l’immediatezza del testimone, emerge la figura di
uno dei personaggi non solo più importanti e significativi,
ma anche più amati dell’anarchismo internazionale.
Si parla di anarchici, di quelli reclusi ma ancora vitali nelle
carceri franchiste, nel romanzo di Manuel Rivas, Il
lapis del falegname (Milano, Feltrinelli, 2000).
Una storia struggente, una delle tante che in questi anni hanno
ispirato i narratori spagnoli alla scoperta delle vergogne di
un passato volutamente nascosto dai miserabili aguzzini di un
popolo straordinario.
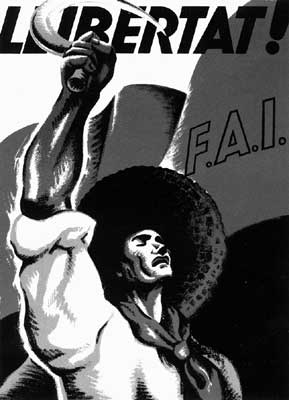
Manifesto
degli anarchici catalani, realizzato da Carles Fontseré
(1936)
Ancora di Abel Paz, Le 30 ore di
Barcellona. Immagini della rivoluzione (Carrara,
Cooperativa Tipolitografica, 2002). Impreziosito dalle famose
tavole disegnate da Sim durante le giornate di luglio, e finalmente
pubblicate in Italia, il libro si concentra sulla descrizione
delle prime, determinanti ore della rivoluzione spagnola, quando,
grazie alla resistenza operaia al sollevamento dei militari,
si decisero le strategie e i rapporti di forza che avrebbero
caratterizzato la lotta al franchismo.
Per chi ama i fumetti, segnalo la bella storia a strisce di
Alfonso Font, Negras tormentas e altre storie
(Milano, ReM, 2002), dove il disegnatore spagnolo ricostruisce
vividamente una Barcellona rivoluzionaria e anarcosindacalista,
epicentro di avvincenti avventure.
Apprezzabile la ristampa dell’introvabile Mussolini
alla conquista delle Baleari (Casalvelino, Galzerano,
2002), il famoso testo con il quale Berneri affrontava, nel
fuoco della rivoluzione, le responsabilità del fascismo
italiano a sostegno del sollevamento dei militari felloni guidati
da Franco. Di un altro grande protagonista dell’anarchismo
spagnolo scrive Fulvio Abbate ne Il ministro anarchico
(Milano, Baldini & Castoldi, 2004). Restando a metà
strada fra narrazione romanzata e ricostruzione storica, lo
scrittore palermitano abbozza la biografia di uno dei più
affascinanti e controversi protagonisti della rivoluzione, Juan
García Oliver, ministro anarchico della giustizia, già
idolo della Barcellona proletaria, poi esule in Nord Europa
e in Messico dove continuerà a vivere nel ricordo della
travolgente esperienza del 1936.
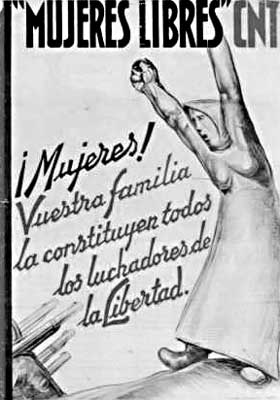
Manifesto
dell’organizzazione femminile anarchica Mujeres Libres,
realizzato da José Maria Gallo (1936)
Di un’altra esperienza eccezionale, fra
le tante vissute dal movimento iberico, scrive Martha Ackelsberg
nel suo Mujeres Libres. L’attualità
della lotta delle donne anarchiche nella rivoluzione spagnola
(Milano, Zero in condotta, 2005), ricostruendo, con un accurato
studio delle fonti, le gloriose vicende di un’organizzazione
tutta femminile, operaia, emancipatrice e impegnata nel progresso
della condizione della donna, tanto più importante in
Spagna dove gli atavici retaggi feudali e maschilisti erano
ancora dominanti.
Seguono due testi dedicati agli anni successivi al 1936-39:
gli anni della feroce repressione franchista e degli ultimi,
tragici tentativi di anarchici irriducibili, decisi a combattere
il fascismo armi alla mano. Di Massimiliano Ilari è uscito
La giustizia di Franco. La repressione franchista
ed il movimento libertario spagnolo 1939-1951
(Chieti, Csl Di Sciullo, 2005), che descrive la resistenza “sconosciuta”
degli epigoni dell’imponente movimento anarchico spagnolo
e la barbara repressione con la quale il regime colpì
il suo nemico più irriducibile. L’autore, giovane
militante della Fai, propone anche un’inedita cronologia
comparata di grande interesse.
La Fiaccola di Ragusa, sempre nel 2005, riedita il famoso Sabatè,
la guerriglia urbana in Spagna (1945-1960), di
Antonio Tellez. Il 1939 non segna la fine della resistenza anarchica
alla dittatura: già dai primi mesi del nuovo regime guerriglieri
anarchici cercano di mantenere viva la lotta. Quanto mai opportuna
è dunque la ristampa di questo drammatico testo, che
narra la tragica storia di una generazione di giovani militanti
caduti nella lotta contro il carnicero falangista.
Chiudo questo lungo capitolo con una curiosità di autore
anonimo, La cuoca di Durruti. La cucina spagnola
al tempo della “guerra civile”. Ricette e ricordi
(Roma, Derive Approdi, 2002). Con la prefazione di Luigi Veronelli,
questo originale e avvincente frammento di diario, un po’
narrazione e un po’ cronaca storica, mescola i ricordi
rivoluzionari della giovane miliziana Nadine, ricchi di personaggi
e grandi avvenimenti, con le sue allettanti ricette culinarie
realizzate, è il caso di dirlo, nel fuoco di uno dei
più grandi e gloriosi incendi del Novecento.
 Russia
Russia
e Ucraina
Veniamo ora all’altra grande rivoluzione che segnò
l’inizio del secolo breve, quella “realizzata”
e non sconfitta dalle forze della reazione e del capitalismo,
la rivoluzione russa, ricca di contraddizioni e di duri insegnamenti
per gli entusiasti rivoluzionari, bolscevichi, anarchici, menscevichi,
che vi presero parte.
È soprattutto della soffocante burocrazia e della repressione
che ne seguì e che affossò il sogno della palingenesi
sociale, che trattano i libri che citerò.
 Nestor Makhno
Nestor Makhno
Piotr Arscinov, ucraino, fu uno dei tanti anarchici
che combatterono le truppe bianche della reazione, con in cuore
il sogno di una nuova società di liberi ed uguali. Nella
sua ormai classica Storia del movimento makhnovista,
ristampata da Samizdat (Pescara, 1999), ma uscita a caldo nella
Parigi del 1924, ci sono tutti gli elementi per capire la capitale
importanza che ebbe l’anarchismo nei primi anni, soprattutto
nella fertile Ucraina controllata dalle truppe dell’anarchico
Makhno, e la degenerazione che i semi dell’autoritarismo
bolscevico avrebbero innestato nella nuova società.
Anche l’anarcosindacalista Gregori P. Maximoff, con il
suo Gli anarcosindacalisti nella rivoluzione russa
(Pescara, Samizdat, 1997), porta un prezioso contributo alla
ricostruzione del ruolo, importante e misconosciuto, che l’anarchismo
ebbe nei processi rivoluzionari della Russia.
Ed è proprio la specificità dell’agire anarchico,
inconciliabile con il centralismo burocratico marxista leninista,
che fa capire perché i libertari furono tra i primi a
cadere sotto i colpi della spietata repressione di Lenin e Stalin.
Un altro lavoro sui contrastati rapporti all’interno delle
forze rivoluzionarie è Marxismo e anarchismo
nella rivoluzione russa, di Arthur Lehning, nella
nuova edizione di Samizdat (Pescara, 1999). Si tratta di uno
dei grandi classici della letteratura anarchica, nel quale lo
studioso olandese affonda le mani nella tragica diatriba che
vide opporsi, da un lato, il pragmatismo totalitario di Lenin
e, dall’altro, l’afflato libertario e rivoluzionario
che gli anarchici russi, nonostante la repressione, contrapposero
alla degenerazione burocratica e alla dittatura del proletariato.
Infine, molto interessante per la prospettiva da cui muove,
è il libro di Santi Fedele, Una breve illusione.
Gli anarchici italiani e la Russia sovietica 1917-1939
(Milano, Angeli, 1996). Come si sa, le sirene della rivoluzione
russa cantarono a lungo fra i movimenti sovversivi europei,
e anche gli anarchici non furono sordi. Questo documentato e
illuminante saggio ricostruisce il progressivo alienarsi delle
simpatie che i libertari italiani avevano manifestato, se non
per i bolscevichi, certamente per la loro rivoluzione.
Una breve illusione, appunto, presto sommersa dalla consapevolezza
con cui si colsero gli aspetti degenerativi della rivoluzione
burocratica e della dittatura proletaria.
 Altrove
Altrove
nel mondo
Esaurite le due grandi esperienze rivoluzionarie, prendiamo
ora in considerazione i non molti libri dedicati ad altri paesi.
Restando in Europa, un bel testo che tratta di argomenti poco
conosciuti è quello di Martine Lina Riesenfeld e altri
autori, Piegarsi vuol dire mentire. La resistenza
libertaria al nazismo nella Ruhr e in Renania (1933-1945)
(Milano, Zero in condotta, 2005), che viene a smentire il consolidato
luogo comune sulla mancata resistenza del proletariato tedesco
all’avvento del nazismo, dimostrando come, fra le fila
del movimento sindacalista libertario, l’opposizione alla
barbarie hitleriana non venne mai meno.
Sulla ex Jugoslavia e i drammi che l’hanno dilaniata negli
anni Novanta, ricordo l’opuscolo Jugoslavia
una guerra per il potere (Livorno, Sempre Avanti,
1996), nel quale Claudio Venza mostra con chiarezza le cause
e gli effetti di una delle maggiori tragedie della fine del
secondo millennio: la guerra fratricida fra i popoli slavi condotta
in nome di diversità etniche e religiose, evocate cinicamente
per occultare la sete di potere delle varie cricche post-titoiste.

Marina
Padovese
Estremamente interessante, anche per la particolare prospettiva
di analisi, Donne contro la guerra. Interventi e
testimonianze dalla ex Jugoslavia, curato dalla
non dimenticata Marina Padovese e da Salvo Vaccaro (Palermo,
La Zisa, 1996). Pier Francesco Zarcone è autore di Portogallo
anarchico e ribelle (Pescara, Samizdat, 2004),
che ripercorre l’esperienza dell’anarchismo portoghese,
senza dubbio meno significativa di quella dei cugini spagnoli,
ma non per questo priva di episodi e figure interessanti.
Rimaniamo in Europa, per parlare di quei cittadini del mondo
che furono gli ebrei fino alla nascita dello Stato di Israele,
e segnaliamo l’interessante Nati altrove.
Il movimento anarchico ebraico tra Mosca e New York di
Furio Biagini (Pisa, Bfs, 1998), che ricostruisce la storia
di un movimento tanto importante quanto poco conosciuto, quello
degli ebrei di lingua yiddish che partirono dai villaggi della
Russia per sfuggire ai pogrom, trasportando in Inghilterra e
negli Stati Uniti le loro esperienze comunaliste e autogestionarie,
nelle quali il tradizionale messianismo era sostituito dall’utopismo
rivoluzionario.
Sempre sull’importanza della presenza ebraica nell’anarchismo
internazionale, Amedeo Bertolo ha curato L’anarchico
e l’ebreo. Storia di un incontro (Milano,
Elèuthera, 2001), gli atti del convegno tenutosi a Venezia
nel maggio 2000, nel corso del quale gli epigoni di questo movimento
senza frontiere hanno confrontato, forse per la prima volta,
le loro eccezionali esperienze.
Cambiando continente, sbarchiamo nelle due Americhe; nella prima,
che pare destinata a essere a lungo l’epicentro politico-economico
e sbirresco del mondo, e nella seconda che ancora manifesta,
con i colori degli indios messicani, la voglia di un cambiamento
definitivo nei rapporti che regolano la vita dei popoli.
Sugli Stati Uniti e il loro ruolo negli equilibri internazionali,
si è scritto e si continua a scrivere con dovizia, e
spesso gli occhiali delle superstiti ideologie impediscono di
cogliere con esattezza le dinamiche in atto. Non è il
caso del libro di Stefano Capello, Oltre il giardino.
Guerra infinita ed egemonia americana (Milano,
Zero in condotta, 2003) nel quale l’autore, con un’analisi
dal taglio decisamente libertario e scevro da condizionamenti,
analizza le tendenze in atto nella geopolitica mondiale, evitando
di cadere nelle trappole della propaganda e mettendo in risalto
le oggettive convergenze fra i poteri internazionali in conflitto,
per fare sì che il dominio nordamericano sull’economia
non venga minimamente messo in discussione.
Passando la frontiera di El Paso, sbarchiamo in Messico, dove
la comunità chiapaneca, con la sua pratica antimperialista,
continua a destare l’interesse degli spiriti liberi in
tutto il mondo.
Come primo approccio, non si può prescindere dal prezioso
Documenti e comunicati del Chiapas insorto. 1 gennaio
1994-29 settembre 1995 (Pisa, Bfs, 1996-1997,
2 voll.), che raccoglie i documenti dell’Ejercito Zapatista
de Liberacion Nacional. Uno strumento indispensabile, anche
per la mole documentaria, per cogliere di prima mano la ricchezza
teorica e la imprevedibile tattica sovversiva degli indios del
Chiapas. Sempre sul Chiapas, ma anche su altre insorgenze indie,
due libri scritti da uno dei maggiori esperti del continente
latinoamericano, il giornalista uruguayano Raul Zibechi. Il
primo, Il paradosso zapatista. La guerriglia antimilitarista
in Chiapas (Milano, Elèuthera, 1998), dove
la peculiarità libertaria del movimento zapatista si
mostra in tutta la sua inimitabile originalità, e il
secondo, Zapatisti e sem terra. Movimenti sociali
ed insorgenza indigena (Milano, Zero in condotta,
2001), in cui si afferma che la cultura india, la cultura degli
oppressi, può emergere come strumento di riscatto e di
liberazione per chi non è più rassegnato ad essere
l’ultimo degli ultimi.
Infine, di Jerome Baschet, La scintilla zapatista.
Insurrezione india e resistenza planetaria (Milano,
Elèuthera, 2003), una storia e una cronologia dello zapatismo
che, con chiarezza e senza demagogia, spazza via il fuorviante
folclore “militante” che avvolge l’Ezln. Venendo
a Cuba, un altro dei nodi politici e sociali di questi anni,
segnaliamo Cuba libertaria. Storia dell’anarchismo
cubano (Milano, Zero in condotta, 2003), di Frank
Fernandez, militante storico e redattore della rivista «Guangara
Libertaria», edita dal movimento libertario cubano in
esilio.
Un movimento che, soprattutto negli anni Venti e Trenta ma anche
in seguito, ha vissuto momenti di grande splendore e che ha
visto i suoi militanti dapprima combattere al fianco di Castro
e Guevara contro la dittatura di Batista, poi prendere la via
dell’esilio per continuare a lottare per la libertà.
Termino questo lungo viaggio nell’editoria libertaria
sbarcando in Africa, nell’auspicio che questa ultima segnalazione
sia presagio di nuove avventure anarchiche in terre ancora inesplorate
dagli eredi di Bakunin e Malatesta. Merito dunque alla milanese
Zero in condotta per aver pubblicato, nel 2002, Africa
ribelle, Società senza stato. Le prospettive libertarie,
di Sam Mbah e I. E. Igariwey, militanti della Awareness League
nigeriana aderente all’Ait, che illustrano gli sconosciuti
e sorprendenti elementi libertari e comunalisti presenti nelle
società tradizionali africane, ancora vitali nonostante
gli effetti del colonialismo, gli esperimenti dei socialismi
di stato, le drammatiche conseguenze delle lotte di liberazione
nazionale e dei conflitti tribali.

Questo
dossier
esce come supplemento del n. 311 (ottobre 2005) della rivista
mensile anarchica “A”; direttrice responsabile:
Fausta Bizzozzero; registrazione al tribunale di Milano n.72
in data 24.2.1971; stampa e legatoria: Officina
Grafica – Milano; progetto grafico e impaginazione:
Erre & Pi – Milano.
“A”
esce regolarmente 9 volte l’anno dal febbraio 1971. Non
esce nei mesi di gennaio, agosto e settembre. È in vendita
per abbonamento, in numerose librerie e presso centri sociali,
circoli anarchici, botteghe, ecc.. Se ne vuoi una copia/saggio,
chiedicela. Siamo alla ricerca di nuovi diffusori.
Per qualsiasi
informazione, compresa la lista completa dei nostri
“prodotti” (dossier “Gli anarchici contro
il fascismo”, letture di Bakunin, Kropotkin, Malatesta
e Proudhon, volantoni della serie anti-globalizzazione, poster
di Malatesta 1921, i nostri dossier, cd e dvd di /su Fabrizio
De André, dossier su Franco Serantini, lista di oltre
cento cd, mc, ecc. della ‘Musica per “A”’,
ecc.) contattaci. Se ci fai avere per fax, email o in segreteria
telefonica il tuo indirizzo completo, ti spediamo a
casa tutte le informazioni necessarie per poter ordinare
quello che vuoi.
Una copia di “A”
costa € 3,00, l’abbonamento annuo
€ 30,00, quello estero € 40,00, l’abbonamento
sostenitore da € 100,00 in su.
Editrice
A
cas. post. 17120, I – 20170 Milano
telefono (+39) 02 28 96 627
fax (+39) 02 28 00 12 71
email arivista@tin.it
sito web arivista.org
conto corrente postale 12 55 22 04
conto corrente bancario n. 107397
presso Banca Popolare Etica, filiale di Milano
(abi 05018, cab. 01600).
Per effettuare un bonifico, le banche richiedono spesso le coordinate:
quelle nazionali (BBAN) sono H 05018 01600 00000107397
e quelle internazionali (IBAN) sono IT10 H050 1801 6000 0000
0107 397.
|

