|
Un po' di chiarezza
(Chi era Matteo Salvatore)
Se l’Italia avesse un minimo di dignità e d’onore
l’alta Puglia non sarebbe il luogo del culto di Padre
Pio ma di Matteo Salvatore.
Matteo Salvatore è stato un miracolo vivente degli ultimi
cinquant’anni, un grande poeta popolare, un cantante sopraffino
di ineguagliabile musicalità, un ottimo chitarrista con
una tecnica autodidatta ma di audace raffinatezza.
Le origini della sua arte affondavano nella leggenda: le biografie
lo vogliono, pressoché bambino, ad accompagnare un violinista
cieco, tale Pizzicoli, portatore di serenate a pagamento. Sembra
esserci una sorta di reincarnazione del mito d’Omero alla
base della cultura profonda di questo aedo del ’900.
La miseria nera che fa compagnia alla quasi totalità
degli abitanti del paesino d’Apricena (in provincia di
Foggia, dove Matteo era nato nel 1925) è il basso
continuo che accompagna tutte le sue opere, il motivo che
lo spinge ben presto, come tanti suoi conterranei, a spostarsi
a nord. Roma (ma anche Milano, Torino…tutta la via crucis
del poer crist emigrante) lo troverà a esercitare
il nobile mestiere del posteggio nelle trattorie, dove attira
l’attenzione di alcuni intellettuali.
Sono gli anni che preludono la riscoperta del patrimonio popolare
(quello che avrà la sua eclatante rivelazione nello spettacolo
Bella Ciao del Nuovo Canzoniere, presentato al Festival
dei due mondi di Spoleto nel ’64). Sono anni in cui Ernesto
De Martino, Diego Carpitella e Alan Lomax battono la penisola
nel timore (fondatissimo) che presto la televisione di lascia
o raddoppia fagociti la cultura contadina. Gli spiriti
più sensibili se ne sono già accorti.
Matteo canta nelle trattorie romane le canzoni di Napoli, perché
son quelle conosciute che fanno tintinnare la mancia, ma Giuseppe
De Santis, Calvino gli dicono “Matteo, tu sei pugliese.
Perché non canti le canzoni della tua terra?”.
“Non ne conosco” dice Matteo. “Cercale!”
gli ribattono.
E allora, armato di registratore Matteo va ad Apricena a cercare
tali melodie e, non trovandole, si mette a scriverne lui stesso.
Torna e comincia a cantare queste canzoni spacciandole per repertorio
anonimo.
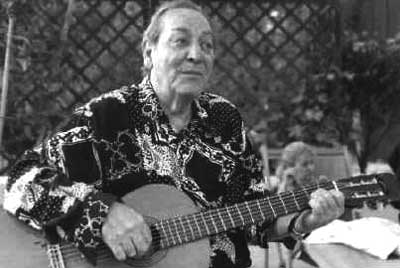
Matteo Salvatore
Comporre cantando
Bisogna riflettere a quest’ambiguità di cui lui
si servì, ma a cui molti vollero credere: Matteo inizia
a scrivere canzoni popolari su commissione, egli di
suo è voce, canto; il termine “scrivere”
sarebbe già del tutto improprio nel suo caso visto che
compone cantando. La percezione che si avrà per anni
di Matteo come portatore, cioè memoria vivente ed esecutore
di materiale popolare, è una falsificazione. Troviamo
il suo repertorio inserito nelle grandi collezioni di Folk anni
’70 (dai Dischi del sole in poi), ma Matteo è
un poeta, un musicista, popolare certo, ma raffinatissimo sia
nei versi che nelle melodie.
Se le prime canzoni che registrerà conterranno stucchevoli
ritornelli di becera comicità, ben presto avviene in
lui una sorta di purificazione: Matteo Salvatore diventa il
medium del dolore secolare di un popolo, la sua opera assume
carattere di grande affresco. Non vi è riflessione, le
canzoni non “parlano di”, nemmeno, per intenderci,
attraverso l’umanissimo filtro dell’immedesimazione
deandreiana; sono proprio i personaggi che, senza presentarsi,
si esprimono per voce di Matteo, di modo che l’esperienza
della miseria faccia da sfondo a un discorso che ha le parole
della vita di tutti i giorni. Nella canzone Lu furastiero
non viene raccontata in modo esplicito la tragedia degli stagionali:
uomini che vagavano a piedi per i paesi del Gargano e del Tavoliere,
prestandosi alla massacrante raccolta dei pomodori, riposando
poche ore a terra sull’aia, guardati in cagnesco dai lavoratori
del posto, i cui salari da fame venivano ulteriormente ribassati
per l’enorme offerta di braccia; nella canzone tutto ciò
è un non detto. Nient’altro che l’impressionistica
descrizione di un notturno in cui il forestiero, stremato, dorme:
Lu furastiero dorme
stanotte sull’aia
Dorme sull’aia alla frescura
E pe cuperta la raccanella
E pe cuscino la sacchettola
La dolcezza struggente della melodia, la nettezza diamantina
dei versi fa di questo, come di quasi tutti i canti di Matteo
Salvatore, una specie di Lied dialettale, un concentrato
inestimabile di concisione e follia.
Le parole di queste canzoni non potevano, come abbiamo detto,
essere scritte perchè Matteo non sapeva scrivere (se
non con estrema difficoltà e già in età
avanzata), dunque son canzoni che nascono senza mediazione letteraria,
dal e per il canto. Questo, si sa, è
un tratto della musica popolare o più in generale della
cultura orale, ma la caratteristica specifica di Matteo sta
nella misura, nel raccoglimento, nel controllo; l’arte
tutta di Matteo Salvatore poggia su un carattere di forte astrazione,
cosa tanto più rara nella tradizione meridionale o mediterranea.
Le sue canzoni, da questo punto di vista, potrebbero essere
accostate a certi canti del De André degli ultimi dischi
(quello di da me riva, o di ho visto nina volare)
e, un po’ più logicamente, le sue melodie accostate
a certe melodie belliniane o para-belliniane (certamente Matteo
conosceva Fenesta ca lucive).
Un grande lirico
Matteo Salvatore possedeva e usava una vocalità particolarissima,
in grado di passaggi vorticosi dai toni gravi al falsetto attraverso
reminiscenze, si direbbe, arabe. Ne Lu pecurere (Lu
pecurere pe li murge vaje / a pasculà le pecore)
la voce si avvita in un melisma che fa pensare alla leggendaria
nota blu. È sinceramente impressionante e distante anni
luce dal vigore un po’ greve dei pur grandissimi cantori
popolari del sud (Rosa Balistreri, Cicciu Busacca). Per dirlo
in una parola Matteo Salvatore non è un cantastorie,
egli è un grande lirico.
Ecco, non vorrei fosse un’ennesima forzatura, ma a me
piace pensare Matteo Salvatore come un bluesman leggendario,
un Blind Lemmon Jefferson pugliese. Anche biograficamente: la
maggior parte dei bluesman erano personaggi violenti e incontrollabili;
la carriera di Matteo fu precocemente spezzata dagli anni passati
in carcere in seguito all’assassinio della sua compagna
Adriana Doriani nel 1973.
Il silenzio che negli ultimi anni si fa intorno a questa vicenda
è rivelatore di un atteggiamento moralistico e falsificante
tipico dell’Italia, dove si tiene il parente strambo chiuso
in cantina, anche se il parente è Van Gogh (o Ligabue),
dove c’è sempre stata una particolare difficoltà
nel confronto fra arte popolare e intellighenzia, dove si può
accettare un cantore popolare come una curiosità antropologica,
sociologica, dove si considera sempre la sua opera una sorta
di materia grezza a cui attingere, ma dove si fa fatica ad ammettere
che l’arte conosce strade che a volte passano lontanissime
non solo dalle accademie, ma anche semplicemente dalle scuole
elementari o dalle nostre vite “rispettabili”.
L’America in questo senso è stato un porto più
franco in cui nessuno si stupisce del rapporto strettissimo
fra le figure leggendarie del Blues (Leadbelly, Robert Johnson)
e i cantautori moderni (Dylan, Springsteen).
Il 27 agosto di questo 2005 Matteo Salvatore è morto.
Per quanto acciaccato ha voluto cantare fino all’ultimo:
il 29 luglio scorso, a Loano, Enrico Deregibus e John Vignola
gli avevano conferito un premio nell’ambito del festival
della musica popolare, quella è stata la sua ultima esibizione.
Prima di questa il Club Tenco, Otello Profazio, Eugenio Bennato,
Daniele Sepe, Teresa De Sio, Vinicio Capossela e qualche altro
avevano fatto il possibile per alleviare a questo maestro la
durezza di una vecchiaia povera.
È però mancata un’attenzione delle istituzioni
culturali (l’unico documentario sulla sua vita è
di produzione francese), mancano pubblicazioni serie su di lui,
a parte un recente racconto/autobiografia della benemerita Stampa
Alternativa, curata dall’ancor più benemerito Angelo
Cavallo (che lo ha accudito come un fratello fino all’ultimo
respiro); manca tuttora (vergogna!) una ristampa in CD della
gran parte dei suoi dischi.
Noi restiamo con il rimpianto di non aver parlato abbastanza
e correttamente di questo meraviglioso artista.
Io resto con il piccolo personale rimpianto di non aver fatto
prima l’articolo su di lui, e sì che me l’ero
ripromesso (e in parte l’avevo già scritto) dall’alba
di questa rubrica. Invece, come nella peggiore tradizione, che
vuole veder celebrati i grandi artisti in occasione o a partire
dalla loro scomparsa, eccomi a versare le lacrime tipografiche
del coccodrillo medio.
Ma aldilà di ogni considerazione di carattere sociale,
morale o personale, l’occasione è buona per cominciare
a fare un po’ di chiarezza sul suo lascito. Matteo è
stato un grandissimo poeta, portatore e rielaboratore di una
cultura altra, che, nonostante i tentativi di sotterramento
della nostra società globalizzata, giunge ancora a scuoterci
dalla notte di Orfeo.
 Alessio Lega
Alessio Lega
alessio.lega@fastwebnet.it
|

