|  Oggi
che il qualunquismo è un’arte Oggi
che il qualunquismo è un’arte
Luca Bassanese è un cantautore vicentino, giovane
sui trent’anni. Ha una voce simpatica che si ascolta
volentieri, ma non è questo il punto. Di bello c’è
che sa scrivere testi molto diretti e semplici senza scivolare
sulla superficialità, anzi ci incastra dentro qua e
là tracce di poesia intima, quasi confessasse attraverso
le canzoni i suoi piccoli desideri e i suoi grandi sogni.
A leggerle senza l’accompagnamento della musica, le
sue parole restano ritte in piedi -a volte con un sasso in
mano altre con addosso il rumore rosso della sete di cambiamento-
a rivendicare una giustizia più giusta, spazi liberi
ed aria pulita.
“Oggi che il qualunquismo è un’arte...”,
questo il titolo del suo lavoro, è un assaggio breve
delle sue capacità: solo due canzoni, però ben
rifinite nell’arrangiamento e nella registrazione.
“Confini” è una bella ballata pacifista
e internazionalista come da troppo tempo non se ne scrivono
più (cantata in due versioni distinte, italiana e spagnola),
a cui contribuisce la sezione fiati degli Ska-J, il che sta
a dire che è impossibile ascoltarla restandosene fermi
come pietre, e che è valsa a Luca il premio Recanati
per la migliore musica.
“Il 20 luglio 2001” racconta in modo visionario
i sanguinosi fatti di Genova, un po’ sulla scia della
traduzione della “Desolation row” di Dylan a suo
tempo addomesticata da De André ai fattacci di casa
nostra. Complice la tromba assassina di King Naat Veliov (quello
de “Il tempo dei gitani” di Emir Kusturica) e
l’intera Kocani Orkestar, si consuma in sei minuti a
passo di 3/4 una tragedia personale, in cui Luca mette in
rima la frustrazione di non poter reagire alla violenza: “Mi
sento inutile, come se non fosse qui quest’aria che
respiro”. Volendo esagerare, ci si potrebbe soffermare
su qualche intrusione leopardiana tra le pieghe del testo.
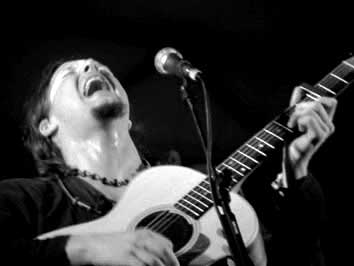
Luca Bassanese
Qualcuno ha scritto, senza barare, che Luca è una
specie di Manu Chao che incontra De André tra i campanili
e i capannoni del nordest: può sembrare un accostamento
sacrilego, ma mi sento onestamente di sottoscriverlo, con
un pizzico di entusiasmo (e Faber si sarebbe certamente messo
a sorridere, accogliendo a braccia aperte Luca in camerino
dopo un suo concerto). Queste canzoni sono una dimostrazione
luminosa che si può ancora scrivere musica da offrire
generosamente in giro senza farcirla di banalità per
renderla appetibile. Gran bel lavoro, e chissà che
ci sia presto un intero album di questo livello. Complimenti,
davvero. E grazie.
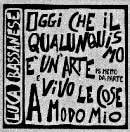 contatti:
www.lucabassanese.it. contatti:
www.lucabassanese.it.
PS: alcune copie del cd di Luca sono disponibili, in offerta
libera, tramite la lista di Musica
per A/Rivista Anarchica.
 “Le
stanze dei giochi” “Le
stanze dei giochi”
I monzesi Daniele Manini e Roberto Barbini sono dentro a
progetti musicali dai primi anni Ottanta, coinvolti nelle
attività di Faded Image e Underground Life (molti quasi-cinquantenni
di oggi, tra cui il sottoscritto, sono i punx e i new-wavers
di allora). Li ritroviamo nel passato recente nel Circo Fantasma
e a gironzolare nell’Apecar dei Mercanti di Liquore.
 Roberto
Barbini e Daniele Manini Roberto
Barbini e Daniele Manini
I nomi dunque non suonano nuovi. Quello che suona nuovo
(…e pure assai strano) è questo loro disco fatto
marcandolo con i cognomi appiccicati insieme e intitolato
“Le stanze dei giochi”, perché contiene
canzoni che esigono un ascolto attento. Del genere: se vi
interessa musica del tipo qualcosa-non-importa-cosa da mettere
sotto i denti mentre fate dell’altro, lasciate stare,
girate alla larga. Se invece vi va di tuffarvi in un viaggio
sonoro piuttosto impegnativo e nodoso, allora prendetevi un’ora
libera e mettetevi seduti tranquilli, e dategli tutta l’attenzione
e la pazienza che potete perché altrimenti questo disco
non funziona. E non funzionano soprattutto i testi, elaboratissimi
e contorti: ogni parola pesa, ha un significato, un suggerimento
preciso.
Il disco, musicalmente parlando, è popolato da presenze
inquietanti e numerosi fantasmi ispiratori, tanto da sembrare
un viaggio privato italiano di Tom Waits e David Thomas finiti
a cucinarsi una pasta e bere vino e grappa di contrabbando
a casa di Vinicio Capossela. Ma qui non c’entrano né
Tom né David né Vinicio, perché si va
ben oltre. Forza ora. Liberate la mente, e pigiate play.
- Si parte con “Ecosentimento”, storia spigolosa
di Mario e Maria che fanno l’amore presso la discarica
abusiva o lo svincolo della tangenziale o dove capita, portando
a loro modo un po’ di verde disperato tra l’immondizia
e l’asfalto, giocata su ammiccamenti e sinuosità,
la fisarmonica soffocante e la chitarra desertica annodate
strette.
Da qui alla fine è un percorso sghembo lungo un’ora
fatto di disagio metropolitano e stati mentali/sonici allucinati,
il suono ultracurato e gli arrangiamenti ricchissimi di incastri,
sorprese e particolari.
- “Donna ideale” racconta di un amore andato
a male che manda luce di lampadina economica, tratteggiato
da un basso elettrico distorto e cattivo come un cane trattenuto
a fatica al guinzaglio dell’arrangiamento.
- “Riti domestici” è una foto senza futuro,
ritagli di spazzatura televisiva ricomposti in forma di tango
strappabudella a raccontare della vita obbligatoriamente felice
della famiglia nucleare condannata all’ergastolo tra
le quattro mura di casa.
- “I vicini” è la mostra delle atrocità
delle ossessioni condominiali, porte chiuse a chiave per paura
del mondo di fuori, segreti sepolti sotto la carta da parati
e il foglio di nylon appoggiato a conservare il divano buono,
parole sussurrate perché non scavalchino le pareti
sottili.
- “Fido destriero” è l’inno alle
quattro quote spinte a benzina e suona del suono della polvere
petrolifera del deserto texano a metà tra Howe Gelb
e i Cardigans…
E il viaggio allucinato dei due continua tra mazurche sporche
di periferia e cori femminili così improbabili da suonare
malati, piccole melodie da osteria e macchine cromate parlanti,
rate da pagare e rassegnazione infinita. Una specie di circo
sinistro dove pian piano noi che ascoltiamo scopriamo di assomigliare
inesorabilmente agli animali/mostri in gabbia, scimmie, tigri,
topi, cani.
Daniele Manini me lo immagino come il padrone del circo o
meglio come il truce capo dei domatori, altissimo irraggiungibile
e sguardo di fuoco, divisa nera e bottoni e alamari d’oro
su cui si riflette tagliente la luce dei riflettori. Cappello
a cilindro e baffi impomatati, avvicina un megafono alla bocca
e fa prendere alla sua voce colori di perversione e disgusto,
trasformandola in un gelato amaro variegato di cattiveria
e sguaiatezza.

La fisarmonica di Roberto Barbini è assieme ricamo
cangiante e rumore di fondo dell’intero disco: si arrampica
sulle pareti di ogni canzone come un ragno in fuga, trasformandosi
ora in voce familiare altre in brivido di spettro.
È un disco che ha un coltello in mano, e che continua
a colpire proprio dove fa più male, perché ci
ha sorpreso nudi all’angolo del letto con tutte le nostre
bugie e scuse sparse per terra, inservibili. Un disco da cui
difficilmente si esce rappacificati, e che continua a far
compagnia di notte -a pezzi- nella colonna sonora vischiosa
che hanno i sogni che non si raccontano al mattino.
contatti: www.putiferio.it.
PS: alcune copie del cd di Manini & Barbieri sono disponibili,
in offerta libera, tramite la lista di Musica
per A/Rivista Anarchica.
 John
Loder John
Loder
Due parole – infine – per ricordare John Loder
(1946-2005), che se n’è andato lo scorso agosto
dopo una lunga e terribile malattia.
L’ho incontrato a Londra all’alba degli anni Ottanta,
proprio una delle primissime volte in cui sono andato a trovare
i Crass alla loro casa comune (erano stati proprio lui e Scott
Piering di Rough Trade a telefonare a Dial House annunciando
la mia visita): Penny Rimbaud e compagni avevano messo in
piedi la loro attività appoggiandosi al suo piccolo
studio di registrazione e dato vita alla loro etichetta discografica
con il suo contributo determinante, così che John era
considerato a tutti gli effetti come uno del gruppo.
L’intera attività della Crass Records è
passata attraverso i Southern Studios di John Loder, che offriva
impeccabile assistenza tecnica e creativa e consigli utili
oltre che registrazioni di elevata qualità ad un prezzo
accessibile.
“La musica era pessima e i soldi erano pochi, ma ci
si divertiva” – così lo ricorda Penny dalle
pagine del Guardian. Nel giro di un paio d’anni, il
piccolo studio casalingo col registratore a quattro tracce
dove venne registrato il debutto dei Crass si trasformò
in una sala attrezzatissima sempre fervida di lavoro che attirò,
oltre che musicisti in numero sempre maggiore, anche il Signor
Padrone, dal quale John seppe tenersi sempre a distanza di
sicurezza propugnando un’assoluta e incompromissoria
indipendenza.
Grazie a John abbiamo potuto ascoltare buona parte del canto
anarchico dell’Inghilterra thatcheriana, da Crass a
Conflict a Flux a Poison Girls, nonché l’espressione
artistica di Bjork, Chumbawamba, Fugazi, Jesus and Mary Chain
e cento altri musicisti occupati a colorare d’arcobaleno
un mondo che il Signor Padrone vorrebbe invece grigio e silenzioso,
oppure frastornato dal rumore delle bombe.
 Marco Pandin
Marco Pandin
stella_nera@tin.it
|

