|
Si può ben dire che il ruolo più incisivo e rilevante della
vicenda libertaria di Emma Goldman sia racchiuso tra due date
cruente che precedono e seguono il suo ingresso e la sua espulsione
dagli Stati Uniti: l'11 novembre I887 e il 23 agosto 1927. Nel
1887, un anno dopo che la Goldmann si era rifugiata in America
(1886) per sfuggire ai progroms del governo zarista, vengono
condannati a morte, a Chicago, mediante impiccagione, gli anarchici
Spies, Parsons, Lingg, Fischer ed Engel, accusati di aver ispirato
e alimentato le violenze che si erano verificate per l'ottenimento
delle otto ore lavorative. Li si ricorderà sempre come "i martiri
di Chicago".
Il 23 agosto 1927, nel carcere di Charleston (Massachusetts)
vengono uccisi sulla sedia elettrica, dopo sette anni di reclusione
e di processi, Sacco e Vanzetti, immigrati italiani, per un
omicidio mai commesso. La Goldman era stata espulsa, insieme
al suo compagno e a qualche centinaio di "sovversivi", nel 1919,
un anno dopo l'arresto di Sacco e Vanzetti. Ma quali erano intanto
la situazione e il peso delle forze politiche più aperte al
rinnovamento sociale? Alla fine del XIX secolo diverse formazioni
progressiste tentarono di aprire qualche varco nella roccaforte
del capitalismo industriale americano. Si trattava di forze
che potremmo definire moderate. Accanto ad esse operavano un
movimento socialista e uno anarchico, il cui scopo era invece
l'eliminazione del sistema capitalista in quanto tale. Oltre
al partito socialista, l'I.W.W. Industriall Workers of the World,
formata da socialisti, marxisti, anarchici ed esponenti del
movimento operaio americano, cerca di organizzare i lavoratori
al di fuori dei partiti e di portare su posizioni radicali i
lavoratori qualificati che ne facevano parte. Con la sua avversione
per l'ordine costituito, la tendenza a far uso del sabotaggio
e i successi tra i lavoratori più emarginati ed umili l'I.W.W.
contribuì largamente ad accendere le lotte operaie di questo
periodo suscitando timori e collera tra le classi medie americane,
tra i dirigenti sindacali conservatori e tra i managers delle
industrie. Essa, pur comprendendo elementi troppo eterogenei
per fondersi in un fronte unitario, non mancò ugualmente di
preoccupare il padronato, cui il successo dei bolscevichi in
Russia e lo spettro della rivoluzione socialista fornivano il
pretesto a una politica di repressio ne continua. Da parte sua,
anche se per ragioni di ordine dottrinario il movimento anarchico
statunitense, di chiara ascendenza liberal radicale e individualistica,
veniva a trovarsi in aperto contrasto con l'anarchismo europeo
degli immigrati che perseguivano una concezione socialista e
collettivista e la violenza come metodo di lotta contro lo sfruttamento,
l'ingiustizia e il sopruso. L'Internazionale Nera aveva subìto
gravi contraccolpi sia da tale situazione, interna all'area
sovversiva, sia dall'atteggiamento sempre più diffidente e ostile
dei lavoratori americani. Resistevano i gruppi anarchici italiano,
russo ed ebraico, e la Union of Russian Workers con i suoi quindicimila
iscritti. Difficile sarebbe stato per chiunque risalire la china
dell'orizzonte cupo e desolato, come recitava una canzone anarchica
dell'epoca, restituendolo alla primavera dei suoi momenti miglliori.
Difficile per chiunque tentasse d'infondergli nuova linfa: non
per "Emma la Rossa", estrosa ed indomabile: le cui gesta Paolo
Salvatores ci fa rivedere con tanta perizia storica e umana
partecipazione nel pregevole libro, Red Emma Un'anarchica
in America, uscito recentemente per la Tip.Le.Co., via S.
Salotti, 37, 29100 Piacenza (tel.0523 / 380102 fax 0523 / 380520).
Salvatores coglie bene la specificità del contributo di Emma
Goldman al movimento anarchico, che si dispiega in una militanza
ininterrotta, segnata da consapevolezza e anticipazioni culturali,
da iniziative editoriali e giornalistiche, (la pubblicazione
per 12 anni consecutivi della sua rivista "Mother Earth", e
di testi antologici teatrali con cui fece conoscere, tra gli
altri, Ibsen al pubblico americano); contraddistinta da campagne
condotte con audacia in molte città degli Stati Uniti contro
lo stato e la chiesa, contro la proprietà ed il militarismo;
dalla diffusione di temi, allora scottanti, sulla questione
femminile, sulla libertà sessuale, sul controllo delle nascite,
su un nuovo sistema educativo libero "da connotati religiosi
e autoritari", ecc. Ma non si completerebbe il profilo della
sua personalità se non si aggiungesse che la Goldman lottò strenuamente
contro la legge che impediva agli anarchici l'ingresso negli
Stati Uniti e contro l'intervento del governo americano nella
prima guerra mondiale. Poche donne rivoluzionarie possono vantare,
come la Goldman, un primato così ricco di presenze e di combattività
anche se attraversato, talvolta, da ripensamenti che riguardavano
più il suo carattere e la prassi da seguire che non l'ldea.
Interessante è notare come Paolo Salvatores non si sia limitato
a consultare l'ampia bibliografia della Goldma e le sue opere,
ma abbia esteso il desiderio di conoscenza alle fonti, ai documenti
di archivio che svelano aspetti non ancora noti della sfera
pubblica e privata della compagna anarchica: alla corrispondenza,
ai testi autografi di conferenze e discorsi, agli articoli;
e che per soddisfarlo s'è recato negli Stati Uniti e in alcuni
paesi d'Europa.
Salvatores ha esaminato all'In-ternational Institute of Social
History, di Amsterdam, il vasto catalogo comprendente, oltre
agli articoli della rivista, anche numerosi manoscritti e discorsi
inediti della Goldman, trascrizioni governative delle sue conferenze
e la corrispondenza privata. Scrive ancora l'autore di lei,
Red Emma: "Buona parte del materiale appartiene alla seconda
metà degli anni Venti e degli anni Trenta, quando la Goldmann,
fuggita dalla rivoluzione russa tradita dai bolscevichi, viveva
in esilio in Europa, risiedendo alternativamente in Francia
e in Gran Bretagna. Nel dicembre 1938 quando l'ingresso delle
truppe di Franco in Barcellona sembrava ormai imminente, a rappresentare
il definitivo crollo della rivoluzione anarchica spagnola, la
Goldman si recò ad Amsterdam, dove si fermò per quattro settimane,
per consegnare personalmente all'International Institute of
Social History, il proprio archivio e quello del suo grande
amico Alexander Berkman, suicidatosi in Francia nel 1936".
Dalla ricostruzione fattane da Salvatores emerge un personaggio
di grande fascino, nel cui processo formativo hanno notevole
influenza le opere di Most, di Bakunin, di Kropotkin (soprattutto);
e, successivamente quelle di Emerson, di Thoreau, di Witman,
e di altri. Insieme col personaggio emerge anche un temperamento:
una volontà che decide in piena autonomia, al di fuori di ogni
schema; che, dopo l'attentato di Berkman, traccerà un solco
tra sé e la prassi della violenza terroristica; che si avvicinerà
alle posizioni dei radicali americani e riconoscerà nell'individualismo
una forza propulsiva capace di accelerare la crescita interiore
attraverso un gradualismo educativo e culturale. In questo senso
anche il teatro, opportunamente selezionato e antologizzato,
darà un valido contributo alla causa stimolando la sensibilità
dei lettori e degli ascoltatori non con i problemi d'ordine
estetico, ma con le istanze sociali.
A tal fine organizza "letture sociali e tour teatrali a Boston
e Chicago".
Dopo l'uccisione di Francisco Ferrer "decise di dar vita, in
suo onore, con un grupppo di compagni, alla Fondazione Francisco
Ferrer, creata per diffondere lo stesso tipo di scuole, denominate
"scuole Moderne". Questa incessante alternanza di presenza attiva
e di rivolta comportava un prezzo carissimo in termini di restrizioni
della libertà personale, di galera e di processi. Un prezzo
che la Goldman pagò sino al giorno della sua espulsione dall'America.
La sua vicenda politica fu sinonimo di battaglia: contro lo
sfruttamento del lavoro, contro l'oscurantismo religioso, contro
le dittature. Battaglia per il riscatto dalla schiavitù della
miseria, della xenofobia, dell'antisemitismo, dei pregiudizi.
Battaglia per la libertà di pensiero e di parola. E quando sarà
costretta a rimpatriare in Russia fuggirà anche dalla sua terra,
per la svolta autoritaria impressa alla rivoluzione socialista,
che aveva acceso in lei e in tanti altri compagni anarchici
sentimenti di solidarietà e di ammirazione. Lo scrittore Paolo
Salvatores ha saputo restituire tutto questo alla nostra memoria,
col suo ottimo libro così documentato e partecipe. In effetti,
con Red Goldman egli evoca dal passato una donna eccezionale,
esempio di fierezza anarchica, pronta a dar voce all'idea legando
il mutamento storico alla necessità dell'azione umana e l'evolversi
degli eventi quotidiani alla volontà soggettiva. Seguendo le
vicende di "Emma la Rossa", ecco che l'anarchismo viene a configurarcisi
come il seguito d'un percorso evolutivo che dalla cocienza individuale
passa alla coscienza collettiva, plasmandola e guidandola verso
una profonda trasformazione della società.
 Emanuele Gagliano
Emanuele Gagliano
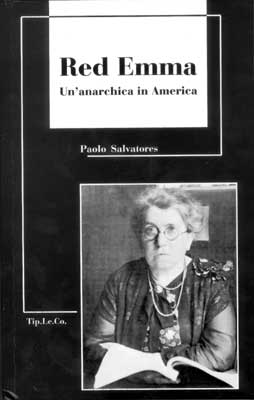
ApARTe
Arte e anarchia, progetto...
ApARTe
arte
e
anarchia
progetto
ricerca
tracce
emozioni
Parte ApARTe e parte bene.
Promuovere questa neonata del movimento anarchico è più facile
del solito.
La segnalazione serve a far conoscere, propagandare, propagare,
vendere.
ApARTe i giochi di parole, scriverò ciò che dico di solito spontaneamente
a voce in questi giorni, a tutti coloro ai quali ne parlo.
Al suo apparire il neonato si scruta frementi, per sapere se
è sano, ben fatto, robusto ecc.
Certo non si butta se così non è, ma se risponde alle aspettative:
si è felici.
Nonostante il prototipo che Fabio Santin e Rino de Michele avevano
fatto girare, nonostante l'elaborazione dell'anteprima realizzata
dal Centro Internazionale della Grafica di Venezia, nonostante
le descrizioni a voce di ciò che doveva essere, quando ho visto
il primo numero sono rimasto stupito: era davvero il numero
1.
Bellissima, sana, forte; ricca oltre ogni mia immaginazione.
Quest'opera che parla d'arte magari per destrutturarla, impossessarsene,
farla propria, e farne di propria, narrarla: si autorappresenta.
Non accenno, come di solito si fa, al contenuto elaborato da
molte teste - lungo elenco che ometto perché i fortunati possessori
potranno leggere, vedere, sentire, toccare, "annusare" direttamente.
Dirò del non-contenitore, dell'oggetto. Creativa creatura, "quad-erno"
solo perché quad-rato (30,8 x 30,8 cm.) reale composizione architettonica
di materiali irregolari.
Ogni parte (senza numerazione di pagine, sostituita da coppie
di lettere - non sempre -, che identificano o rimandano al testo
in un gioco di segna-file) è parte dell'insieme e contiene altro.
Guardi la prima (copertina?) che è il logo della neonata, e
sei spinto a superarla. La seconda contiene una rilettura di
Max Ernst che raffigura l'ampio manipolo dei collavoratori,
e siamo già attratti dall'acetato del quasi editoriale; bandella
attaccata una per una a mano con biadesivo rosso.
Il tatto è stuzzicato dalla diversità dei materali la vista
dalla varietà delle forme e dei colori, l'orecchio da un budget-matrioska
di assoluto valore: un compact prezioso nella sua busta, con
dentro il testo, con dentro una riproduzione, con dentro...
aggiunte di allegati.
Vedere per credere.
Anticipazioni su lavori in corso (porzioni di lavoro) sono stampati
su porzione di pagina. Di contro uno splendido disegno inamputabile,
che deve superare la mezzeria della neonata facendo debordare
la 6(tm)(?) con partenza dalla 21(tm)(?).
Emozione continua.
Foto, immagini, carte, operazioni sulla pagina che producono
arte.
Altri diranno altro, quando la neonata parlerà, ora presento
e descrivo ciò che vedo.
Pagine tagliate, porzioni sottratte, inserti colorati, che connotano
quella pagina rispetto all'altra.
Il centro è in 1/8° ma... anziché produrre doppine (tagliandoli),
resta attaccato per un lembo ad un margine con una giocosa operazione
origamica che nasconde e rimanda, fa intravedere e si disvela.
Poesia, teatro, arte postale, disegno, pittura, cinema, video...
Una fortuna trovarla in edicola, un veloce esaurimento in abbonamento!
È già cult.
I biblionecrofori non dovranno attendere per apprezzarla, è
oggetto d'arte da catturare subito, così fresco da indurre azioni
bibliopedofile.
Il costo sarà alto per tutto ciò? No, vale enormemente di più
di quanto viene chiesto per averla.
Prodotto artigiano, copia su copia, ciascuna è oggetto unico
(solo cinquecento esemplari), comunica arte: è opera d'arte.
Oggetto non-seriale, è questo un valore aggiunto rispetto al
contenuto, da gustare, usare; se troverete una copia da qualche
parte.
Chi si abbona, la riceve in busta (bella anche quella), con
indirizzo scritto a mano.
ApARTe è già parte di noi, c'è sempre stata e deve durare per
vantaggio reciproco.
Ah! il cognome! rivista? quaderno? aperiodico?
Molto di più: comprare per credere.
 Alberto Ciampi
Alberto Ciampi
(pARTe di A)
Per abbonamenti:
Fabio Santin, c/o ApARTe - CP 85 Mestre succ. n°8 - 30171 Mestre.
CCP 12347316: annuo (due opere) Lit. 50.000 Sostenitore il doppio.
Una copia Lit. 30.000

Dietro "Faber"
È stato presentato ufficialmente l' 11 gennaio scorso (primo
anniversario della morte del cantautore) a Milano, nel salone
della Provincia in via Corridoni, il filmato "Faber", dedicato
a Fabrizio De André. Ai due registi abbiamo chiesto il senso
del loro "prodotto". Questo loro scritto appare anche nella
monografia "Signora Libertà, Signorina Anarchia".
Quali sono i percorsi lungo i quali si è sviluppata l'identità
di Fabrizio De André? E questi percorsi, in quali scenari si
sono dipanati? Quali le voci, le emozioni, i sentimenti che,
nel tempo, là si sono sedimentati sino a diventare una cosa
sola con l'essere e il sentire dell'individuo?
Questi gli interrogativi che, per la realizzazione di Faber,
hanno guidato il nostro viaggiare tra la Sardegna dell'Agnata,
la Genova dei "caruggi" e la Milano, metropoli della transizione
postfordista stretta tra le irriducibili contraddizioni delle
vecchie e nuove povertà.
Ciò che ci interessava era scoprire quali "fili" avessero tessuto
l'arazzo della poetica di Fabrizio, quella poetica così forte,
unica e nello stesso tempo eco di idee e di utopie antiche che
nel corso di più di trent'anni avevano contribuito a formare
anche il nostro "sentire" il mondo.
La strada che scegliemmo fu quella di "non cercare" ma di lasciare
che gli scenari, i luoghi, le voci, le emozioni, i sentimenti
su cui ci eravamo interrogati, trovassero noi, in modo da far
sì che fossero loro a guidarci lungo le "rotte" della poesia
di Fabrizio De André.
Volevamo, cioè, che la sua poesia si materializzasse davanti
a noi nelle forme originarie che l'avevano generata, volevamo
riconoscerla nei colori e nei rumori di un luogo, nelle parole
dei suoi amici, nei visi della serenità e in quelli della disperazione
che affollano l'eterna commedia umana.
Sapevamo che quello era il solo modo per ritrovare le parole
di Fabrizio in tutta la loro ricchezza semantica.
E, infatti, così è stato.
Dal fattore Filippo a don Vico agli altri amici di Tempio Pausania,
di Genova e di Milano; dai luoghi del mirto e dei boschi impenetrabili;
dai vicoli dell'amore mercenario come dalle strade "vestite
a festa" dell'esibizionismo benpensante; dalle "terre di nessuno"
extra-metropolitane abitate da rom e dai "nuovi miserabili"
che la nostra civiltà del profitto produce, emergono, a volte
direttamente, altre volte quasi in filigrana, i versi delle
canzoni di Fabrizio.
Inevitabilmente, da questo humus creativo, emerge anche la grande
arte del poeta che di quegli scenari e di quella umanità ha
cantato, muovendo ora le corde della pietas ora quelle dello
sberleffo e dell'indignazione.
Perché abbiamo "girato" Faber? Per un omaggio, per un atto di
amore verso chi aveva con noi un inestinguibile credito di poesia
ma anche di umanità, di affetto verso gli umili e i reietti,
verso quelli cioè che avevano popolato gli orizzonti del nostro
agire e che lui, Fabrizio, era riuscito a dargli dignità e storia.
Realizzando Faber, abbiamo avuto la conferma - se mai ce ne
fosse stato bisogno - che in Fabrizio non c'era manierismo,
non c'era la "furbizia" di chi ha cantato l'utopia - pronto
a rinnegarla il giorno dopo qualora i venti cambiassero - solo
per guadagnarsi un "posto" nelle hit-parade del consumismo usa
e getta.
Per Fabrizio la parola "impegnava", si faceva "gesto" e lo coinvolgeva,
coinvolgendo, nel contempo, coloro che lo ascoltavano.
Ecco perché più sopra abbiamo scritto "inevitabilmente emerge":
la "varia" umanità cantata da De André è così vera, così reale,
perché Fabrizio è stato lì, con quell'umanità, con la quale
si è confrontato, scontrato, ha riso e sofferto, in ogni caso
si è sempre "messo in gioco" in prima persona non demandando
a pindariche quanto fantasiose elucubrazioni (così comuni nella
spesso miserina quanto pedante prosopopea del ceto intellettuale),
il senso ultimo del proprio impegno.
Missione compiuta, dunque: il nostro viaggiare ci ha confermato
le certezze che in fondo già avevamo; ma non solo: il nostro
viaggiare "attorno" a Fabrizio, ci ha insegnato alcune "regole",
alcuni modi di essere che hanno nel rigore, nella onestà, nella
responsabilità il loro cardine.
Ma questa è una storia nostra, personale, intima che poco può
interessare a chi ci legge. D'altra parte, a chi le vuole imparare,
queste stesse cose le insegna tutta l'opera di Fabrizio De André.
 Bruno Bigoni e Romano Giuffrida
Bruno Bigoni e Romano Giuffrida
Non stare al
gioco
Ho letto questo racconto Il cristallo di quarzo di Marco
Sommariva (Sicilia Punto L edizioni, 63 pagine, 6000 lire) in
una serata, tutto d'un fiato. È una di quelle storie dove non
si sa perché, quale meccanismo interviene, gli eventi si susseguono
senza lasciare possibilità di scelta se non viverli lasciandosi
trasportare con stupore. Ciò accade al protagonista, voce di
sé narrante, mai nominato per nome, quindi io, tu o chiunque
altro, che si trova suo malgrado coinvolto in vicende ben più
grosse di lui; ha la possibilità addirittura di chiarire il
mistero dell'aereo di Ustica. Lui però essendo uomo normale,
nel senso onirico del termine, non ha nessuna intenzione di
fare il supereroe. Vuole prima possibile uscire da un incubo
in cui si è venuto a trovare senza perdere l'umiltà e la coerenza
di uomo cosciente. E' un susseguirsi di personaggi, compagni
di viaggio più o meno importanti, che lo imputtanano sempre
di più. E un susseguirsi di città, di paesi piemontesi e paesi
siriani, di ogni tipo di lomocozione: treni, aerei, autobus.
Conosciamo Olmo, l'amico più caro, Oku, il pakistano trafficante,
Ciro, pilota temerario, cinesi, colonnelli, sacerdoti e sicari.
Personaggi più o meno pennellati che rispecchiano il cosmopolitismo
di cui si colorano le nostre città. A volte c'è però il tempo
di fermarsi e dare un'occhiata a come si viveva ai tempi di
guerra e come era difficile trasportare la mobilia o le provviste
tra il Basso Piemonte e Genova. Pur essendo romanzo breve riesce
comunque, mi ripeto, a parlare di uomini, di città e di come
ci si vive (particolarmente curiosa la descrizione di Roma,
il miglior esempio di genovesità di fronte alla capitale); di
cosa ci propina questo mondo che si confronta solo sui soldi
e sui segreti di stato. Il problema sta nell'essere non omologato,
di non stare al gioco solo perché non ci sono chiare le sue
regole. Diciamo che è un racconto che dà forza, un poco di fiducia
a chi prova a non dire sempre sì. Un "Cacucci" genovese al quale
sono particolarmente grato per il capitolo del sogno impastato
con De André.
 Marco Casamonti
Marco Casamonti
|

