
Piazza Fontana 1969/
Capire la genesi e la storia di quella bomba
Enrico Deaglio, giornalista e scrittore, in questo libro ripercorre,
con gli occhi dell'acuto osservatore, gli anni della sua giovinezza
quando, studente universitario, partecipò con convinzione
ai movimenti di protesta nati nelle scuole e nelle università,
e che attraversarono l'intero paese per approdare alle fabbriche.
Ma va detto subito che questo non è un libro “autobiografico”,
tutt'altro: la presenza dell'autore si dissolve dalla scena
dopo poche battute sparse nel testo.
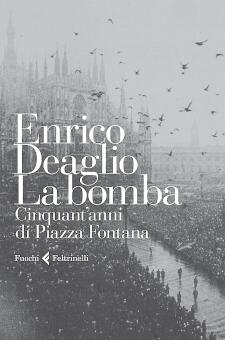 Il
libro di Deaglio, La bomba. Cinquant'anni di piazza Fontana,
edito da Feltrinelli (Milano 2019, pp. 295, € 18,00), non
è un semplice racconto storico, che si aggiunge all'ormai
vastissima biblioteca sull'argomento, ma un vero e proprio j'accuse
contro le istituzioni, i servizi segreti “non deviati”
(quella dei “servizi deviati” è una leggenda
che questo libro dissolve), i neofascisti, i politici, cioè
lo Stato, perché quella storia è ancora viva e
continua a fermentare i suoi nefasti influssi nel nostro Paese.
Un libro composto non solo da parole ma anche da molte fotografie
dell'epoca che illustrano, in modo preciso, l'intera narrazione
della storia di quella maledetta bomba di Piazza Fontana del
12 dicembre 1969 e le perduranti menzogne del potere che l'hanno
accompagnata. Il
libro di Deaglio, La bomba. Cinquant'anni di piazza Fontana,
edito da Feltrinelli (Milano 2019, pp. 295, € 18,00), non
è un semplice racconto storico, che si aggiunge all'ormai
vastissima biblioteca sull'argomento, ma un vero e proprio j'accuse
contro le istituzioni, i servizi segreti “non deviati”
(quella dei “servizi deviati” è una leggenda
che questo libro dissolve), i neofascisti, i politici, cioè
lo Stato, perché quella storia è ancora viva e
continua a fermentare i suoi nefasti influssi nel nostro Paese.
Un libro composto non solo da parole ma anche da molte fotografie
dell'epoca che illustrano, in modo preciso, l'intera narrazione
della storia di quella maledetta bomba di Piazza Fontana del
12 dicembre 1969 e le perduranti menzogne del potere che l'hanno
accompagnata.
È importante capire la genesi e la storia di quella bomba
esplosa alla Banca dell'Agricoltura a Milano, che causò
la morte di diciassette persone e novanta feriti più
la morte nella Questura di Milano, tra la notte del 15 e 16
dicembre, dell'anarchico Giuseppe (Pino) Pinelli. Questo tragico
evento – con tutte le stragi che seguiranno e con quelle
che l'avevano preceduto – può aiutarci a comprendere
i mali di mezzo secolo del nostro Paese e di questa democrazia
che, ancora oggi, è messa in discussione da “strani”
personaggi che auspicano i “pieni poteri” e che
trovano ispirazione per la propria azione politica nel nazionalismo,
nel sovranismo e nel razzismo, alimentando un acceso odio xenofobo.
Una storia, dunque, che non passa e che ritorna con un vulnus
“oscuro” nella coscienza di tutti, e che ha segnato
profondamente la generazione di quegli anni.
Va detto per inciso che il libro di Deaglio si legge come un
thriller storico, avvincente, emozionante, con tutti i protagonisti,
vittime e carnefici, che emergono dalla narrazione a tutto tondo,
intorno al “mistero/giallo” da risolvere: chi ha
messo la bomba nel salone della Banca dell'Agricoltura quel
pomeriggio del 12 dicembre 1969? Chi ha pensato e voluto quella
stagione di stragi che è poi passata alla storia come
“strategia della tensione”?1
Chi era veramente presente nella stanza della Questura durante
l'interrogatorio di Pinelli? La tragicità del racconto
è che è tutto vero, nomi e cognomi come le responsabilità
materiali e politiche, e la lettura del libro non lascia nell'indifferenza
il lettore. È un'analisi amara, che lacera la coscienza
di ognuno, capace di travolgere il lettore assillandolo con
domande come: ma in quale paese viviamo? La democrazia italiana
è mai esistita veramente? Cosa sono stati la società
o lo Stato italiano nati dalla Resistenza?
Come scrive Deaglio: «Raccontare la Storia di Piazza Fontana
è anche raccontare la bomba, i suoi complici –
quelli che con felice intuizione gli anarchici del Ponte della
Ghisolfa definirono “lo stato” – e la tenace
lotta che, con pochi mezzi, molto coraggio e molto romanticismo,
gruppi di persone intrapresero per ristabilire la Verità,
molto spesso contro lo spirito dei tempi». Una verità
che nonostante i depistaggi (il depistaggio è stato introdotto
nel Codice penale solo nel 2016, art. 375 bis) e le “amnesie”
degli uomini dello Stato è emersa negli anni, ma che
è necessario ribadire non tanto per cercare una “verità
giuridica”, che dopo anni di inchieste e processi è
ben lungi dal manifestarsi, ma per riconfermare una “verità
storica”: quel massacro fu una «strage di Stato».
Gli italiani in fondo sanno e possono sapere la “Verità”
su Piazza Fontana: parafrasando Pasolini – che il 14 novembre
1974 dalle pagine del «Corriere della sera» lanciò
il suo j'accuse contro i mandanti e gli esecutori delle
stragi – si può affermare che “noi sappiano”
bene chi sono i responsabili di quella strage. Ma all'epoca
dei fatti, come scrive con amarezza l'autore, la «menzogna
era più forte – molto più forte –
della verità».
Il ruolo dei fascisti
La descrizione, ad esempio, di Mariano Rumor nel libro, uno
dei politici e presidente del consiglio dell'epoca, è
esemplare. Uomo della DC, appartenente alla corrente dorotea,
durante l'interrogatorio del noto processo presso il Tribunale
di Catanzaro a proposito della strage di Milano ebbe a rispondere
a «diciotto domande» «con “diciotto
non ricordo”, che rimasero un celebre momento dell'Italia
intesa come repubblica dell'amnesia». Nessuna autorità
politica all'epoca fece bella figura a principiare da Giuseppe
Saragat, presidente della Repubblica, assente ai funerali.
In mezzo a questa palude di “non ricordo”, nella
memoria di milioni di italiani rimase impressa la fotografia,
pubblicata dai quotidiani dell'epoca, della voragine provocata
dalla potentissima esplosione – l'attentato era stato
progettato per causare il maggior numero possibile di vittime
– formatasi nel salone della Banca dell'Agricoltura. Eppoi,
come non ricordare le vittime, e tra queste il bambino che perse
una gamba per fare un favore al papà che non se la sentiva
di andare in banca?
E i fascisti cosa c'entrano in tutto questo? Deaglio ricorda
che proprio uno di loro, Giovanni Ventura – piccolo imprenditore
veneto che come seconda attività faceva il terrorista
–, confidò il giorno seguente al suo amico Guido
Lorenzon – testimone “scomodo” lasciato solo
dalla magistratura e dalla polizia – «che la bomba
l'avevano messa loro». L'attentato venne preparato «dal
gruppo veneto di Ordine Nuovo, un'organizzazione nazista con
forti agganci e protezioni ai vertici dello Stato italiano,
che non fece nulla per impedirlo». E aggiunge lo scrittore:
«Quando leggerete quanta protervia, quanta “organizzazione
industriale”, quanta volgarità venne usata per
costruire il falso su piazza Fontana, probabilmente penserete
che gli attuali demagoghi non hanno inventato niente».
«I dirigenti della sezione veneta di Ordine Nuovo erano
Franco Freda, procuratore legale a Padova; Giovanni Ventura,
libraio e editore di Castelfranco (Treviso), che con Freda aveva
commesso tutti gli attentati del 1969 attribuiti agli anarchici;
e Carlo Maria Maggi, “medico dei poveri” in un ambulatorio
all'isola della Giudecca di Venezia». Inoltre, un altro
veneziano, Delfo Zorzi, è stato identificato tra coloro
che attuarono questo piano mortale.
Come ricorda l'autore del libro, questa ricostruzione dei fatti
avvenuta durante l'inchiesta del giudice Guido Salvini, «sancita
in due gradi di giudizio e infine vidimata dalla Cassazione»,
non ha mai trovato esecuzione perché nel frattempo Freda
e Ventura vennero assolti per lo stesso reato nel 2005 mentre
Zorzi fu precedentemente assolto dall'accusa di essere l'esecutore
materiale dell'attentato. «Dopo quarantatré anni
di processi, la mortificazione della giustizia era totale. Una
beffa postuma».
Il libro affronta, inoltre, la complessa ricostruzione dell'attentato,
e non c'è commento che non sia proceduto dalla descrizione
particolareggiata dei fatti e soprattutto la montagna di bugie
che furono sparse al tempo per nascondere le responsabilità
degli esecutori e dei mandanti. Per esempio l'impiegato della
Banca nazionale dell'agricoltura e vittima dell'esplosione,
Fortunato Zinni, scrive così in un memoriale: «La
vergognosa e irridente tela di Penelope ordita per fare e disfare
sentenze, in una allucinante e incredibile parodia della giustizia,
ha di volta in volta messo a nudo: la certezza di impunità
dei burattinai del massacro, il cinismo di una classe politica
imbelle e complice, la disponibilità di una parte della
Magistratura ad assecondare il potere, il servilismo di una
stampa pronta a credere alle verità ufficiali».
Proprio la stampa e la televisione, allora con unico canale
televisivo, in prima battuta avvallarono senza spirito critico
le tesi della Questura di Milano sulla responsabilità
“anarchica” dell'attentato. Per tutti il “Mostro”
fu Pietro Valpreda- “ballerino-anarchico”, con la
complicità del suicida-confesso Giuseppe Pinelli –
«elemento di speciale pericolosità e come tale
da sottoporre a sorveglianza» per le autorità di
polizia – così come dichiararono più volte
Marcello Guida questore di Milano, Antonino Allegra capo dell'ufficio
politico della Questura di Milano e infine il commissario Luigi
Calabresi. Coloro che in quel coacervo di notizie false e tendenziose
credettero invece all'innocenza degli anarchici furono pochissimi.
Tra i primi a schierarsi dalla parte di Pinelli e degli anarchici
milanesi, il giornalista Piero Scaramucci, recentemente scomparso,
che all'inizio degli anni Ottanta darà alle stampe un
bel libro-intervista con Licia Pinelli: Una storia quasi
soltanto mia. Un'altra giornalista, Camilla Cederna, si
distinse per il suo impegno controcorrente e la sua passione
civile. All'epoca chi dissentiva veniva perseguitato e in molti
sono stati perseguitati e condannati dalla magistratura, e questo
per aver detto soltanto in parte la verità, non potendo
conoscere altri inquietanti dettagli. Ma a loro, giustamente,
Deaglio offre un tributo di ringraziamento per non aver ceduto
e aver continuamente sostenuto la battaglia civile per la ricerca
della verità.
Un tributo a Licia Rognini
Altro tributo il giornalista lo dedica a Licia Rognini, vedova
di Giuseppe (Pino) Pinelli; grazie a lei alla sua determinazione
e al suo coraggio si deve la costruzione di quell'argine che
non ha permesso al fiume Lete, quello della mitologia greca,
di affogare questa tragica storia nell'oblio. A lei e alle sue
adorate figlie si è aggiunto poi un manipolo di intellettuali
che il giorno 19 dicembre 1969 riuscirono a far pubblicare un
appello dal quotidiano «Il Giorno», dopo che l'organo
del PCI «L'Unità» l'aveva rifiutato, nel
quale affiancandosi a Licia rivendicavano il diritto di difendere
Pinelli sostenendo la sua innocenza.
La «verità è figlia del tempo» e non
dell'autorità, scrive Deaglio e ha ragione, tanto che
a distanza di anni piano piano sono emersi dettagli che gettano
una nuova luce sulla dinamica degli eventi e sullo stesso “suicidio”
di Pinelli. In particolare sul ruolo svolto dalla «Squadra
54 dell'Ufficio Affari Riservati» i cui uomini arrivano
a Milano a poche ore di distanza dall'esplosione “espropriando”
le autorità locali di polizia e della magistratura di
ogni “autorità”, che gestirono direttamente
il tassista Rolandi, quello che “identificò”
Valpreda, e furono presenti nelle fasi finali della vita di
Giuseppe Pinelli. È lo stesso Silvano Russomanno, ex
“filo-nazista” dell'epoca della RSI e numero due
dei servizi segreti, a confessarlo candidamente nel 2009 alla
giovane magistrata Grazia Pradella: «Io c'ero la notte
che è morto Pinelli».
Questa giovane magistrata, che recuperò in extremis dall'anziano
agente segreto questa dichiarazione, dopo qualche anno in un'intervista
ebbe a dichiarare al settimanale «Famiglia Cristiana»:
«Piazza Fontana fu sicuramente una strage di Stato, perché
si volevano eliminare i cardini fondamentali della democrazia
e perché erano coinvolti elementi che a questo Stato
appartenevano e che lo hanno tradito». A queste considerazioni
manca soltanto l'epilogo logico: del resto è difficile
che un'intera macchina statale recepisca oggi la consapevolezza
di essere stata allora uno dei principali problemi del Paese.
Sfogliando le pagine di questo libro ci si forma un'immagine
chiara di questa “misteriosa” struttura legata a
una continuità “istituzionale” di uomini
e strutture con il suo passato fascista, insieme burocratica,
parassitaria e golpista, sorniona ma immodificabile, impermeabile
a chiunque, compresi i neofascisti che con i loro “deliri”
teorici e terroristici immaginavano una “seconda rinascenza”.
Il libro di Deaglio è da leggere con attenzione e anche
con “passione civile”, ed è rivolto soprattutto
a quelle generazioni che – nate dopo Piazza Fontana –
hanno un bisogno impellente di conoscere tutta la dinamica storica
che ha attraversato il nostro Paese nei decenni immediatamente
successivi alla fine del Secondo conflitto mondiale, per comprenderne
lo stato attuale.
Franco Bertolucci
1. Il termine “strategia della tensione” (“strategy
of tension”) venne coniato dal quotidiano inglese «The
Guardian» nell'editoriale del 17 dicembre 1969.
Una bomba che riecheggia nelle coscienze
In occasione della presentazione del libro di Enrico Deaglio a Pisa, lo scorso 20 novembre 2019, al Polo Carmignani - Università di Pisa, promossa congiuntamente da Biblioteca Franco Serantini e ANPI provinciale Pisa, Claudia Pinelli ha fatto pervenire agli organizzatori il seguente messaggio:
C'è
una dedica importante nel libro di Enrico Deaglio, una
dedica che fa bene al cuore di chi in tutti questi anni
ha cercato che la storia di una persona, Giuseppe Pinelli,
e la storia di quella bomba deflagrata in una nebbiosa
e invernale Milano, continuasse a riecheggiare nella coscienza
distratta di un paese.
Non è un libro di inchiesta come altri che stanno
uscendo in questo periodo, ma una potente opera letteraria
che ricompone l'insieme, che restituisce senso e memoria,
che non si abbandona alla rassegnazione e all'omologazione,
nel coraggio della coerenza e dell'onestà intellettuale
di chi non si è permesso l'indifferenza.
Il libro di Enrico Deaglio è l'impegno di persone
tra cui giornalisti, e vorrei ricordare Camilla Cederna,
Corrado Stajano, Marco Nozza, Piero Scaramucci, che in
questi anni hanno fatto propria una storia permettendo
che non venisse dimenticata ed entrasse nella Storia e
lo hanno fatto con altruismo, senza egocentrismi e autocentrature,
restituendo dignità dove altri avrebbero voluto
calasse l'oblio.
L'arte, come i libri, le poesie, le installazioni artistiche,
è uno strumento che va oltre le omertà e
quel filo che tiene insieme quello che è stato
con una visione più ampia e necessaria.
Questa è la giustizia che ha avuto Pino Pinelli
e mi piace ricordare con una frase dell'ultima lettera
che scrisse a un giovane ingiustamente carcerato: “Anarchia
non è violenza la rigettiamo ma non vogliamo neanche
subirla. Essa è ragionamento e responsabilità”.
Grazie,
Claudia Pinelli |
Droga, mafia, Stato/
Il Sistema è uno solo
«Chetati, grillaccio del mal'augurio!»
– gridò Pinocchio – ma il grillo, che era
paziente e filosofo, invece di aversi a male di questa impertinenza,
continuò con lo stesso tono di voce...
Dopo gli anni della speranza e quelli della disillusione e
della normalizzazione giunsero infine tempi confusi. Appassionanti
e spesso terribili per chi li ha vissuti in paesi in cui regimi
– che parevano eterni – si disfecero come neve al
sole; caotici e quasi incomprensibili nei luoghi in cui la democrazia
(post)industriale ha continuato implacabile la sua marcia. Ed
è in fondo di tale impetuoso incedere di cui qui si parla,
ma da un particolarissimo punto di vista: quello degli anarcopunx
di strada.
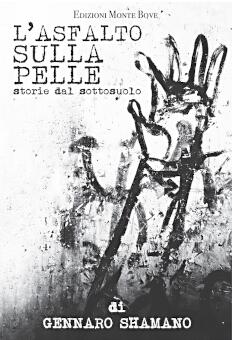 L'arte della scrittura può far miracoli e la vita più
piatta e banale, se narrata in modo da suscitare immedesimazione,
risulterà avvincente ed emozionante. Non è questo
il caso.
L'arte della scrittura può far miracoli e la vita più
piatta e banale, se narrata in modo da suscitare immedesimazione,
risulterà avvincente ed emozionante. Non è questo
il caso.
In primo luogo perché lo Shamano (Gennaro Shamano, L'asfalto
sulla pelle – Storie dal sottosuolo, Edizioni Monte
Bove, Spoleto – Pg 2019, pp. 352, € 10,00) scrive
con un piglio rocchenroll grezzo e veemente, che ai cultori
della scrittura in punta di fioretto suonerà qual unghia
sulla lavagna ('o Shama', ma quanta sfaccimm' 'e punt' esclamativ'
c'ej mis' dint' a 'stu libbr'?); e in secondo luogo perché
l'esistenza di Gennaro è tutto fuorché rifrittura
impiegatizia. Spoileriamo: Gennaro è ancora vivo e pure
in buona salute (poi non è che ho visto le sue analisi).
Risultato sorprendente viste le sollecitazioni alle quali ha
sottoposto il suo corpo. Questa è la buona notizia.
La cattiva notizia è che abbiamo un'altra storia di sconfitta,
più della mia generazione che della sua; o meglio: dell'incapacità
di trasmettere l'esperienza di chi aveva visto con quanta perizia
ed efficacia erano state usate le sostanze sintetizzate da Bayer
e Sandoz per neutralizzare il movimento negli anni in cui un
movimento c'era davvero. Andiamo con ordine, però. Ragazzini
nati e cresciuti alle falde del Vesuvio, insofferenti alla famiglia,
all'istituzione scolastica e in genere all'ordine costituito,
o all'ordine e basta. Ribelli senza veri obiettivi, in un tessuto
sociale polverizzato dalla modernità e mummificato dalla
televisione; lì rock, punk e metal potevano essere la
scintilla per innescare una fuga dalla condanna di vite monotone
e grigie oppure incasinarsi in avventure senza capo né
coda verso lo scontro frontale. Come quando – in seguito
all'arresto per uno scippo – «fui legato [da mio
padre] al tavolo con alcune corde e poi prese a frustarmi con
la cinghia per ore. Mi lasciò in quello stato fino a
tarda sera, senza acqua né cibo, poi ad intermittenza
picchiava mia madre e mia sorella incolpandole per la mia cattiva
educazione.»
Di studiare non se ne parla, si cerca invece di andare ai concerti,
nelle occupazioni, usando alcool e erba, prima, poi chimica
assortita; un vortice di viaggi per l'Italia e in Europa, fino
ai rave, il lavoro in fabbrica e infine a Napoli: call center
di pomeriggio e la sera eroina a Scampia.
Su tutto, nella seconda parte del libro, dominano due nodi del
nostro vivere e della nostra storia troppo spesso ignorati,
occultati. Il primo è la visione chiara del fatto che
non esiste alcuna separazione possibile tra le istituzioni e
le organizzazioni mafiose. È sorprendente quanti pensatori
illuminati e quanti sinceri antistatalisti credano ancora alle
scemenze delle forze dell'ordine corrotte e dell'invincibile
camorra con la quale scrittorucoli omertosi hanno venduto milioni
di copie impestando le librerie e le menti.
Poche pagine dello Shamano descrivono chiaramente come il Sistema
sia uno solo, tossici a branchi che fanno file per ore in attesa
della roba con la polizia che finge posti di blocco. E poi la
parte più pesante, quella del capire di aver abboccato
all'amo che il Sistema gli aveva messo davanti.
A mio avviso, non solo l'eroina, ma tutto quel processo di estraniazione
che arriva agli oppiacei dopo essere passati per anfetamine,
cocaina, ketamina, lsd e le altre sfavillanti porcherie psicoattive
di cui questo libro è pieno. E quindi? Siamo forse riusciti,
noi che negli anni '80 ci facevamo largo nel fiume di eroina
che l'Operazione Bluemoon ci aveva regalato – senza mai
toccarla, e non per moralismo, ma perché vedevamo
quali erano le strategie messe in campo – a mettere in
guardia, a tutelare questi giovani compagni, palesemente indifesi?
Ed ora, cosa ci può dare sollievo, forse berciare: Visto,
ve lo avevamo detto... Così non si fa la rivoluzione!
Perché, forse che noi – grillacci del mal'augurio
– siamo stati capaci di farla?
Giuseppe Aiello
Han Ryner/
Anarchia fa rima con armonia
Quando si evocano i teorici dell'anarchismo, solitamente il pensiero non corre
immediatamente a Han Ryner (1861-1938) nonostante la cospicua
produzione di scritti filosofici e letterari, in particolare
sotto la forma di racconti filosofici. Noto soprattutto in Francia
come irriducibile pacifista e anticlericale, ebbe una certa
influenza sulla giovane generazione in Spagna negli anni Venti
e in particolare sui renitenti alla leva durante la dittatura
di Primo de Rivera, grazie alle traduzioni degli scritti suoi
e di E. Armand a cura degli anarchici individualisti M. Costa
Iscar e J. Elizalde.
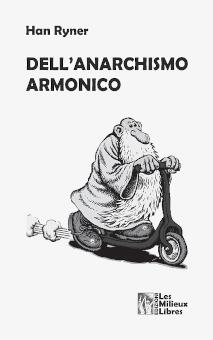 Il
mio primo incontro con lui risale alla lettura di un ormai ingiallito
opuscolo pubblicato a Genova nel lontano 1965 dalla Libreria
della FAI e intitolato “Storicità di Gesù”;
quindi l'ho conosciuto soprattutto per la sua verve antidogmatica.
In realtà, anche in Italia il suo breviario individualista,
ora riproposto dalle edizioni Les Milieux Libres (Dell'anarchismo
armonico, Les Milieux Libres Edizioni, Soazza - Svizzera
2019, pp. 64, € 8,50) conobbe diverse edizioni. Di transenna:
anarchismo armonico sembra una tautologia; l'anarchismo o è
armonico o non è. Diverso è il discorso dell'individualista,
dove invece la contrapposizione tra l'egoista e l'individualista
armonico regge. Il
mio primo incontro con lui risale alla lettura di un ormai ingiallito
opuscolo pubblicato a Genova nel lontano 1965 dalla Libreria
della FAI e intitolato “Storicità di Gesù”;
quindi l'ho conosciuto soprattutto per la sua verve antidogmatica.
In realtà, anche in Italia il suo breviario individualista,
ora riproposto dalle edizioni Les Milieux Libres (Dell'anarchismo
armonico, Les Milieux Libres Edizioni, Soazza - Svizzera
2019, pp. 64, € 8,50) conobbe diverse edizioni. Di transenna:
anarchismo armonico sembra una tautologia; l'anarchismo o è
armonico o non è. Diverso è il discorso dell'individualista,
dove invece la contrapposizione tra l'egoista e l'individualista
armonico regge.
Bisogna però sapere che l'individualismo di Ryner non
trae linfa dalla lotta di classe, ma dalla ricerca della liberazione
individuale da tutte le dipendenze esteriori per una vita in
armonia con se stessi. In effetti, l'autore chiamato Socrate
contemporaneo o Tolstoj provenzale ci fornisce lui stesso una
plausibile spiegazione per l'uso dell'aggettivo nel testo sull'anarchismo
armonico tratto dall'Encyclopédie Anarchiste di
Sébastien Faure e molto opportunamente inserito dal curatore
Edy Zarro in apertura del volumetto. “Bisogna arrivare
a trovare tutto in sé e a tutto rispettare”, questo
significa “Vivi armoniosamente”.
Frasi come queste non sono piaciute ad esempio a Albert Libertad,
che sospetta passività e fatalismo nella muta adorazione
di un io silenzioso e, anzi, ritiene che libretti del genere
vadano distrutti come l'assenzio e la morfina1.
In realtà, la logica dell'armonia in Ryner significa
avocare a sé la propria esistenza sottraendola a dogmi,
idoli e autorità (come la patria, il potere, la volontà
del popolo, l'ordine, la religione, la razza, il colore fino
al più triviale “cosa ne diranno”). Orbene,
siccome gli idoli (direi che qui Stirner fa più che capolino)
“esigono il sacrificio di me stesso”, l'individuo
è chiamato a difendersi, rifiutando l'obbedienza (tenete
presente il titolo emblematico di uno dei suoi libri, Il
crimine di obbedire), astenendosi o obiettando: “L'individualista
non può essere del numero dei tiranni sociali”.
Nonostante il sospetto di passività, Ryner è,
nei fatti, un campione attivo di solidarietà militante
con anarchici e antimilitaristi perseguitati dalla legge, da
Hem Day (autore di Individualisme d'armonie chez Han Ryner)
a Francesco Ghezzi. L'antidogmatico francese costruisce il manuale
sotto forma di dialogo con se stesso. Pone domande come: che
cos'è la felicità? Ci sono casi in cui si ha il
diritto di uccidere? Cos'è la menzogna maliziosa? Fare
sesso senza amore è un errore? Il saggio crede nel progresso?
Cosa pensa il saggio dell'anarchia?
Se pensate che ora dica anche le risposte vi sbagliate, sarebbe
come svelare chi è l'assassino in un giallo. Evidenti
e dichiarate però le sue fonti: i “veri individualisti”
Socrate, Epicuro, Gesù ed Epitteto, il cui Manuale
è considerato “il più bello e il più
liberatorio dei libri”.
Nella sua breve ma densa prefazione, Edy Zarro evoca un aspetto
particolare e negletto del pensiero libertario di Ryner, il
cosiddetto “amour plural”, inteso come relazioni
molteplici poste sullo stesso piano. La diffusione di queste
idee ad opera dell'anarchica individualista Maria Lacerda de
Moura hanno fatto conoscere Han Ryner anche in Brasile. Alla
fine, un libretto delizioso come una pralina in bocca, a soli
8 euro e 50.
Peter Schrembs
1. Albert Libertad, Dans les Livres, Le Petit Manuel
individualiste, par Han Ryner, “L'Anarchie”,
n° 5, 11 maggio 1905.
Architettura/
L'a-crescita di Serge Latouche
Hyperpolis, l'interessante opuscolo edito recentemente da Meltemi con
sottotitolo Architettura e Capitale (Milano 2019, pp.
80, € 8,00), contiene un breve intervento di Serge Latouche
dal titolo Architettura, urbanistica e decrescita inserito
tra una dettagliata introduzione e un più corposo intervento
di Marcello Faletra sul tema Urbanistica e architettura come
psicopatologie.
Un indizio sui diversi registri dei due autori lo trovo nella
citazione nelle prime righe dell'introduzione ad Eric Hobsbawm
e a Rem Koolhaas e nell'inizio del saggio finale di Faletra
a Lewis Mumford così come nel saggio di Latouche trovo
un omaggio in esergo a Les Géants di J.M.G. Le
Clézio: una citazione storica e disciplinare da una parte,
una letteraria e poetica dall'altra in cui è contenuto
il termine Hyperpolis che dà il titolo all'opera.
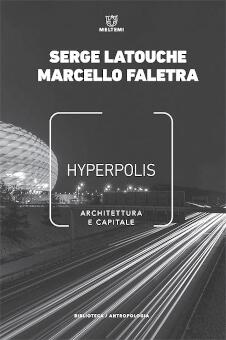 Latouche
sin dalle prime righe mette subito il coltello nella piaga ed
evidenzia la contraddizione della contemporanea presenza di
un gran numero di architetti che predicano la necessità
di un habitat ecologico e che contemporaneamente, da complici,
contribuiscono alla speculazione e alla distruzione del territorio
e dell'ambiente. L'architettura di questi nuovi ecologisti a
parole, al di fuori del singolo intervento puntuale spesso a
impatto zero, si rivela nel complesso fortemente deludente,
“perché non riesce a fare città e
soprattutto perché non è riuscita a impedire globalmente
la decomposizione del tessuto urbano, la cementificazione
del territorio, la proliferazione urbana del paesaggio,
il propagarsi della bruttezza delle condizioni di vita e la
distruzione dell'ambiente.” Latouche
sin dalle prime righe mette subito il coltello nella piaga ed
evidenzia la contraddizione della contemporanea presenza di
un gran numero di architetti che predicano la necessità
di un habitat ecologico e che contemporaneamente, da complici,
contribuiscono alla speculazione e alla distruzione del territorio
e dell'ambiente. L'architettura di questi nuovi ecologisti a
parole, al di fuori del singolo intervento puntuale spesso a
impatto zero, si rivela nel complesso fortemente deludente,
“perché non riesce a fare città e
soprattutto perché non è riuscita a impedire globalmente
la decomposizione del tessuto urbano, la cementificazione
del territorio, la proliferazione urbana del paesaggio,
il propagarsi della bruttezza delle condizioni di vita e la
distruzione dell'ambiente.”
È possibile ragionare di un'architettura e di un'urbanistica
che collaborino per la “costruzione di una società
di abbondanza frugale”, si chiede Latouche?
Con una rapida carrellata da Platone a Tommaso Campanella sino
ai nostri Tiziana Villani e Alberto Magnaghi e alle analisi
di Marc Augé e Alvaro Siza, Latouche si chiede se dovremo
soccombere all'affermazione del cyberman e alla “deterritorializzazione
senza ritorno” o se esista un'altra via praticabile. La
prima modernità a partire dal XIX secolo, nonostante
i danni irrimediabili al territorio, aveva mantenuto un certo
equilibrio tra la struttura urbana e il paesaggio. La rottura
definitiva di ogni equilibrio per Latouche avviene “in
modo simbolico, dalla caduta del muro di Berlino, nel 1989”,
per dare spazio alla globalizzazione e alla mondializzazione
e dalla definitiva “mercificazione e dalla finanziarizzazione
del mondo”. Amaramente conclude che “i rimedi finora
proposti non sono all'altezza della sfida. Il recupero dei centri
storici, ad esempio, dà luogo a gradevoli rese estetiche,
ma provoca una gentrificazione che accresce la segregazione
sociale e una museificazione che rende il turismo di massa un
incubo urbano.”
È inutile lavarsi l'anima con qualche “forma di
modernizzazione ecologica del capitalismo (greenwashing)
o sperare nei progetti totalitari – già fallimentari
– delle “ecocittà” cinesi.
La ricetta alternativa di Latouche è politica, in senso
letterale: urge “una rifondazione della politica, e quindi
della polis, della città e del suo rapporto con
la natura. Il progetto urbano/paesaggistico è necessariamente
secondario rispetto al progetto sociale e il progetto
architettonico è esso stesso accessorio al progetto urbano”.
E ancora Latouche aggiunge: “Il territorio dovrebbe essere
considerato come un'immensa opera d'arte vivente, prodotta e
mantenuta nel tempo dai popoli esistenti.”
Concetti simili questi ultimi a quelli espressi dal filone “libertario”
presente nel panorama architettonico internazionale sin dalla
seconda metà del XIX secolo, di cui i principali esponenti
italiani sono stati De Carlo, che per lungo tempo ha lottato
per ribadire l'indissolubile unità di urbanistica e architettura,
e Carlo Doglio, che in una lezione allo IUAV di Venezia nell'anno
di corso 1971-72 ci disse: “volete sapere per me cos'è
l'urbanistica? È come un affresco rinascimentale di un
grande artista, è qualcosa di complesso, ci sono tante
cose, non è spiegabile, però funziona.”
(Franco BunÄuga in Architettura, l'altra; in “Libertaria”
2018, Ed. Mimesis)
Idee che sia Doglio e De Carlo sia ora il nostro Latouche hanno
desunto da Patrick Geddes e dagli urbanisti della scuola anglosassone
che affonda le sue radici nel pensiero del rivoluzionario e
geografo anarchico Pëtr Kropotkin, come ci ricorda nel
suo esauriente excursus storico Marcello Faletra nel
saggio finale Architettura e urbanistica come psicopatologie.
Nel testo l'autore analizza i caratteri della forma totalitaria
del capitalismo contemporaneo di cui la città diviene
il veicolo spaziale propulsore, aspetto analizzato in una prospettiva
genealogica del postmodernismo prendendo come paradigma la città
di Las Vegas.
Oltre ai modelli anglosassoni Latouche nel suo saggio ripropone
molte delle intuizioni del grande Yona Friedman: autarchia,
autonomia, dispersione, autosufficienza energetica e “una
città ecologica fatta di quartieri compatti”. Per
lui “la città della decrescita sarà anzitutto
un altro modo di abitare la città”, non un modo
diverso di costruire città.
Una ricetta dunque per iniziare da subito, senza grandi progetti
utopici, partendo dalla città esistente ed eliminando
gradualmente “la pubblicità, le automobili e la
grande distribuzione e dove saranno stati introdotti giardini
condivisi, piste ciclabili, la gestione in economia dei beni
comuni (acqua, servizi di base) e lo sviluppo della coabitazione
e dei laboratori di quartiere.”
Non una decrescita dunque in senso stretto, ma come preferisce
dire Latouche una a-crescita, una sana crescita organica, come
sviluppo orizzontale della comunità e delle reti urbane
e un dissolversi graduale delle strutture di dominio, anche
nelle forme oppressive dell'attuale onnipervasivo manhattanismo
delle strutture urbane descritto da Rem Koolhaas, che sembra
voler avverare la distopica profezia di Lewis Mumford citata
da Latouche che prevedeva che la megalopolis si sarebbe
trasformata in tirannopolis, per poi finire in nekropolis.
Franco Bunčuga
Hugo Pratt/
La guerra nelle tavole
Nell'elegante e raffinato volume a fumetti di Hugo Pratt e Hector Oesterheld, Ernie Pike (Rizzoli – Lizard, Roma 2019, pp. 462, € 39,00), si racconta di Hugo Pratt che, già disegnatore affermato in Italia, nel '49 decide di accettare l'invito del magnate del fumetto argentino Cesare Civita a lavorare per le sue riviste di comics e si trasferisce da Venezia, sua città natale, a Buenos Aires.
Qui conosce lo sceneggiatore Héctor Oesterheld e con lui realizza una serie a fumetti, che esce per quattro anni, dal '57 al '61, su Hora Cero – uno dei tanti album a fumetti prodotti da Civita – che ha per titolo Ernie Pike.
Erano strisce sulla guerra, ispirate alle cronache del famoso giornalista americano Ernie Pyle, corrispondente di guerra da vari fronti durante la seconda guerra mondiale e morto, nel '45, per una bomba esplosa in Indocina mentre fotografava la battaglia di Okinawa.
Le tavole di Pratt e Oesterheld documentavano, illustrandola, la guerra da una prospettiva diversa e più umana da come l'avevano raccontata i grandi media, proprio seguendo e riportando, a volte fedelmente, i reportage di Ernie Pyle – premio Pulitzer e tra i giornalisti più letti in America durante la seconda guerra mondiale – raccolti nel suo famoso libro Brave men, uscito in America nel '45 dove raccontava con grande obiettività e verità e senza acritici patriottismi, gli eventi bellici e la vita quotidiana dei militari, non solo degli Usa, valorosi ma anche impauriti e inorriditi, con la voglia di vincere ma anche di tornare di casa sani e salvi.
È uno 'spettacolo', quello della guerra, che sfianca il grande corrispondente di guerra americano, che confessa in uno dei suoi articoli: “Sono sporco sia mentalmente che fisicamente. Ho prosciugato le mie emozioni. Guardo il coraggio, la morte, i campi di battaglia, i tanti e tanti paesi, quasi come un cieco, vedendo debolmente e non volendo vedere affatto la realtà. È il pensiero dell'insensatezza che si insinua in me e comincia a divorarmi. È la polvere perpetua che mi soffoca, il terreno duro che mi irrigidisce i muscoli, sono le mosche e i piedi sporchi e il rombo continuo dei motori e il movimento continuo, il vai e vai, notte e giorno e poi di nuovo, la notte, senza mai smettere o solo Dio sa quando, ma io sono stanco”.
E proprio quella stanchezza di Pyle di fronte ad un'umanità avvilita dalla guerra, Pratt e Oesterheld la sceneggiano e disegnano nelle avventure del loro personaggio, Ernie Pike, destinato a diventare icona di culto del fumetto del '900 e che si muove – in più di trenta storie, tra eserciti in guerra, in scenari che vanno dall'Europa all'Africa, al Pacifico – “retto e giusto” – come scrivono nel loro intervento introduttivo al volume (dal titolo deandreiano Siete lo stesso coinvolti) Boris Battaglia e Paolo Interdonato – “sulla linea del fronte, in mezzo alle pallottole, allo sporco, al fetore, alla codardia, ai piccoli eroismi, alla bassezza di ufficiali che danno ordini disgustosi, alle menzogne, alle lacrime e al sangue” e che “vive racconti di guerra nei quali è impossibile prendere una parte tra i fronti. Le divise non servono a determinare quali siano i soldati buoni e quali i cattivi”.
Una proposta valida, quindi, quella della Rizzoli-Lizard, non solo perché serve da stimolo ad una riflessione sulla violenza e la guerra, ma anche perché offre, di un'opera poco conosciuta di Pratt, la sempre gradevole visione del suo inconfondibile e originale tratto artistico.
Silvestro Livolsi
|

