
Carne della sua carne
1.
La lettura de I sogni dell'intellettuale politicante Francisco
De Quevedo (1580-1645) la ricordo come una delle più fastidiose
imprese in cui mi sia buttato. Mai più – e implicito
è l'invito a starne alla larga. Perennemente in cerca dell'approvazione
ecclesiastica, De Quevedo delira contro tutto e contro tutti –
contro i farmacisti, per dirne una, e contro i mancini o contro
i poeti e contro i teatranti, per dirne altre. Data l'epoca in
cui scriveva – tra il 1606 e il 1627 – e dato il contesto
– la Spagna –, fra i suoi bersagli non poteva mancare
Maometto, cui, passando da un insulto all'altro (“il peggior
uomo che vi sia stato al mondo”), chiede, “Pezzo di
birbante, perché mai hai proibito il vino ai tuoi seguaci?”.
“Perché se oltre ai discorsi da ubriaco che lasciai
scritti nel mio Corano, avessi permesso loro anche di darsi
al vino, a quest'ora sarebbero tutti ubbriachi”, gli fa
rispondere. E poi passa al lardo e al prosciutto. “Perché?”,
“Lo feci per non recare offesa al vino”, è
la sorprendente insulsa risposta che gli mette in bocca, “perché
tale sarebbe stata se avessero mangiato ciccioli bevendoci su
acqua, sebbene io usassi ciccioli e vino”. Sul resto stendiamo
un velo pietoso.
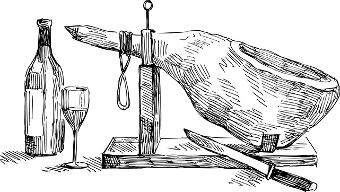
2.
Fermo restando che se ne nutrono abbondantemente, l'avversione
dei cattolici per gli animali in genere ha accompagnato tutta
la loro irresistibile ascesa ai poteri nel pianeta. San Francesco
– non a caso accettato obtorto collo dalle autorità
ecclesiastiche – costituisce l'eccezione alla regola. In
Matteo (7.6) si raccomanda di non dare “le cose sante
ai cani” e di “non gettare le vostre perle davanti
ai porci, perché non le calpestino con le loro zampe e
poi non si voltino per sbranarvi”. Nell'uso, ormai l'espressione
“non dare le perle ai porci” sembra designare l'invito
a non donare cose preziose a chi non le merita, ma l'invito di
Gesù va più in là – avvisa anche del
pericolo che si corre: le perle non sono cibo – risultano
incongrue per i porci – e dunque i porci possono rivoltarsi
contro il donatore incongruo. Implicito è anche il fatto
che è molto meglio se uno le proprie perle se le tiene
– e qui il Vaticano non si è mai smentito. Poi c'è
la correlazione con il primo invito che, solitamente, non viene
mai ricordata. Il fatto che si inviti a non dare cose sante ai
cani e la citazione successiva dei porci riducono di molto la
portata metaforica dell'espressione complessiva. Qui, innanzitutto,
si sta parlando di cani e di maiali.
3.
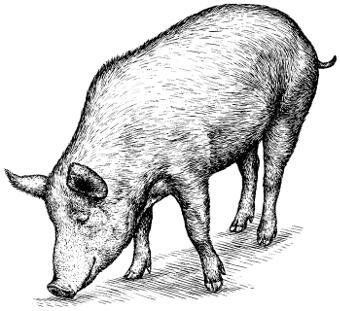 Non
più tardi di sei mesi or sono, noto una pubblicità
televisiva della Rovagnati. Vantandone l'alta qualità,
l'azienda si era imposta sul mercato per via di un prosciutto
cotto battezzato con il nome proprio di “Granbiscotto”.
Palese l'intendimento di usufruire dell'enfasi iniziale e dei
valori positivi caricati sul “biscotto” senza perderne
la caratterizzazione distintiva del prosciutto – “cotto”
e non “crudo”. Ora, però, sull'onda del successo
ottenuto, la stessa azienda ha esteso la propria produzione al
prosciutto crudo e, per convincerne all'acquisto, si affida ad
uno slogan dalla facile rima: “Crudo o cotto purché
sia Granbiscotto”. Che i conti ora non tornino più
– semantica alla mano – è evidente: se il “Granbiscotto”
designava un prosciutto “cotto”, lo stesso nome non
può servire per designare anche il “crudo”.
O cambi nome o, come parli, ti contraddici. Non
più tardi di sei mesi or sono, noto una pubblicità
televisiva della Rovagnati. Vantandone l'alta qualità,
l'azienda si era imposta sul mercato per via di un prosciutto
cotto battezzato con il nome proprio di “Granbiscotto”.
Palese l'intendimento di usufruire dell'enfasi iniziale e dei
valori positivi caricati sul “biscotto” senza perderne
la caratterizzazione distintiva del prosciutto – “cotto”
e non “crudo”. Ora, però, sull'onda del successo
ottenuto, la stessa azienda ha esteso la propria produzione al
prosciutto crudo e, per convincerne all'acquisto, si affida ad
uno slogan dalla facile rima: “Crudo o cotto purché
sia Granbiscotto”. Che i conti ora non tornino più
– semantica alla mano – è evidente: se il “Granbiscotto”
designava un prosciutto “cotto”, lo stesso nome non
può servire per designare anche il “crudo”.
O cambi nome o, come parli, ti contraddici.
4.
Circola per i canali televisivi, in questi giorni, una pubblicità di qualcosa che viene definito come “carne di prosciutto”. La contraddizione è palese. Prosciutto condivide la stessa radice del verbo “prosciugare” – designa un qualcosa che è lasciato in condizioni tali da perdere buona parte dell'umido che lo costituisce. Che da un po' di tempo a questa parte si designi così solamente una parte conservata del maiale non sana affatto la contraddizione – perché verrebbe a designare della “carne di carne di maiale” e la “carne di carne” è una mera tautologia.
Il percorso in virtù del quale chi comunica ha deciso di comunicare questa sciocchezza attiene principalmente ai processi valoriali relativi al prosciutto. Anche se, in teoria resterebbe l'ambiguità tra il cotto e il crudo, è presumibile che qui si miri a spacciare insieme alla merce il quadro ideologico del prosciutto cotto – la sua presunta leggerezza, la digeribilità, la sua perenne disponibilità a facilitare le scelte alimentari per i pasti solitari come per i pasti in comune. Da notare, infine, che la comunicazione vuole anche enfatizzare la purezza e la garanzia del prodotto esplicitando che si tratta “solo di carne di prosciutto” come ad evitare eventuali contaminazioni – con altre carni meno nobilitate, con grassi o scarti. Il nome scelto per battezzare questo prodotto è quello di “Golfetta” che è nome femminile – per una forma di bresaola schiacciata che, affettata, somiglia al salame –, nome femminile che già in quanto tale, rimanendo innocua se non addirittura vezzeggiativa, tiene a bada l'associazione eventuale con il maiale.
La domanda di fondo, allora, diventa la seguente: non sarà che tutta questa cogenza del non nominare la parola “maiale” – al di là della vasta letteratura notoriamente negativa che accompagna il maiale – non solo incapace di apprezzare le perle che gli si danno, ma zeppo di colesterolo e, nei secoli dei secoli, portatore della temibile tenia – risponda semplicemente all'esigenza di ingannare l'islamico inducendolo ad un peccato che, non essendo esplicito il nome del contenuto, diventa meno peccato perché compiuto nell'inconsapevolezza?
Felice Accame
|
|