
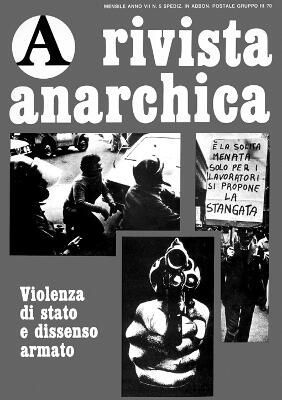
CCon il titolo “Violenza
di stato e dissenso armato” anche la copertina di questo
numero 57 (giugno-luglio 1977) dichiara fin dall'inizio quale
sia il tema che sta più a cuore alla redazione. E vari
sono gli scritti, all'interno, che in vario modo si rifanno
a quel tema. Il dibattito su “nuova sinistra e criminalizzazione
delle lotte” comprende due interventi, entrambi critici
con le posizioni “lottarmatiste”, di Franco Melandri
(“Ampliamo e consolidiamo l'area rivoluzionaria”)
e Luisito (“Lotta armata e 'delinquenza'”). C'è
poi una lunga intervista redazionale, non fìrmata, all'avvocato
Giuliano Spazzali, “uno degli avvocati di estrema sinistra
– si precisa nell'Ai lettori – più impegnati
nella difesa dei compagni rivoluzionari. Tra i recenti numerosi
arresti di legali rivoluzionari o comunque non disposti a farsi
condizionare dalla magistratura e dalla strategia del riformismo,
vi è stato anche quello di suo fratello Sergio.”
Altri tempi, altra sensibilità, altre posizioni politiche.
Lo si riscontra anche nel primo interno di copertina (“Contro
il terrorismo di stato”), nel quale tre foto e un testo
danno conto della manifestazione nazionale indetta dagli anarchici
a Pisa il 7 maggio 1977, nel quinto anniversario della morte
di Franco Serantini. Un corteo al quale partecipano diecimila
persone, tra cui migliaia di anarchici e folte rappresentanze
di Democrazia Proletaria e Lotta Continua. Sotto il palco ci
sono tafferugli (“abbastanza duri, ma fortunatamente brevi
e circoscritti” - si legge nel testo) quando per Lotta
Continua prende la parola Mimmo Pinto, leader dei “disoccupati
organizzati” napoletani ma soprattutto deputato. “Buona
parte della piazza anarchica – si legge sempre nella cronaca
redazionale – ha a quel punto espresso la sua disapprovazione
a gran voce, sommergendo con gli slogan le parole di Pinto,
giudicando politicamente contraddittorio che un esponente dello
stato concludesse una manifestazione contro lo stato e di pessimo
gusto che proprio a questa manifestazione Lotta Continua (che
ha sempre una pratica ambigua: un piede nella scarpa anti-istituzionale
ed uno in quella istituzionale) avesse voluto imporre proprio
il suo volto parlamentare nonostante la richiesta fatta dagli
organizzatori di scegliere un altro oratore (...)”.
Un episodio non fondamentale nella storia italiana e nemmeno
in quello della rissosità a sinistra. Ma, ad avviso della
redazione attuale (2014) di “A”, emblematico del
clima esasperato, del settarismo e soprattutto dell'auto-referenzialità
dei movimenti (quello anarchico, compreso) di quegli anni, in
un'ottica tutta ideologica incapace di cogliere le possibili
e necessarie articolazioni che i movimenti (appunto, e non a
caso, al plurale) devono avere ed accettare al proprio interno
per poter aspirare ad avere una qualche forma di influenza nel
sociale e nell'opinione pubblica.
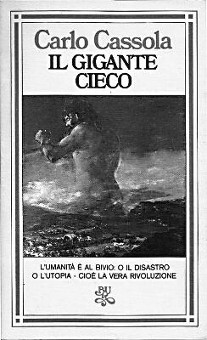 Lo
scrittore Carlo Cassola Vista con gli occhi di oggi – decenni e decenni dopo (anzi,
per essere precisi e in linea con questa rubrica, 37 anni dopo)
– anche da quell'episodio si possono trarre elementi di
riflessione e di ragionamento. Che è poi il senso di
questa rubrica, che non vuole “celebrare” la storia
di questa rivista, ma ripercorrerne selettivamente alcuni passaggi
in un continuum di ricordi e di interrogativi affinchè,
come si usava dire in quegli anni, gli anziani ricordino e i
giovani sappiano.
Su di un versante di apertura mentale e di pluralismo, senza
per questo rinunciare alle “nostre posizioni”, è
l'intervista/confronto con lo scrittore Carlo Cassola, in quegli
anni promotore della Lega per il Disarmo Unilaterale e più
in generale della battaglia contro gli eserciti, il militarismo,
le guerre.
Una battaglia che riprendeva sensibilità e posizioni
classiche del pensiero e del movimento anarchico, ma li rileggeva
da una prospettiva molto particolare, quella data dall'impronta
dell'allora notissimo scrittore. Una prospettiva diciamo così
“catastrofista”, che all'imminente percepito pericolo
di una guerra nucleare mondiale e della consguente scomparsa
dell'umanità dalla faccia della terra opponeva un rifiuto
del militarismo che però non si sposava con una prospettiva
di trasformazione sociale. Al punto che, diceva Cassola, per
abolire gli eserciti ci si poteva accordare con chicchessia,
Stati compresi.
Alcuni anarchici (ricordiamo Ugo Mazzucchelli, altri anziani
militanti, e non solo anziani) fecero propria la battaglia di
Cassola, altri ne criticarono duramente le posizioni e rifiutarono
ogni contatto. In questo frangente “A” si mosse
con intelligenza, dando spazio sia alle posizioni cassoliane
sia alle voci critiche. Confermando che, anche allora (come
oggi), il compito di un foglio anarchico non è quello
di “dare la linea” ma di fornire materiali eterodossi
per riflettere. Lasciando poi ai singoli di formarsi un'opinione
e di agire in conseguenza.
Che, 37 anni dopo, è a nostro avviso il compito che ci
prefiggiamo e che vorremmo poter dire di realizzare almeno in
parte. |