
a cura
della redazione
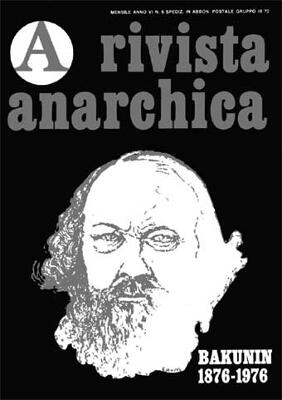
Un faccione stilizzato di Mikhail
Bakunin, (1814-1876) campeggia nella copertina del n. 49 (agosto/settembre
1976) della rivista. Oltre la metà delle pagine sono
dedicate a questo “padre fondatore” dell'anarchismo
internazionale. Roberto Ambrosoli (R. Brosio) ne traccia la
vita; Gampietro “Nico” Berti (M. Roberti) ne analizza
l'attualità del pensiero; Paolo Finzi intervista lo storico
Pier Carlo Masini; Maurizio Antonioli affronta la questione
del suo rapporto con il sindacalismo; Tina Tomasi con la pedagogia
libertaria; Heri Arvon con la sinistra hegeliana.
“Nessuna forma di 'culto della personalità' da
parte nostra – si legge nella presentazione del dossier
– anzi sappiamo bene quanto deteriore e paralizzante risulti
qualsiasi tipo di venerazione per chicchessia e non saremo certo
noi anarchici a elevare qualcuno al rango di Maestro, Caposcuola,
colui-che-ha-capito-tutto. Neppure Bakunin che è stato
il primo ad inquadrare dal punto di vista ideologico e organizzativo
l'anarchismo, neppure Bakunin può sfuggire a questo nostro
costante atteggiamento critico.”
Questo dossier usciva anche in vista del Convegno internazionale
di studi bakuniniani, tenutosi poi a Venezia, Palazzo Sceriman,
24-26 settembre, promosso dai Gruppi anarchici federati (Gaf)
con decine di relatori. Fu quello il primo degli incontri internazionali
anarchici tenutisi in quegli anni nella città lagunare,
che si concluderanno nell'orwelliano 1984 – otto anni
dopo – con l'Incontro internazionale anarchico in Campo
Santa Margherita e in altre parti di Venezia. Avremo modo di
parlarne, perché di “A” ne fummo informalmente
tra gli organizzatori.
Gran parte delle pagine restanti sono dedicate al 6° Festival
del proletariato giovanile, tenutosi dal 26 al 29 giugno di
quell'anno (1976) a Milano, al Parco Lambro. L'evento aveva
avuto un grosso impatto sui mass media sia per la notevole affluenza
di partecipanti sia per alcuni fatti di cronaca. La presenza
organizzata degli anarchici, provenienti da tutta Italia (e
la foto di un intervento al microfono del carrarese Goliardo
Fiaschi, da poco uscito da una lunga detenzione in Spagna e
in Italia, ne è testimonianza), era stata notevole non
solo in termini numerici. A caldo, la redazione di “A”
organizza una tavola rotonda alla quale partecipano Marina Candia
e Alberto Castelnuovo (della commissione animazione), Luciano
Lanza (della segreteria del festival), Massimo Varengo (della
commissione cultura e dibattiti) e Gabriele Roveda (della redazione
di “A”, come peraltro allora Lanza). In apertura
si precisa che la tavola rotonda non pretende di essere esaustiva
rispetto ai molti aspetti del festival, ma “è solo
un modo per aprire un dibattito sereno e approfondito sulla
condizione giovanile e sulle sue prospettive rivoluzionarie.
Questa tavola-rotonda non mancherà di sollevare osservazioni
e critiche, ne siamo certi. Il dibattito è aperto (...).”
Per quanto attiene la vita interna della rivista, si dà
conto della tredicesima assemblea di “A”, tenutasi
a Napoli l'11 luglio, con la partecipazione di una sessantina
di compagni, provenienti in grande maggioranza dalla Campania,
ma anche dalla Sicilia, dal Lazio e da altri centri. In quell'occasione
numerosi partecipanti all'assemblea, compresi i nostri redattori
presenti, andarono a trovare a casa sua Beppe Furia, un anarchico
residente con i suoi cari in un tipico quartiere super popolare
della città, gravemente handicappato, che non aveva potuto
essere presente.
Naturalmente sulla rivista non c'è traccia di quell'incontro.
Ma a chi vi partecipò, sono di sicuro rimasti impressi
nella memoria e nel cuore il coraggio e la dimensione poetica
e militante di Beppe, la calda ospitalità e umanià
della madre, il casino caratteristico dei vicoli, quel muro
della casa dirimpetto che sembrava di poter toccare con la mano
tanto era stretta la vociante via sottostante. Uno spaccato
di una Napoli che noi polentoni non conoscevamo, un ricordo
di Beppe che non ci ha mai lasciati.

|