
Le Br,
dalle grandi fabbriche alla sconfitta
La più duratura organizzazione della lotta armata in
Italia è stata oggetto di un'ampia pubblicistica concentrata
tuttavia in modo quasi esclusivo sugli eventi che hanno ruotato
intorno al sequestro dell'on. Aldo Moro e non sugli “anni
della formazione”. Come se le Brigate rosse, che nel 1978
operavano già da sette anni, fossero nate e si fossero
strutturate solo in vista dell'obiettivo finale di rapire lo
statista democristiano. Poca e superficiale attenzione è
stata invece dedicata alla nascita e agli albori dell'organizzazione,
intorno ai quali circolano ancora giudizi storiograficamente
imprecisi e rievocazioni solo giornalistiche sganciate da qualsiasi
contesto.
Il saggio di Andrea Saccoman (Le Brigate Rosse a Milano:
dalle origini della lotta armata alla fine della colonna “Walter
Alasia”, Unicopli, Milano 2013, pagg. 287) colma tale
lacuna e rappresenta una affidabile ricerca storica basata sullo
studio attento dei documenti provenienti dall'organizzazione
e sull'esame di prima mano degli atti processuali e che utilizza,
correttamente, solo come fonti secondarie le dichiarazioni degli
appartenenti alle Br, pentiti o irriducibili che siano, per
evitare rielaborazioni basate su racconti autogiustificatori
o autoelogiativi.
Grazie a tale metodo la ricerca di Saccoman consente di fissare
alcuni punti fermi: il luogo e la data di nascita delle Brigate
rosse, l'esordio delle loro azioni, la composizione sociale
e la provenienza dei suoi componenti.
Luogo di nascita è stato senza dubbio Milano, dalle cui
fabbriche provenivano i primi nuclei di brigatisti, con un apporto
limitato dal mondo universitario di Trento, fornito anche dall'interno
del cattolicesimo del dissenso, e del collettivo “gruppo
dell'appartamento” di Reggio Emilia, formato in parte
da ex militanti del Pci usciti dal partito su una linea “avventurista”.
L'arrivo a Milano da Trento di Renato Curcio e di sua moglie
Margherita Cagol e di Franceschini da Reggio Emilia sarebbe
stato tuttavia insufficiente a creare una nuova forza e avrebbe
aggiunto alla piazza solo qualche rivoluzionario di professione
in più se non si fosse incontrato con nuclei radicali
presenti in modo significativo all'interno delle grandi fabbriche:
la Pirelli, la Sit Siemens, la Magneti Marelli, la Breda, la
Falck, luoghi di lavoro dell'operaio-massa e ormai come tali
praticamente scomparsi
Certa è quindi l'origine operaia delle Brigate rosse,
a smentita di una percezione ancora diffusa che le vorrebbe
creazione di studenti e di piccoli borghesi frustrati, ed è
individuata con certezza nel saggio di Saccoman la loro data
di nascita: il convegno di Pecorile, un minuscolo paese dell'Emilia,
nell'agosto del 1970 che sancì il processo di uscita
delle Br dal bozzolo di Sinistra proletaria, involucro destinato
a estinguersi una volta terminata la sua funzione di incubazione
della nuova realtà. Una realtà che teorizzava
come ormai impossibile la lotta semplicemente politica e inevitabile
l'unificazione con il piano militare sulla base anche della
distorsione percettiva che giudicava parimente inevitabile lo
scivolamento a breve dell'Italia in uno scenario autoritario
e golpista.
La provenienza operaia, con l'abitudine alla disciplina del
lavoro e alla frugalità, ha certamente favorito quella
scelta strategica dell'organizzazione che nel saggio è
descritta con grande efficacia: l'assoluta clandestinità
dei militanti, applicata dalle Brigate rosse per prime dopo
la fine della guerra. Quindi sparizione dai luoghi di lavoro
e rottura di ogni legame familiare, assunzione di una nuova
identità e contemporanea “apparizione” di
un altro individuo, un “uomo senza qualità”
con regole precise: abita in una casa anonima e “compartimentata”,
conosciuta cioè solo dai militanti che la abitano e da
un altro componente della “colonna”, si inventa
una figura sociale, operaio, artigiano rappresentante e quindi
esce e rientra in casa a orari precisi, gentile ma riservato
con i vicini, non stringe rapporti sociali nel quartiere tanto
da non comperare i giornali sempre nella stessa edicola. Una
scelta obbligata per la guerra rivoluzionaria nella metropoli,
che tuttavia col tempo ha separato i militanti dalla loro base
sociale di riferimento e li ha distaccati dalla realtà.
Un aspetto, questo, poco studiato e, aggiungiamo, l'esatto contrario
dello stile di vita alternativo, della creatività rivoluzionaria,
dell'attenzione al “personale” che sono stati tra
i tratti salienti dei movimenti del '68.
È il 17 settembre 1970 la data della prima azione rivendicata
con il simbolo della stella a cinque punte, il banale incendio
della porta del garage dell'ing. Giuseppe Leoni, dirigente della
Sit Siemens, azienda che, tra azioni contro uomini e cose, sarà
colpita nel corso della vita delle Br per ben 30 volte.
Seguiranno i sequestri “volanti” di altri dirigenti,
fotografati con un cartello appeso al collo (il primo, Idalgo
Macchiarini, il 3 marzo 1972), la produzione “seriale”
delle gambizzazioni (la prima vittima è l'esponente democristiano
Massimo De Carolis il 15 maggio 1975) e delle uccisioni, fra
cui, tra le più efferate, la strage, nel gennaio 1980,
in un sottopassaggio di via Schievano, di tre agenti di polizia,
che nulla avevano a che fare con l'antiterrorismo.
A metà di questa catena di delitti, tutti descritti in
dettaglio nel saggio anche nei loro aspetti più curiosi
(una volta fu gambizzato un dirigente d'azienda scambiato per
un altro e il volantino di rivendicazione fu precipitosamente
corretto) si consuma alla fine del 1980 la scissione della colonna
Walter Alasia dall'esecutivo romano di Moretti e Balzerani,
accusato dalla componente “autonomista” milanese
di aver privilegiato un velleitario attacco al cuore dello Stato
a discapito dell'origine fondante delle Br e cioè il
collegamento con la classe operaia.
Per qualche tempo sono esistite dunque due Brigate rosse e poi
addirittura tre con la nascita a Napoli dell'ancor più
feroce Partito della guerriglia.
La fine della Walter Alasia milanese e dell'intera esperienza
delle Br storiche si consuma con lo smantellamento delle ultime
basi nel 1982, cui seguiranno, dopo anni di silenzio, le riedizioni,
dal 1988 in poi con gli omicidi Ruffilli, Biagi e d'Antona,
che tuttavia sono all'esterno del perimetro storico del saggio.
Perché le Brigate rosse, nonostante il primato di longevità
come organizzazione della lotta armata in Europa, hanno fallito
e si sono poi ridotte ad una variante marginale? Le ragioni
sia tattiche sia strutturali indicate nella conclusione del
volume sono tutte condivisibili.
In primo luogo sono scomparse le grandi fabbriche, serbatoio
di militanti e di simpatizzanti. Dove vi era la concentrazione
operaia della Pirelli-Bicocca sorge ora la seconda Università
milanese in cui è ricercatore proprio l'autore del saggio.
Sul piano generale, soprattutto dopo il sequestro di Aldo Moro,
le Br si erano infilate in un vicolo cieco. Per quanto ottusa
e corrotta fosse parte della classe politica, nella Dc come
in altri partiti, la sua impopolarità non fu mai tale
da spingere una parte significativa della popolazione italiana
anche solo ad augurarsi una soluzione rivoluzionaria guidata
dalle Br o da gruppi simili che mancava di una qualsiasi progettualità
di ampio respiro.
Oltretutto le Br non si erano nemmeno prese cura di descrivere
cosa avrebbero fatto dell'Italia se avessero vinto la loro guerra
contro lo Stato. Non esisteva in pratica una parte “costruttiva”
del loro progetto che facesse da specchio alla parte “distruttiva”,
ritmata dalle esecuzioni e dai volantini di rivendicazione.
Era possibile solo, e in modo più che giustificato, immaginare
che in caso di presa del potere avrebbero instaurato un regime,
ben lontano tra l'altro dall'anima libertaria del '68, molto
simile quello di Stalin e di Pol Pot: una prospettiva questa
di qualche attrattiva davvero per molto pochi.
Sul piano strategico era impensabile che una guerriglia urbana,
incentrata solo su azioni in alcune città, potesse avere
risultati decisivi. Anche i Gap del resto, i Gruppi di azione
patriottica che agivano nelle città, avevano avuto, durante
la Resistenza, un semplice ruolo ausiliario. E le Br non erano
mai riuscite nè avevano tentato di costruire anche solo
una parvenza di esercito regolare che agisse in montagna o in
altre zone non metropolitane del paese.
Sul piano tattico le azioni delle Br si erano poi disperse su
molti e troppi obiettivi: dirigenti di azienda, democristiani,
sindacalisti “revisionisti”, poliziotti, agenti
di custodia, giornalisti. Un vasto numero di obiettivi dà
certamente il vantaggio di rendere ardua l'azione di prevenzione
dello Stato (più numerosi sono i potenziali obiettivi,
più difficile è difenderli tutti) ma in tal modo
l'organizzazione armata non era riuscita a portare veramente
in profondità nessuna campagna. Anche durante le intermittenti
campagne contro i dirigenti di azienda, le carceri, i giornalisti,
nessuna azienda si era fermata per paura, nessun carcere aveva
cessato di funzionare, nessun giornale aveva interrotto le pubblicazioni.
Infine, benché attente alla pubblicità delle loro
azioni e ai mezzi di comunicazione di massa le Br si erano dimostrate
incapaci di costruire messaggi di una qualche efficacia: i loro
volantini e le loro risoluzioni erano monotone e ripetitive
come le loro azioni. In poche parole: illeggibili. Sono state
più studiate dai carabinieri che le analizzavano a fini
investigativi – e questo è un ricordo personale
di quando negli anni '80 ero giudice istruttore – che
lette da coloro che, operai, proletari, studenti, ne sarebbero
stati i naturali destinatari.
A questi fattori di sconfitta si deve unire, aggiungiamo noi,
il mutamento del quadro internazionale. Le Br non erano certo
dirette dall'esterno ma erano comunque nate all'interno della
Guerra fredda e lo spostarsi del conflitto dall'Est\Ovest al
Nord\Sud del mondo ha reso obsolete le loro analisi e la loro
pratica e quasi artigianali le loro azioni: una uccisione ogni
tanto, di fronte a nuove forze che con un modesto sforzo sono
riuscite a far crollare le Torri gemelle.
Chiudono il volume due documenti del tutto inediti, custoditi
presso la Fondazione Isec di Sesto San Giovanni e provenienti
dalla Federazione milanese del Pci: una dettagliata “indagine”
del partito su sospetti brigatisti presenti nelle fabbriche
milanesi e una confessione-relazione di un militante del Pci
della Sit Siemens, “sedotto” alla metà degli
anni '70 per breve tempo dalle Br, fitta di dati su coloro che
avevano cercato di reclutarlo.
A riprova del fatto che, per quante azioni di fuoco riuscissero
a mettere a segno, il destino delle Br, strette tra la tenaglia
delle forze dello Stato e del Pci che si muoveva dall'interno
della loro base sociale, era, anche nei momenti della loro massima
espansione, a lungo termine segnato.
Infine l'autore ha ricordato le difficoltà incontrate
negli anni nelle sue ricerche per reperire negli archivi giudiziari,
di difficile accesso e privi di una catalogazione se non per
numero dei processi, le sentenze e gli atti di indagine. Fortunatamente
tale ostacolo è stato da poco superato, grazie al lavoro
dei responsabili dell'archivio del tribunale di Milano, che
ha consentito di versare all'archivio di Stato di Milano gli
originali e in più la versione digitalizzata non solo
dei processi alle Br, ma anche sul terrorismo di destra, sul
caso Calvi- Sindona, sulla strage di via Palestro e gli altri
casi “storici”.
Un patrimonio che merita ancora di essere esplorato da studiosi
come Saccoman, con metodi storiografici e senza l'intento di
giudicare o di condannare ma quello di offrire ad altri gli
strumenti per leggere e per riflettere.
Guido Salvini
Musica/
InCanto sulla Martesana
L'attività poliedrica del complesso corale e strumentale
Martesana InCanto Ensemble (www.incanto.name) non è
solamente esecutiva, ma soprattutto creativa, nella forma di
un autentico laboratorio poetico e musicale, tramite la formula
del concerto tematico. Ogni esperienza concertistica risulta
strutturata all'interno di un contesto narrativo, costituito
dall'agile e sagace intreccio tra canti, testi e immagini, al
punto da connotarsi come autentica opera corale. Le musiche
proposte sono rielaborazioni di brani classici (Mozart, Haydn,
Clementi, Vivaldi, Brahms ecc.), oppure direttamente composte
dal maestro Bruno Belli, le parole dei canti sono tratte da
testi di poeti contemporanei o personalità storiche,
da Martin Luther King a David Maria Turoldo, da Gandhi a Piero
Calamandrei, da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a Vandana
Shiva e molti altri.
Lo spettacolo dal titolo “Con lo sguardo dei bambini”
spazia dalla rievocazione della storia, tramite la suggestione
delle poesie dei fanciulli internati nel ghetto di Terezin,
all'attualità del nostro presente, della contemporaneità,
nelle zone in cui l'infanzia è negata e violata dalla
guerra, dallo sfruttamento, dalla fame, dalla più atroce
sopraffazione sulle fragilità e diversità infantili.
Lo spettacolo “Desiderio di pace” presenta percorsi
di riflessione tramite il prisma del desiderio di fratellanza
e solidarietà, annientato dal lager, dai campi di sterminio,
nell'indifferenza della discriminazione, del razzismo, della
segregazione, ricordando l'alto prezzo pagato in vite umane,
per i diritti imprescindibili della persona sanciti dalla Costituzione.
Per approdare al nobile ideale della pace, le proposte musicali
spaziano attraverso gli stilemi della musica di Brahms e il
sapiente andamento delle strofe di Calvino, con un grande anelito
agli ideali di libertà, di lotta alla discriminazione
e al razzismo, tramite la partecipazione, l'impegno e la solidarietà.
Lo spettacolo “La musica non è indifferente”,
in un connubio tra pensiero razionale ed elemento emotivo trasforma
il contesto musicato in un potente mezzo di liberazione del
pensiero e di esercizio di tolleranza antidogmatico. Attraverso
le immortali parole di Martin Luther King, grazie alle quali
il sogno della pace diventa aspirazione alla consonanza, alla
ricerca dell'ideale di libertà, si giunge alla riflessione
musicale che, con brani adeguati, parte dai processi di liberazione
dall'oppressione dei regimi totalitari, per approdare all'esplorazione
delle condizioni di pace da coniugare con alti ideali di giustizia,
solidarietà e incontro di culture e diversità,
per comprendere noi stessi e la dignità umana, lungo
le strade della speranza, della progettualità, dei processi
di pace, di liberazione ed emancipazione anche femminile, vissuti
nell'interiorità e nella socialità. Il cuore dell'opera
corale “Variazioni sulla memoria” propone un percorso
di narrazione degli orrori della Shoah, tramite brani che raccolgono
la dolorosa testimonianza delle vittime, che si compongono,
come tessere di un mosaico di pace, con la rappresentazione
di altri eventi drammatici, ma anche capaci di smuovere le coscienze
e orientarle al cambiamento, nella solidarietà che sempre
sconvolge ed erode il potere, tramite piccoli passi, passaggi
e processi di pace che si alimentano di musica, pensieri e poesia
in un impianto corale, un autentico InCanto concertistico, che
vibra negli animi per far vivere l'anelito del grande sogno
della pace, contro ogni razzismo, contro tutte le guerre, contro
tutti i totalitarismi.
Laura Tussi
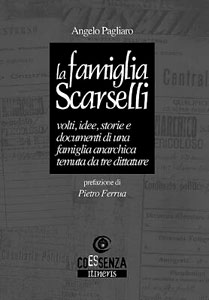 La
famiglia Scarselli/
Un libro. Un mito Correte a leggere la storia degli Scarselli, scritta da Angelo
Pagliaro. Vi accorgerete che è possibile fare del male
al Male. E che c'è stato chi s'è ribellato ai
fascismi, senza perdere la gioia.
La letteratura sui movimenti rivoluzionari ci ha abituato ad
una certa forma di schizofrenia. Da una parte i racconti aridi
di una storiografia farraginosa e specialistica, riservata ad
“eletti” ed “iniziati”; dall'altra i
salti onirici di un'affabulazione a tratti trionfalistica. In
mezzo, massacrate dall'editoria commerciale, dal carrierismo
accademico e da qualche produttore cinematografico a caccia
di emozioni forti, rimangono le carogne delle passioni politiche
e della verità storica. Che persino quando è perseguita
con strumenti certosini, si rivela diafana, inconcludente, criptica.
Grande assente, ai giorni nostri, è la mitopoiesi, la
produzione di mito. Qualcosa d'interessante è stato scritto
e pubblicato a ridosso del ciclo di lotte sociali del 2001.
Ma poi i movimenti antagonisti che si oppongono al Potere hanno
ripreso a parlare difficile. I santoni della conoscenza pickpocket,
quelli che borseggiano i produttori di sapere per infilarselo
in tasca e rivenderlo al miglior offerente, si parlano e si
capiscono da soli. E anche quando narrano qualcosa d'interessante,
finiscono per trasmettere depressione. Sembra si sia persa la
voglia di raccontarsi e sentire raccontare. Del resto la rapidità
con cui viaggia l'odierna comunicazione politica genera un effetto
illusorio. In apparenza, disponiamo di qualsiasi strumento comunicativo.
In realtà viviamo rinchiusi dentro il recinto di una
democrazia drogata. Così diviene inarrestabile la deriva
verso forme improbabili di partecipazione politica. E non ci
si può più aggrappare all'unico argine simbolico:
il piacere di sapere che è ancora possibile non solo
ribellarsi, ma anche giusto e divertente, visto che in tanti,
prima di noi, lo hanno già fatto. Sì, soffrendo,
spesso pagando con la vita e la libertà, ma sempre muniti
di una tendenza ideale alla ricerca della felicità. Da
trovare qui ed ora.
Lo spiega bene Domenico Liguori, della Fai di Spezzano Albanese
(Cosenza): “La storia reale è quella che va al
di là dei libri di testo scolastici, la storia di personaggi
cosiddetti minori”. Nell'ultimo decennio, è andato
in metastasi un male antico, quello della messa a profitto dell'intelligenza
sovversiva. La ricerca storica sponsorizzata dal neoliberismo,
anche quando mascherata da inchiesta genuina, ha continuato
a divorare miti, storie e simboli.
Potrà forse apparire retorico, quasi obsoleto, eppure
a segnare il confine tra la ricerca fine a se stessa e il sincero
lavoro politico c'è, come si diceva tanto tempo fa, una
questione “di classe”. Dipende quindi soprattutto
da chi scrive. Quando a farlo è un libertario
sincero, un attivista della ricerca autonoma, che dedica tutta
la propria esistenza alla ricostruzione di fatti diversamente
destinati all'oblio, il risultato è quanto meno dignitoso.
Nel caso de La famiglia Scarselli (edizione Coessenza,
Cosenza, 2012, pp. 211, e 10,00), Angelo Pagliaro è andato
al di là della semplice testimonianza, regalandoci un
testo che potrebbe a pieno titolo far parte della biblioteca
di ogni sovversivo, oltre che dei pochi sceneggiatori e romanzieri
liberi rimasti in circolazione. Ha ragione Katia Massara, docente
di Storia contemporanea presso l'Università di Arcavacata,
quando dice che quello di Pagliaro è un lavoro “generoso,
appassionato, ricco di umanità e dignità”.
È lo specchio di un'epoca, perché – aggiunge
la Massara – è solo apparentemente storia locale.
È una storia che è anche la storia della grande
famiglia libertaria”. E lo è ancor di più
perché la struttura del racconto è stata congegnata
per lasciar entrare il lettore nel laboratorio dello scrittore.
“Una struttura della narrazione molto interessante che
procede dall'esterno, una sorta di gioco di scatole cinesi in
cui l'aspetto politico acquista una forte tonalità emotiva.
Non è un caso che il testo inizia e termina con dei brani
intimi e familiari”, spiega Elena Giorgiana Mirabelli,
precaria della conoscenza, nonché editor della casa editrice
indipendente Coessenza.
Pagliaro riporta nel volume tutta la documentazione cui ha attinto
per tessere la tela di una vicenda umana e politica sinora confinata
nella dimensione del banditismo, grazie a questo lavoro finalmente
restituita alla sua reale natura. Gli Scarselli hanno vissuto
in mezzo alle dittature fascista, staliniana e brasiliana, e
sono riusciti a dare filo da torcere a tutte e tre, contribuendo
a lastricare l'impervia strada dei movimenti rivoluzionari del
secolo scorso. Grazie anche a loro, rimangono aperti i nostri
infiniti sogni di liberazione. È un libro antidepressivo.
Provare per credere, per arrabbiarsi, per sorridere.
Per ordinare il libro:
ordini.coessenza@libero.it
fax 0984/1862284
Claudio Dionesalvi
Note di lettura
su Valerio Evangelisti
| 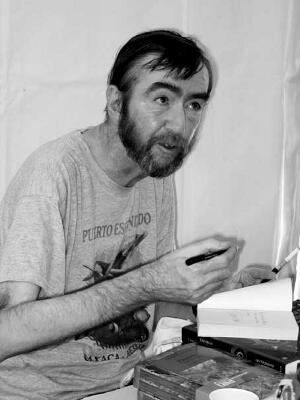
|
| Valerio
Evangelisti |
Valerio Evangelisti è uno scrittore da anni noto al
grande pubblico ed è anzi oggetto da parte di molti lettori
di grande interesse che, a volte, sconfina in una vera e propria
passione. È anche uno scrittore, per molti versi innovativo
e, nel contempo, capace di riprendere forme assolutamente tradizionali
della narrativa.
Se si scorre l'elenco dei suoi libri si può cogliere
la presenza di almeno due macrofiloni narrativi. Da una parte
vi sono opere riconducibili al fantasy, in particolare, ma non
solo, il ciclo di Nicolas Eymerich, un inquisitore, realmente
esistito ma completamente trasformato da Evangelisti, protagonista
di vicende che vedono spostamenti nel tempo e l'intervento di
esseri innaturali. In questo caso la scelta, spiazzante, di
un “cattivo” come personaggio principale permette
di guardare in maniera allucinata e originale a una serie di
eventi che si collocano alla frontiera fra la crisi culturale
determinata dalla fine dell'egemonia culturale della Chiesa
in Europa, sovrapporsi di diversi piani di realtà, sguardi
in un “futuro” che vede spinti agli estremi gli
aspetti più osceni del nostro oggi.
Dall'altra Evangelisti, almeno a mio avviso, riprende la pratica
classica del romanzo storico e da vita, per ora, ad almeno tre
serie di romanzi di questo tipo:
- il ciclo americano, famosissimi Noi saremo tutto e
One Big Union, che tratta essenzialmente della storia
del conflitto di classe e del sindacalismo radicale negli Usa
fra '800 e '900;
- il ciclo messicano che tratta delle vicende, appunto, del
Messico fra seconda metà dell'800 e prima metà
del '900 in stretta relazione con le contemporanee vicende statunitensi;
- il ciclo dei pirati collocati fra '600 e '700 che reinterpreta
la vicenda dei pirati che solcarono in quei secoli l'Atlantico
come anticipazione delle rivoluzioni borghesi che nella seconda
metà del '700 fecero saltare i vecchi equilibri.
Quando faccio riferimento al classico romanzo storico come modello
a cui Evangelisti si tiene – in maniera peraltro innovativa
–, intendo opere che ricostruiscono dettagliatamente vicende
storiche collocando al loro interno personaggi letterari.
È anche vero che l'opera di Evangelisti si distingue
significativamente da quella di Alessandro Manzoni o di Walter
Scott, i maestri del romanzo storico, su almeno due piani, quello
linguistico, caratterizzato dall'uso di uno stile secco e crudo
che molto deve alla lezione di Hemingway, Steinbeck e Dos Passos
e soprattutto quello del senso profondo delle sue opere.
Se infatti Manzoni e Scott descrivono punti di crisi che trovano
soluzione e superiore sintesi nelle fede religiosa e nel riconoscersi
in una cultura nazionale, in Evangelisti non vi è “salvezza”.
Che tratti dei pirati del Mar dei Caraibi, degli Iww (Industrial
workers of the world) o dei rivoluzionari messicani, le contraddizioni
di cui tratta rimandano da un romanzo all'altro e non hanno
alcuna soluzione.
Per Evangelisti, infatti, le contraddizioni che descrive non
oppongono “buoni” e “cattivi” o, meno
moralisticamente, progresso e reazione ma individui e gruppi
sociali che esprimono derive storiche che sembrano attrarre
l'autore essenzialmente da un punto di vista estetico, la storia
come un immenso arazzo vivacemente colorato. E così,
ad esempio, le vicende dei Cavalieri del Lavoro e degli Iww
statunitensi vengono narrate attraverso la biografia immaginaria
di un poliziotto privato infiltrato al loro interno per operare
alla loro distruzione, e quelle dei pirati caraibici attraverso
le vicissitudini di un ufficiale di Luigi XIV che opera come
agente di collegamento fra la flotta francese e quella dei pirati
che la supportano nell'assalto e nel saccheggio di Cartagena
e che, col tempo, anche a causa di una singolare passione amorosa
nei confronti di una nobildonna spagnola che è in realtà
un “agente” dell'anziano marito governatore della
città e che lo tradirà.
Nell'opera di Evangelisti, insomma, si intrecciano erudizione
notevolissima verificabile nella costruzione di ognuno dei suoi
cicli, rielaborazione in chiave letteraria di una passione politica
che ha caratterizzato la sua formazione, notevolissime curiosità
e spregiudicatezza intellettuale.
Una lettura insomma interessante e una sfida per chi, contemporaneamente,
sogna universi altri rispetto all'esistente e opera con l'obiettivo
di facilitarne la nascita.
Cosimo Scarinzi
|