letture
Vino e ribelli in terra d'Apua
di Franco Bertolucci
È uscito di recente l'ultimo libro
dello scrittore toscano Marco Rovelli, dedicato alla sua terra
d'origine, la provincia di Massa e Carrara. Ce ne parla il direttore
scientifico della Biblioteca Franco Serantini.
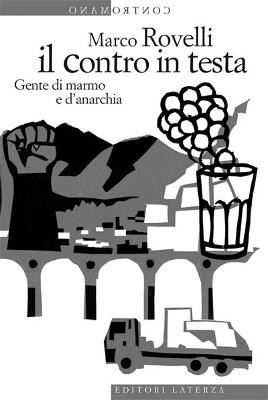 «Ho
odiato la mia terra come si odia una madre secca e muta, una
landa sterile e infeconda, un vuoto inabitabile e senza contorni.
L'ho odiata perché mi appariva come un magma informe,
impasto senza lievito. L'ho odiata perché non ne trovavo
l'anima. L'ho odiata perché, man mano che mi conoscevo,
temevo che non sarei stato altro da lei». Così
inizia il viaggio autobiografico di Marco Rovelli, scrittore,
musicista e insegnante di terra d'Apua, nato ai piedi di quelle
montagne che, come scrive, ospitano i «visionari». «Ho
odiato la mia terra come si odia una madre secca e muta, una
landa sterile e infeconda, un vuoto inabitabile e senza contorni.
L'ho odiata perché mi appariva come un magma informe,
impasto senza lievito. L'ho odiata perché non ne trovavo
l'anima. L'ho odiata perché, man mano che mi conoscevo,
temevo che non sarei stato altro da lei». Così
inizia il viaggio autobiografico di Marco Rovelli, scrittore,
musicista e insegnante di terra d'Apua, nato ai piedi di quelle
montagne che, come scrive, ospitano i «visionari».
Con una scrittura piana e vivace, Rovelli ci trascina in un
viaggio personale nelle viscere di una terra fatta di donne,
uomini e ribelli, tra leggende, mito e storia, di cui oramai
rimane solo una flebile traccia.
Rovelli nasce nell'anno successivo al Sessantotto studentesco:
il 1969 fu caratterizzato dalla grande contestazione operaia
– anno terribilis, che si chiuderà con la
strage di stato di Piazza Fontana e il “suicidio”
dell'innocente Giuseppe Pinelli, ferroviere anarchico, volato
giù dal quarto piano della Questura di Milano –.
Rovelli cresce culturalmente e politicamente negli anni '80,
l'epoca dell'ascesa di Craxi e dell'incubazione del berlusconismo.
Sono gli anni della deindustrializzazione, che per la provincia
apuana significa la dismissione delle fabbriche storiche di
tutta l'area del piano che va da Avenza a Massa, un'area nata
sotto il fascismo come risposta negli anni '30 alla grande crisi
del commercio del marmo.
È in questo scenario che Rovelli si imbatte nella leggenda
e nel mito delle genti ribelli di queste terre. L'incontro avviene
progressivamente con la scoperta dei luoghi, degli spazi e delle
montagne che sovrastano l'intero territorio. I luoghi sono le
piazze e le strade di due città rivali ma vicine, Carrara
e Massa, con le loro diverse origini, i loro monumenti e le
loro lapidi. Queste città, pur con le loro diversità
storiche, urbanistiche e delle loro genti, nonostante tutto
sono unite da un indissolubile destino comune.
Massa, politicamente moderata, è una città influenzata
dal suo ruolo amministrativo e istituzionale, ed esprime sul
piano sociale un riformismo gradualistico.
 L'Oro
bianco e il vino di Candia L'Oro
bianco e il vino di Candia
Carrara è invece la città del marmo, dai forti
contrasti sociali che contrappongono la borghesia industriale
a un proletariato forgiato dal duro lavoro dell'estrazione dell'“oro
bianco” e istintivamente ribelle. La città è
ancora oggi attraversata spesso dalle ritualità laiche
e libertarie dei cortei del primo maggio che bene testimoniano
lo spirito e la fede delle sue genti agli ideali antiautoritari.
Un approccio istintivo all'anarchismo con alcune venature mistiche,
dove spesso l'adesione agli ideali libertari è vissuta
come una “religione laica”.
In mezzo a queste due realtà c'è poi Forno, un
borgo che rappresenta l'anello di congiunzione tra la tradizione
politica moderata della prima e il ribellismo della seconda.
Gli spazi per eccellenza dove si tramanda la memoria di questi
territori sono le osterie con i loro personaggi verghiani, che
si affrontano, con duelli di parole e pensieri, sbicchierando
il profumato vino di Candia.
Le montagne che fanno da spettacolare palcoscenico a entrambe
le città sono gli incredibili e affascinanti bacini marmiferi
delle Alpi Apuane – definite da Rovelli «montagne
resistenti».
L'impatto con questo mondo permette a Rovelli di conoscere e
raccontare la sua storia rovesciata – quella con l'esse
minuscola – della società locale, la storia dei
“vinti”, dei subalterni, dei “senza volto”,
e delle loro utopie, delle loro contraddizioni, della loro caparbietà,
in specie per i carrarini – dura come il marmo –
che ne caratterizza lo spirito «insuscettibile di ravvedimento».
Racconta Silvano, uno dei personaggi che Rovelli incontra in
osteria, della «differenza ontologica» tra la gente
di Massa e quella di Carrara: «Il massese è molle.
È rimasto sempre un contadino, servile. Il carrarino
no, il carrarino non si piega, è fiero, schiena dritta.
Ha il contro in testa il carrarino».
«E che significa?».
«Per spaccare il marmo devi capire qual è la linea
giusta, il suo verso. Se la segui, tagliarlo è facile.
Se invece provi a tagliarlo diciamo al contrario, se vai contro
il verso, non ci riesci: non c'è verso, proprio. E quello
si chiama contro.
Ecco, i carrarini hanno il contro in testa, sono duri, resistono,
e non c'è verso di scalfirli. Non c'è il verso,
proprio».
Fantasmi di un passato remoto, che a volte riappaiono nell'oscurità
delle fiaschetterie che raccontano di donne e uomini i cui nomi
– Taro, Ciac, Pedro, Franca, Evaristo, Ometto, Conte Giò,
Rina, Ovidio Pegollo e tanti altri – sembrano usciti da
un film di Fellini, ai più non dicono niente ma in quei
luoghi sono una parte attiva della memoria orale collettiva.
Custodi di un tempo e di una storia che l'oblio tende a cancellare
e a volte esse stessi vittime di un mito – quello della
città “anarchica” per eccellenza –
che tende a fagocitare la storia stessa del movimento libertario.
Come dice l'autore del libro «il selciato di Carrara è
ingombro di memoria».
Dalle conversazioni e dalle sbicchierate in osteria escono altri
nomi come quello di Alberto Meschi, Galileo Palla, Gino Lucetti,
Pietro Gori, Ceccardo Roccatagliata Ceccardi, Ugo del Papa ecc.
e momenti di storia collettiva come i Moti di Carrara del 1894;
la rivolta delle donne di Piazza delle Erbe contro gli occupanti
nazi-fascisti del 1944 e le incredibili vicende del movimento
resistenziale apuano; le manifestazioni di Lotta continua –
il ricordo della presenza di Adriano Sofri a Massa – dei
primi anni Settanta; la dura agitazione contro la Farmoplant
– industria chimica della “morte” –
degli anni Ottanta; le rivendicazioni dei Cobas del marmo –
guidati da Giovanni Pedrazzi detto «Pedro» –
sull'uso civico degli agri marmiferi negli anni Novanta del
secolo scorso (un bene comune delle comunità locali espropriato
dalla borghesia industriale nel XIX secolo).
Infine, altri personaggi animano questo racconto, con storie
diverse come quella di Gogliardo Fiaschi, dei compagni del Circolo
Bruno Filippi, fino alla vicenda di Ovidio Bompressi. È
bene precisare che questo non vuol essere un libro di storia.
Il racconto si alimenta delle storie biografiche di alcuni ribelli,
che per vari motivi hanno attraversato l'immaginazione e il
cuore di Rovelli. Queste vicende sono un approccio personale
e letterario a una storia, quella del movimento anarchico della
zona, che è assai ben più complessa, articolata
e ricca di personaggi.
 Uno
sguardo al passato Uno
sguardo al passato
La lettura delle pagine di questo libro che, a volte, risente
positivamente anche di un taglio antropologico, ci immerge altresì
nella particolare cultura del lavoro di queste terre, sui mille
mestieri che animano l'antica estrazione del marmo. Un mondo
anch'esso in via di estinzione a causa dell'insensato e selvaggio
industrialismo che, oltre a far scomparire il lavoratore di
mestiere, ha ridotto queste bellissime montagne in un groviera
con mille problemi ambientali.
Un libro per la memoria perché, dice Rovelli, in «assenza
di futuro non restava che rivolgersi al passato», alla
ricerca di quel «conduttore elettrico» che ha contribuito
a illuminare la storia sociale e politica di questa terra. Racconti
nel racconto, quasi generazionale, di una generazione «orfana»
dei «padri dell'anarchia e dell'utopia» che non
sa darsi pace dell'inevitabile avanzare delle acque del fiume
mitologico Lete che ogni memoria distrugge. Un processo che
porta Rovelli a domandarsi «dove sono finiti tutti quei
ribelli» e «dove sono finiti quei sogni?».
Risposte non ce ne sono, questa non è più l'epoca
delle grandi certezze delle ideologie e poi questo è
un racconto, non un libro di sociologia o di filosofia politica
ed è giusto che il lettore provi da solo a immaginare
e sognare le proprie risposte a una crisi epocale che attraversa
l'intera società come, inevitabilmente, anche l'anarchismo
contemporaneo e che angoscia anche l'autore di questo libro.
Rovelli chiude il proprio racconto lasciando aperta una finestra
sul futuro, quando descrive la lotta di un gruppo di migranti
nel Duomo di Carrara, di cui egli stesso è partecipe:
«Ecco, qui, nel centro della città, dove ci sono
lavoratori senza diritti che li rivendicano, è qui che
io ritrovo finalmente lo spirito di una terra che non sentivo
più mia. È qui che trovo la resistenza viva, vibrante,
gioiosa, piena di speranza, che guarda all'avvenire. È
qui che i fantasmi smettono di essere tali, e tornano a essere
lo spirito di corpi che agiscono e costruiscono un mondo».
 Franco Bertolucci
Franco Bertolucci
Ecco qualche stralcio dal libro di Marco
Rovelli
“Differenze ontologiche”
All'osteria mi insegnarono il brindisi alla carrarina. Perché
questa è un'osteria della campagna massese, sì,
ma sta appena sotto le colline del Candia, e il Candia richiama
anche i carrarini. Uno di loro mi ha preso per un braccio una
sera che si cantava, “Vieni qui che ti offro un bicchiere”,
e tu mica puoi dirgli che ce l'hai già sul tavolo e ne
hai bevuto anche tanto, è buona educazione accettare.
Beve, e alza il bicchiere, anzi il bicierin, il “goccio
di vino” che si può scolare tutto d'un fiato. Brinda,
e quel brindisi somiglia molto a un rito. Si leva il bicierin
in alto, lo si fa digradare verso terra, poi lo si porta a sinistra
e infine a destra: un segno della croce, insomma, e l'importante
è che l'occhio non perda mai di vista il vino. Si salmodia
nel gesto apotropaico: “ciar i è ciar – muss'lin
a ni né – te 'n t'l vo – te nemanc –
al bev me” (chiaro è chiaro – moscerini non
ce n'è – te non lo vuoi – te neanche –
lo bevo io). Va da sé che si pronuncia l'ultimo verso
levando il bicierin alla bocca per assimilare il Verbo.
“Sai qual'è la frase migliore per definire il carrarino?
Il contro in testa”.
Silvano veniva di tanto in tanto all'osteria, e mi diceva della
differenza ontologica tra massese e carrarese.
“Il massese è molle. È rimasto sempre un
contadino, servile. Il carrarino no, il carrarino non si piega,
è fiero, schiena dritta. Ha il contro in testa il carrarino.”
“E che significa?”
“Per spaccare il marmo devi capire qual è la linea
giusta, il suo verso. Se la segui, tagliarlo è facile.
Se invece provi a tagliarlo diciamo al contrario, se vai contro
il verso, non ci riesci: non c'è verso, proprio. E quello
si chiama contro.
Ecco, i carrarini hanno il contro in testa, sono duri, resistono,
e non c'è verso di scalfirli. Non c'è il verso,
proprio.”
Il marmo è come la vita, morbido al verso e duro al contro.
“Solo che avere il contro in testa non è facile.
È un bel fardello da portare. Che se ti trovi in periodi
di piena va bene, sei un ribelle, ti unisci con gli altri e
allora guai a chi vi tocca. Se Carrara è terra di anarchici
ci sarà un motivo no? Ma in tempi di secca, quando nessuno
ha speranze di trasformare questo mondo, allora avere il contro
di testa non è bello, vai contro il tuo vicino, il tuo
compagno, il tuo amico. Tutti a parlar male dell'altro, a farsi
guerra l'un con l'altro. Non è bello.”
Silvano alzò il bicchiere e se lo scolò d'un sorso.
Niente brindisi. “È un mondaccio questo. E mi sto
stufando di questa terra.”
***
Piazza Gino Lucetti
Silvano l'ho incontrato di nuovo dopo alcuni anni, tra le bandiere
nere e rosse alla fine del corteo del primo maggio anarchico
a Carrara. Un corteo di canti, una ritualità antica,
corone di fiori rossi alle lapidi. Tante. Troppe, visto che
dietro ognuna di quelle lapidi c'è una vittima da ricordare.
Le vittime dei moti del 1894 alla caserma Dogali, Giordano Bruno
in piazza del Duomo, Alberto Meschi storico sindacalista d'inizio
novecento, e per finire i morti alle cave e Francisco Ferrer
educatore anarchico, le due lapidi che stanno nella piazza dove
arriva il corteo. La piazza ufficialmente si chiama piazza Alberica
– dal duca Alberico I dei Cybo Malaspina, il sovrano che
la volle nel Seicento –, ma per gli anarchici continua
a essere piazza Gino Lucetti, l'anarchico che attentò
a Mussolini e per un soffio lo mancò, in un tragico impeto
di sfortuna: la bomba rimbalzò sul tetto della macchina
del Testa di Morto, esplodendo solo toccando terra e ferendo
sei persone plaudenti. Lucetti venne condannato all'ergastolo.
Nel 1943, all'arrivo degli alleati, Lucetti fu liberato dal
carcere di Santo Stefano, una delle isole ponziane, ma riuscì
a vivere libero solo per pochi giorni: arrivato a Ischia, il
17 settembre morì sotto un bombardamento aereo tedesco.
A Lucetti venne dedicato il battaglione partigiano libertario
sui monti apuani, a lui venne dedicata la piazza, che nel 1960
tornò all'antica denominazione per gli stradari ufficiali.
Non per gli anarchici però, che nei loro manifesti di
convocazione della giornata continuano a scrivere “piazza
Gino Lucetti”.
[...]
“Anche le pietre sono anarchiche”
A percorrere la strada della Foce – una strada in collina
con i boschi che di tanto in bruciano, tra piccole cave e case
sparse – mi sono sforzato di vedere il fantasma che ha
segnato l'immaginario di questa terra: quello delle plebi in
sommossa durante i moti del 1894, alla cui lapide sulla caserma
Dogali si mette la corona di fiori il primo maggio.
Mi è sempre piaciuta questa storia. Sui manuali dei licei
c'è scritto moti di Lunigiana, perché ancora nell'ottocento
Lunigiana comprendeva Massa e Carrara (mentre oggi si intende
unicamente l'entroterra, da Aulla a Pontremoli, che con le due
città di costa non ha molto a che spartire). Furono,
in realtà, moti di Carrara e, in sottordine, di Massa.
Era sulla strada della Foce che una delle bande degli insorti
aveva eretto la prima rudimentale barricata, fermando due carri
trainati da buoi, carichi di blocchi di marmo, e mettendoli
di traverso. Era il 13 gennaio, e l'insurrezione carrarina avrebbe
contagiato l'Italia, i dimostranti ne erano certi. Del resto
in Sicilia il fuoco era già stato appiccato, dai Fasci
Siciliani, e in parecchie altre città a dimostrare erano
grandi folle. La banda che veniva da Ortonovo aveva con sé
una bandiera nera, orlata di rosso, con scritto in caratteri
d'oro: Fascio Operaio. Era la rivoluzione.
“Domani i soldi italiani non hanno più valore perché
deve entrare un nuovo governo”, si diceva in giro. Riportano
le relazioni di polizia che un tale Alessandro Merlini disse
a un tale Andrea Spagnuoli, il quale stava andando a trovare
la fidanzata: “questa sera non si fa l'amore perché
dobbiamo andare a Carrara a fare la dimostrazione”. Quella
dimostrazione a cui l'amore andava sacrificato doveva essere
la scintilla della rivoluzione. Dopo la scintilla della Foce,
si mossero le genti dei paesi di montagna – e non solo
di quella carrarina, anche di quella massese. Ma tutto si risolse
in un massacro. Non riuscì l'effetto sorpresa, le bande
non presero il controllo della città, e quando arrivò
l'esercito la manifestazione delle genti di montagna venne repressa
nel sangue: fucilate sui quattrocento che avanzavano, dieci
morti sul terreno.
A Massa venne instaurato il Tribunale di Guerra, che in tre
mesi comminò 454 condanne per oltre 2500 anni di carcere.
Più del 60 per cento dei condannati erano cavatori. Su
542, 68 erano massesi, in maggioranza dei paesi della montagna.
Galileo Palla, anarchico lunigianese trapiantato a Massa, che
sulla montagna massese aveva predicato il verbo anarchico, ed
era definito nei documenti di polizia “il primo della
lista degli anarchici più pericolosi della Provincia
di Massa Carrara”, ebbe a dire che “in Carrara anche
le pietre sono anarchiche”: ebbene, questo anarchismo
non poteva non spargersi come polvere di marmo su tutto il territorio
circostante.
Lo stesso Palla aveva scritto due anni prima agli anarchici
di Massa, in un momento di crisi politica (pareva ch'essi volessero
appoggiare l'elezione di un deputato): “Sappiate imitare
Carrara, consorella di Massa.” Due città sorelle,
dunque. È questo punto, prima e al di là delle
differenze. Tanto è vero che a innalzare le barricate
sulla Foce era stata quasi certamente una banda di cinquecento
persone scese dalla montagna massese.
“Il contro in testa, Valè, ce l'hanno anche i massesi.
Quelli del piano no, solo qualcuno. Ma quelli della montagna
di sicuro. Più vicini stanno alla montagna, più
hanno il contro in testa. È la montagna a fare resistenza.”
Così aveva detto Carlo all'osteria urlando a Silvano.
Poi aveva tirato l'ultima bestemmia e se n'era andato a casa.
“Sì”, aveva borbottato Silvano come se Carlo
ci fosse ancora, “ma i fascisti son sempre stati tutti
massesi”. E si era ripreso l'ultima bestemmia, che spettava
a lui.
[...]
Bandiere
C'è tutto questo sovraccarico di sensi e di emozioni
in gioco, in questa terra, sensi ed emozioni che traboccano
e ci fanno figurare una realtà diversa da quella che
in realtà è. Accadde a José Seves, lo storico
leader degli Inti-Illimani, quando sbarcò a Carrara per
un concerto. Appena fuori dall'autostrada, appesi ai pali dei
cartelloni pubblicitari, c'erano due enormi bandiere rossonere,
il vento le faceva sventolare, era come se un'icona si palesasse
per come la si è sempre figurata: “Carrara, sì!”,
esclamò felice e tonitruante José, “la patria
dell'anarchia!”. Un istante dopo, la sua voce fu sommersa
dai clacson di un corteo di auto, tutte imbandierate di rossonero:
e fu facile accorgersi che non era per il trionfo della rivoluzione
anarchica, ma per la vittoria dello scudetto del Milan.
 Marco Rovelli
Marco Rovelli
Il contro in testa
gente di marmo e d'anarchia
Marco Rovelli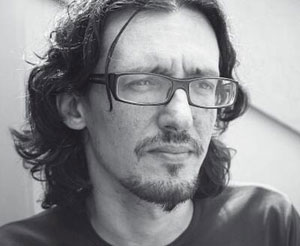
L'Apuania – Massa e Carrara – è sempre
stata terra di ribelli, anarchici, partigiani, sovversivi.
Terra di confine, terra di margine: e nei suoi margini
si articola questa storia, tra osterie, montagne, cave
di marmo, boschi e pastori, alla ricerca delle testimonianze
di quel passato ribelle, per vedere quanto è
ancora presente, e per vedere se c'è un avvenire.
Quegli “uomini che non ci sono più”
hanno ancora qualcosa da insegnarci? Possono ancora
parlarci? Sono solo fantasmi dissolti in una mitologia
passata o le loro tracce possono essere ancora seguite?
Un intreccio di storie visionarie, con percorsi eccentrici:
dal Taro, ultimo partigiano anarchico che custodisce
il circolo dei libertari a Ovidio Pegollo, fondatore
con Sofri di Potere Operaio, embrione di Lotta Continua.
E poi cavatori, pastori, veggenti, operai. E tanto vino,
visto che la narrazione si articola attorno ai tavoli
delle tante osterie.
In una terra che dagli anni ottanta pare aver smarrito
la propria identità, presa nella morsa di una
crisi economica, ambientale, culturale, che ha di fatto
anticipato un processo più generale che ha riguardato
l'intero paese, l'autore si fa voce narrante alla ricerca
di storie, voci che s'infilano una dietro l'altra per
restituire la verità di una storia che possa
essere ancora viva e vibrante.
Marco Rovelli
Il contro in testa: gente
di marmo e d'anarchia
Roma-Bari, Laterza, 2012, pp. 144, €
14,00.
|
|