|  1.
Nel 1940, l’editore Giuseppe Caregaro inizia le pubblicazioni
di Cucciolo, un fumetto disegnato, prima da
Rino Anzi e poi da Giorgio Rebuffi. Come il titolo suggerisce
Cucciolo – e il suo compagno Beppe – nascono come
cani antropomorfi, ma, assumendo presto sembianze umane, cambiano
natura. Il che, peraltro, non impedisce al lettore di rendersi
conto di quanto personaggi e vicende loro siano ricalcati sul
modello dell’ormai famoso Topolino. 1.
Nel 1940, l’editore Giuseppe Caregaro inizia le pubblicazioni
di Cucciolo, un fumetto disegnato, prima da
Rino Anzi e poi da Giorgio Rebuffi. Come il titolo suggerisce
Cucciolo – e il suo compagno Beppe – nascono come
cani antropomorfi, ma, assumendo presto sembianze umane, cambiano
natura. Il che, peraltro, non impedisce al lettore di rendersi
conto di quanto personaggi e vicende loro siano ricalcati sul
modello dell’ormai famoso Topolino.
Cucciolo
è piccolo abile e sagace, fin saccente, mentre l’amico
Beppe è lungagnone e tonto; combattono a volte contro
il cattivo Bombarda che ricorda Pietro Gambadilegno e sono zii
di tre nipotini dal nome di Tip, Top e Tap. Direi che ce ne
sarebbe stato abbastanza per sfiorare il plagio, ma, dovrei
anche ammettere che, in definitiva, non deragliava dalla logica
del sottoprodotto.
Nel 1952, tuttavia, grazie all’inventiva
di Roberto Renzi, nel fumetto si intrufolò un nuovo personaggio
– un personaggio che oltrepassava il filo dell’assurdo
come Eta Beta nel fumetto disneyano. “Figlio del caucciù
e della colla”, poteva allungarsi a dismisura e da linea
trasformarsi in punto a seconda delle necessità riparatorie
che la morale della narrazione gli imponeva. Ebbe un successo
che travalicò lo stesso Cucciolo, guadagnandosi,
anni dopo, una propria autonomia. Si chiamava Tiramolla.
2. Nei dolorosi episodi della vita
quotidiana del protagonista della Dolce vita
– nel frenetico ed eccitante nulla che avvolge il bel
Marcello in cerca di non si sa bene cosa –, Federico Fellini
inserisce una festa notturna in cui, nelle modeste forme in
cui le si poteva rappresentare alla fine degli anni Cinquanta,
sesso alcol-droga e rock and roll, i tre mercati dell’ormai
prossimo futuro – i tre miti del consumismo capitalistico
– fanno la loro comparsa con particolare virulenza.
A distanza di molti anni, commisurare le cose al contesto in
cui sono espresse non è facile, ma, se ce n’è
una di cui si può essere sicuri questa è l’intenzione
fortemente critica di Fellini: il suo protagonista è
il giornalistucolo che si adatta a vivacchiare delle briciole
del “bel mondo” nell’ambizione di diventare
prima o poi un grande scrittore; le relazioni che gli capitano
sono di quelle in cui non ci si sa dir nulla e in cui dall’amore
si rifugge come da un impiccio letale; la società in
cui si impantana è quella di chi può permettersi
di non lavorare, di passare la notte in bianco e di essere sorpresi
sgomenti con la bocca impastata da un’alba che fa paura.
La dolce vita, dunque, è un miraggio
per allocchi e bugiardi – innanzitutto, bugiardi con se
stessi –, sembrerebbe dirci Fellini: quella vita non è
affatto “dolce”, ma è di una dolcezza nauseante,
eccessiva, tanto da renderla amara. Nonostante quella vita fosse
in parte anche la sua – nonostante se avesse una dimestichezza
esperta, per così dire –, il suo, indubbiamente,
è un monito: da questo supermercato di sesso, alcol-droga
e rock and roll alla nostra socialità non ne sarebbe
derivato nulla di buono. Gioverà a questo punto ricordarci
che, nel film, interpretando se stesso, la rappresentazione
del capo d’accusa al rock and roll è toccata ad
Adriano Celentano.
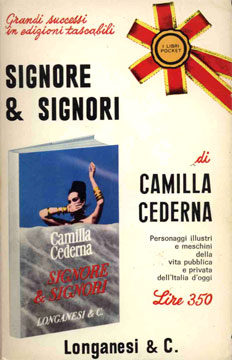
3. In Signore e signori,
un libro del 1969, la scrittrice e giornalista Camilla Cederna
racconta della circostanza in cui fece un’intervista ad
Adriano Celentano. Era il 29 settembre del 1963 e quello che
all’epoca meritava l’appellativo di “re del
tangaccio” la ricevette a Milano, a casa della mamma.
Fu l’occasione, per la Cederna di correggere un dato storico.
Celentano non cominciò la propria carriera all’Aretusa,
come credeva lei, ma alla sala da ballo Filocantanti di viale
Zara, cantando L’orologio matto (Rock
round a clock) il che, per uno che faceva l’operaio
specializzato presso un orologiaio di viale Campania, poteva
anche essere interpretato come un segno di straordinaria coerenza.
Fu anche l’occasione, l’intervista, per ascoltare
in anteprima Sabato triste, una canzone rigorosamente
maschilista in cui si parla di un lui che torna a casa, lei
non c’è e non c’è nemmeno il pranzo
pronto e lui s’imbestia perché ha fame.
E fu anche l’occasione, questa intervista per dare un’occhiata
in giro e farsi un’idea della persona. La Cederna nota,
allora, che, vicino al caminetto, era stata posta una piastrella
propiziatoria su cui stava scritto “Santa Maria Goretti
proteggi questa famiglia” e registra un paio di osservazioni
che riguardano la fidanzata di Celentano, Milena Cantù
– lì presente – che, anni dopo, a dire il
vero – contraddicendo la logica hegeliana della loro relazione
–, di cantante ne sposerà un altro – Fausto
Leali. Milena, dunque, come Adriano, porta al collo una mezza
medaglia che è quasi un manifesto teorico: “Divisi
ma – sempre uniti”, c’era scritto.
La seconda osservazione della Cederna concerne il fatto che,
durante l’intervista, la Milena, interpretando alla perfezione
lo stereotipo di femmina che il suo maschio esigeva, si è
ben guardata dall’intervenire ed ha preferito sprofondarsi
nella lettura.
Cosa leggeva, alla Cederna, ovviamente, non è sfuggito:
leggeva Cucciolo, un’antologia di Cucciolo,
per l’esattezza.
14. Il tempo passa e i cocci sono
nostri. Dell’aria che tirava in casa Celentano, pur lastricati
delle migliori intenzioni, sono fatti i criteri con cui giudica
la società e i meccanismi del potere che la governa.
Delle relazioni fra capitale e lavoro, fra lotta sociale e religione
– della stessa relazione fra Chiesa e Paradiso –,
fra maschile e femminile, lui vede quel che può e quel
che gli conviene – soprattutto non vede né se stesso
né quanto della sua propria storia è bersaglio
attuale dei suoi strali. Nell’enciclopedia mentale del
molleggiato – si noti la radice dell’aggettivo –,
nei sottoprodotti che costituiscono la sua cultura, qualcosa
– parecchio – di Tiramolla e della tecnica immaginaria
con cui riparava i torti è rimasto. Come di Cucciolo,
diviso e unito per sempre – alla faccia di ogni contraddizione
– a quel Beppe che, peraltro – anche e non solo
per l’aspetto fisico –, a Celentano sarebbe stato
più congeniale.
 Felice Accame
Felice Accame
Nota: Signore e signori
di Camilla Cederna è pubblicato da Longanesi, Milano
1969. Della visita a casa Celentano si parla da pag. 153 a pag.
158.
|