|
 Omaggio
a Lucio Dalla Omaggio
a Lucio Dalla
La morte di Lucio Dalla ha folgorato quanti erano come abituati
alla sua permanenza sui media italiani: era uno di quei personaggi
che ti paiono immortali, perché te li ricordi, si può
dire, da sempre. Non pareva potesse finire.
Dalla non si è risparmiato, si è impegnato a fondo
nel suo mestiere e in un mucchio di altre cose a volte contraddittorie
fra loro. Certamente è stato un grande operatore musicale.
La morte se lo è pigliato in corsa, fra un concerto dato
la sera prima e un altro a venire, con moltissime cose fatte,
ma con dei progetti ancora da realizzare. Magari un po’
troppo presto, ma quanto al modo… ci metterei la firma!
Lucio Dalla è stato un genio della canzone italiana,
però – lo dico subito sperando di non offendere
nessuno – è stato anche un cialtrone. Le sue prime
canzoni erano interessanti, fra quelle ogni tanto delle perle
di gusto popolare: le notissime “4 marzo ’43”
e “Piazza grande”, presentate al festival di Sanremo.
A partire da lì Dalla si costruisce una vocalità
ispirata al canto Soul applicato alla nostra lingua,
uno stile inimitabile che riesce ad appaiare la colloquialità
all’epica, l’ironia allo strazio. Attentissimo agli
arrangiamenti, nel suo primo periodo non produce i testi delle
sue canzoni. Il personaggio bizzarro, multiforme, clownesco,
comincia da subito a sfondare lo schermo in TV.
È all’inizio degli anni ’70 però che
Dalla – forte dei due successi Sanremesi – convince
i discografici a un’impresa suicida dal punto di vista
commerciale, la collaborazione per tre dischi col poeta Roberto
Roversi. Ne parliamo più avanti.
Finita la collaborazione con Roversi, Dalla pare uscito da un
lungo apprendistato e inizia a scrivere da sé i propri
testi e pubblica, uno di seguito all’altro, 5 lp e un
EP che sono dei capolavori. 1977 “Com’è profondo
il mare”. 1979 “Lucio Dalla”. 1980 “Dalla”.
1981 l’EP “Lucio Dalla”. 1983 “1983”.
1984 “Viaggi organizzati”.
Sono dischi ai vertici della produzione mondiale, dischi di
indiscutibile bellezza, sperimentali e popolari, cantati con
una musicalissima rabbia, con dolcezza abbacinante, arrangiati
e suonati stupendamente.

Parabola ineguale
Dopo di ché il diluvio – tranne qualche
rara singola canzone passabile – Dalla decade d’improvviso:
i testi si banalizzano, le musiche si dissanguano, si fanno
aperte, incerte. Persino il gusto squisito per i suoni e la
voce paiono appannati.
Il personaggio è solidissimo, quasi tutte le sue operazioni
dal punto di vista commerciale e mediatico sono successi enormi.
Ma cos’è successo alla sua creatività? Chi
lo sa?… invano aspetteremo, per oltre vent’anni,
un Dalla ai livelli del suo periodo migliore. Ora, dopo la conclusione
del percorso, possiamo comunque testimoniare che la parabola
ineguale di Dalla resta una delle esperienze più profonde
e consistenti della musica di questo paese.
Voglio qui riproporre un frammento del mio saggio “La
canzone che fa la storia” compreso nel volume a cura di
Isabella Zoppi “Dalla città, le montagne”
edizioni Nota, 2009. Il saggio indaga in tre momenti distinti
la storia della città di Torino attraverso la canzone
d’autore impegnata. Il secondo momento è appunto
la trilogia Dalla-Roversi.
«Il ciclo dei tre dischi che si esaminano in questo capitolo
è quanto di più ardito e maturo la discografia
leggera italiana abbia prodotto, di certo fino a quel momento,
probabilmente fino a oggi. (…)
All’inizio degli anni ’70 cresce anche in Italia
un movimento musicale che si ispira alle forme più complesse
del Rock alternativo, del Progressive e della Psichedelia; nell’insulso
beat italiano si fa strada l’esigenza di testi di ricerca,
di moduli compositivi molto elaborati, di prese di posizione
nette. All’avanguardia di tale percorso troviamo i gruppi
AREA e Stormy Six. Intanto da Roma e dalla fucina creativa del
Folkstudio – un piccolo live club – la canzone d’autore
si sta forgiando la rivincita con un nuovo linguaggio, meno
francese e più americano, che presto esploderà
anche commercialmente: hanno appena iniziato le loro carriere
Francesco De Gregori e Antonello Venditti, cui danno man forte
da Bologna Francesco Guccini e Claudio Lolli.
Dunque c’è un incredibile affastellarsi di proposte
in poco più di una diecina d’anni. In questa situazione
magmatica e ricca di stimoli ci si trova spesso di fronte ad
artisti che cambiano bruscamente il corso della loro vita pubblica,
emblematico il caso di Giorgio Gaber, che da gradevole fantasista
televisivo si trasforma nel più intelligente e feroce
fustigatore delle idee comuni.
Fra tutti questi artisti ce n’è uno che non è
più un bambino, compie in quel 1973 trent’anni;
da sempre sulla scena, sente comunque di non aver ancora composto
un’opera all’altezza delle sue potenzialità.
Ha una solida formazione jazzistica, una perizia musicale non
comune, suona pianoforte e clarinetto.
A un angolo della vita incrocia un bolognese come lui, di una
ventina d’anni più vecchio, Roberto Roversi, un
poeta con gli allori, animatore della rivista “Officina”
con Pasolini, uno sperimentatore linguistico con una cultura
politica e filosofica solida, un uomo di principi tanto fermi
da rifiutare il mondo accademico e quello della grande editoria.
I due, dapprima con qualche perplessità e fatica, poi
con entusiasmo, cominciano a scrivere canzoni, ovviamente Roversi
il testo e Dalla la musica. I primi due dischi che escono dal
loro sodalizio suonano sperimentali oggi, all’epoca saranno
apparsi marziani, infatti non vendono bene. I produttori della
RCA, che si aspettavano l’eterna ripetizione di “Gesù
bambino” e “Piazza grande”, corrono ai ripari,
violentano il terzo disco estromettendone dei brani e cambiando
l’ordine della scaletta. Dalla con qualche mugugno finisce
per acconsentire, Roversi si indigna e rompe il sodalizio, rifiutandosi
persino di firmare l’album col proprio nome (uscirà
con lo pseudonimo Norisso).
L’automobile, simbolo della modernità
La collaborazione con Roversi pone Lucio Dalla all’avanguardia
della canzone politicizzata, con un’opera che si può
ritenere il più grande saggio musicale sulla storia d’Italia
intorno al boom economico e alla sua crisi. Alcune canzoni sono
visionarie, altre narrative, altre ancora in forma di scrittura
automatica, con elementi di pura onomatopea corroborata da una
personalissima interpretazione della tecnica dello scat
(una specialità dalliana).
“Un auto taRgata TO”, il brano che dà inizio
a quest’epopea, racchiude in pochi versi un mondo presente
in tanti film (“Rocco e i suoi fratelli” di Visconti),
in tante canzoni, in tanti romanzi, ma che qui trova un linguaggio
che si fonde con le forme e le distorsioni che vuole rappresentare,
anche per virtù delle distorsioni e delle citazioni del
testo musicale. Un linguaggio che è narrazione e commento,
epica e critica, analisi, ironia e compassione. Al centro del
discorso c’è l’automobile: il simbolo della
modernità, di una modernità già condannata
dalla sua stessa simbologia – la velocità –
ad essere superata.
Un’auto vecchia torna/da Scilla a Torino,/dentro ci sono
dieci occhi/ed uno stesso destino./Il bambino ha una palla/ed
aspetta in cortile/con in mezzo poco sole,/poco sole di aprile./Il
ragazzo, inferriate e catene,/ha vent’anni:/son vent’anni
di pene!/La ragazza, venduta per ore,/nella campagna butta sangue
e sudore./La madre è una forma disfatta,/sopra gli occhi
ha i capelli di latta./Il padre è uno schedato, spiato,/se
si avventa sull’asfalto è inchiodato./Il paesaggio
è un’Italia sventrata/dalle ruspe che l’hanno
divorata./Arrivano nel ghetto, ammuffito, spaccato,/contano
i sassi dentro il filo spinato./Questo luogo del cielo è
chiamato Torino,/lunghi e grandi viali, splendidi monti di neve/sul
cristallo verde del Valentino,/illuminate tutte le sponde del
Po./Mattoni su mattoni,/sono condannati i terroni/ a costruire
per gli altri/appartamenti da cinquanta milioni.
Sull’automobile si apre il dramma. All’auto si contrappone
immediatamente il topos della mitologia classica di Scilla e
Cariddi; qui l’ironia compassionevole di Roversi la paròdia
in Scilla e Torino: come dire che i due mostri che
rendevano arduo il passaggio dello stretto di Messina per le
navi dell’antichità, sono, nella società
descritta da Dalla e Roversi, sia il Sud originario sia la meta
torinese, l’industrializzazione, la FIAT. Dentro la vettura
c’è una famiglia che torna a Torino; un mondo ben
conosciuto da una buona metà degli italiani: l’emigrante
che in occasione di una vacanza, di un matrimonio, di un battesimo,
di un funerale va a passare qualche giorno al paese d’origine
e ritorna. Stracariche di masserizie, le utilitarie affrontano
i mille e più chilometri della lunghissima Italia, che
le genti del nord pensano schiacciata e più corta di
quella che è, di modo che non si ha precisamente la cognizione
di quanto sia infinito il tempo e lo spazio che serve per percorrere
l’intera Calabria o le Puglie, dopo aver già disceso
tutta la penisola, di quante ore si passi chiusi nell’abitacolo
sempre più saturo. Le stimmate della miseria si misurano
anche da questa fatica del vivere miserabile.
I cinque personaggi stanno, isolati nel disastro collettivo,
la cui percezione individuale li appiattisce su un futuro già
scritto. Rotelle di un ingranaggio che li potrà far girare
o triturerà i più sfortunati, ma in cui è
difficilissimo percepire lo spiraglio di un riscatto, di una
vita da prendere in mano secondo i propri piani. Perché
la società industrializzata che queste canzoni vogliono
descrivere è un luogo che tende a trasformare tutto in
un prodotto, la fabbrica non fabbrica solo le automobili italiane,
ma fabbrica gli italiani per le sue automobili, è un
mostruoso incubo orwelliano, un’industria che forgia una
classe e un pensiero, l’industria che ha capito e che
si adopera a determinare la sua più grande risorsa che
non è il prodotto che fabbrica, ma i suoi stessi operai/clienti.
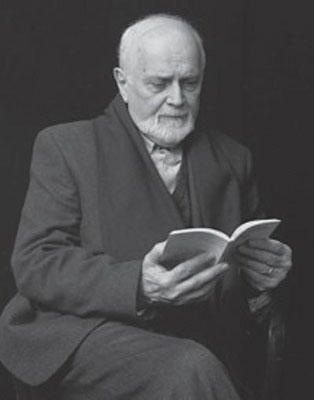 |
Roberto
Roversi |
“È il potere che offende”
In questa alienazione in cui l’uomo non fa più
parte della natura, in cui l’uomo è un nuovo agglomerato
di vita e tecnologia, lo spettatore inconsapevole della propria
vita, non si percepisce più il senso del sacrificio,
della fine, del passaggio. “L’operaio Gerolamo”
è una boccia sradicata che carambola per le capitali
dell’emigrazione (Torino, Germania, “Melano”,
Nanterre, periferia di Parigi), inseguendo la vita, puntualmente
raggiunto dalla morte, vede regolarmente alzarsi e calare il
sole, unico contatto con una realtà i cui confini sembrano
del tutto perduti. Tutti sognano continuamente di spostarsi,
andarsene, i morti abbandonati sul ciglio dell’autostrada
come i vivi in fuga dalla città per un fine settimana,
come i coatti del riformatorio Ferrante Aporti, come
l’operaio Gerolamo travolto da ogni successiva ondata
migratoria verso un chimerico paese ideale. “Non era più
lui” è la canzone che narra di un uomo completamente
distrutto dall’esperienza dell’emigrazione forzata,
che non ritrova più i suoi sentimenti positivi, non riesce
a stabilire più rapporti coi suoi simili e finisce per
sfogare la propria alienazione in stazione a guardare i treni
senza più nemmeno l’idea del ritorno. A quest’alienazione
fa contrappeso quella di Emilia Villesi, donna qualunque
(forse incinta) che per stanchezza di vivere, si suicida gettandosi
nel Po: non è il suicidio romantico di un poeta che corre
contro la sua tempesta, piuttosto una resa all’orrore
del vivere magro e inutile del quotidiano, sapendo che i propri
giorni non possono cambiare, è l’eutanasia della
vita intesa come un male inguaribile.
Apoteosi geniale di questa trilogia, tutta inarcata sulla corsa
del presente e dei suoi miti fondativi, la canzone “Le
parole incrociate”, dove usando lo schema dell’enigmismo,
si apre lo spaccato della storia dell’Italia dalla sua
unità, a partire proprio da quel generale Bava Beccaris
che fece aprire il fuoco sulla folla disarmata a Milano nel
1898.
Chi era Bava il beccaio? Bombardava Milano/correva il novantotto,
oggi è un giorno lontano./I cavalli alla Scala, gli alpini
in piazza Dom./Attenzione: cavalleria piemontese, gli alpini
di Val di Non.
E di seguito, parafrasate in giochi di parole, le vicende legate
alla repressione del brigantaggio, dei primi scioperi, alle
sommosse in seguito all’istituzione della tassa sul macinato,
ecc…
Sei le colonne in fila, il gioco è terminato/Nel bel
prato d’Italia c’è odore di bruciato./Un
filo rosso lega tutte queste vicende/Attenzione: dentro ci siamo
tutti, è il potere che offende.»
 Alessio Lega
Alessio Lega
alessio.lega@fastwebnet.it
|