|  Una bella Una bella
giornata?
Perché scrivere proprio dell’ultima fatica per il grande schermo di Checco Zalone, “Che bella giornata?” È presto detto: perché è stato il film campione di incassi della scorsa stagione raggiungendo, quindi, una fetta considerevole della popolazione italiana e propugnandole il suo immaginario.
Per chi non l’avesse vista, la pellicola in questione tratta delle disavventure del “bamboccione” Checco, trentenne di origini pugliesi installatosi da tempo nella verde Brianza e ancora saldamente a casa con mammà e papà. Il suo sogno è diventare un carabiniere, ma viene bocciato all’esame per l’ennesima volta e ripiega nel settore security. Grazie ad una raccomandazione del prete del suo paese, riesce ad ottenere un posto di vigilante nientepopodimenoche al Duomo di Milano, dove conosce una ragazza araba di cui si invaghisce, ma la sedicente studentessa è in realtà una terrorista che con il fratello progetta di far saltare in aria la Madonnina. A suon di gag e peripezie tra Milano e la Puglia, il nostro riuscirà involontariamente a sventare i foschi piani di Farah e suo fratello, ed alla fine nonostante la sua imbranataggine verrà promosso a guardia del corpo del Papa.
Come tutti i prodotti della cultura pop, il film offre interessanti spunti d’analisi rispetto a tematiche sociali e culturali che al suo interno vengono affrontate sempre con tono burlesco e scanzonato: proprio questa cornice ‘leggera’ costituisce il passepartout che permette agli autori di parlare ad un pubblico vastissimo, e di veicolare messaggi in modo più sotterraneo, implicito e forse quindi più incisivo rispetto ad un trattamento “serio”, esplicitamente didattico o comiziale.
Il tema principale qui è quello dell’incontro/scontro di civiltà: nel film esso è sintetizzato dalla relazione tra il super-italiano-tanto-medio-da-essere-sopra-la-media Checco (bamboccione, terronissimo, aspirante carabiniere) e la bella e colta, ma ingannatrice, Farah (che studia l’arte sacra italiana e fa colpo su tutta la pittoresca famiglia degli Zalone). Da una parte quindi l’ennesima riproposizione dello stereotipo dell’”italiano brava gente”, magari pasticcione, magari ignorante, magari tendente al fascio visti i suoi commenti (sulle donne: “questa volta la faccio addirittura parlare”, sul colore della pelle: “è un po’ negra, ma non dà fastidio”, sulla cultura: “tu studi vero? eh, non serve a un cazzo qui in Italia”), ma in fondo dal cuore d’oro, e dall’altra l’immagine tipicamente colonialista dell’”altro”, in questo caso la cultura araba, come oggetto esotico e affascinante sì, ma sostanzialmente scaltro, traditore, pronto a fregarti se ti lasci sedurre invece di mantenere la dovuta distanza gerarchica e gerarchizzante, quella su cui si fondano l’atteggiamento e la pratica coloniali anche e soprattutto da un punto di vista culturale.
In diversi momenti del film la questione delle culture a confronto (e scontro) viene tematizzata apertamente: nella scena della cena a casa Zalone, siedono allo stesso tavolo addirittura due terroristi arabi in incognito (che si spacciano per amici di Farah) e un soldato dell’esercito italiano appena rientrato per una licenza dall’Iraq, il padre di Checco. Quando uno degli arabi chiede conto a Zalone senior della sua presenza nel paese di Babilonia, costui gli risponde candidamente che non ci “devo rimanere per sempre: appena finito di pagare il mutuo me ne vado”. “È per questo che state in Iraq? Per il mutuo? È questo il vostro ideale?” chiede l’arabo esasperato. “Guagliò, mi danno 6000 euro al mese e non faccio un cazzo... per me è l’ideale” chiosa l’italiano.
Come leggere una sequenza di questo tipo? Ogni spettatore la legge e la interpreta a modo suo, secondo i suoi orientamenti culturali, politici etc. Qui vorrei solo far notare la densità del testo cinematografico e dei significati da esso estrapolabili (persino in un film di Checco Zalone!). Se da una parte infatti è possibile dare una lettura “dominante” di scene come quella descritta qui sopra e quindi leggerla coma una banalizzazione atroce di un fatto tragico come la guerra che ancora una volta riconduce tutto l’universo ad una burletta e fondamentalmente salva moralmente il soldato perché è un bravo e simpatico cristiano che anche se uccide lo fa per il mutuo, per provvedere alla sua famiglia, dall’altra è possibile leggere il tutto in modo oppositivo, e quindi considerare che vengono messi alla berlina per la loro ignoranza, il loro cinismo e la loro insensibilità gli atteggiamenti del soldato italiano e di suo figlio (tutto fiero e completamente acritico nei confronti di papà), mentre la durezza delle espressioni degli invitati arabi fa da contraltare alla loro cialtroneria.
 Michele Lembo Michele Lembo
 Una scuola senza voti Una scuola senza voti
né bocciature
È possibile imparare senza essere obbligati a frequentare lezioni? Senza essere sottoposti a voti e alla minaccia di una bocciatura?
Liberi di imparare, di Francesco Codello e Irene Stella (Terra Nuova Edizioni, Via Ponte di Mezzo 1, 50127 Firenze / pagg. 180, € 12,00) risponde di sì attraverso le voci e le esperienze concrete di coloro che animano le scuole democratiche libertarie in Italia e nel mondo. Racconta e descrive, non eludendo riflessioni più critiche, un modo di vivere la scuola costruito sulla convinzione che ogni bambino e ogni ragazzo sa cosa vuole imparare veramente e, se lasciato libero e autonomo, lo fa in maniera originale e positiva. Che cos’è una scuola democratica e libertaria, quali sono le caratteristiche principali e quali le sfumature che distinguono le diverse realtà presenti nel mondo? Le risposte a queste domande vengono offerte presentando le esperienze in corso in diverse aree geografiche; conducendoci in un viaggio introduttivo nell’arcipelago di queste pratiche autenticamente alternative al sistema dominante di istruzione. Una volta definite sinteticamente le caratteristiche più salienti di questi spazi educativi, vengono rintracciate, all’interno di ogni singolo elemento distintivo, le matrici culturali e le anticipazioni storiche che hanno stimolato e stimolano, ancor oggi, queste esperienze libertarie. Un intero capitolo è dedicato a una ricognizione storica e teorica dell’insegnamento libertario. In queste pagine potrete trovare i principali riferimenti teorici e i dibattiti che hanno sostenuto e sostengono la validità di questi progetti educativi.
Parte del libro dà voce ai diretti interessati: studenti, insegnanti e genitori sono stati intervistati sulle loro esperienze e su alcuni temi controversi, come ad esempio il rapporto dei ragazzi con il mondo esterno alla scuola democratica. Così vengono illustrate le scuole democratiche del mondo per assaporare, da una parte, le peculiarità di ciascuna e, dall’altra, lasciarsi affascinare dal fatto che anche culture assai distanti trovano in questo modo di vedere la scuola un terreno comune. C’è infine una parte tutta dedicata all’Italia: quali sono le leggi, le situazioni, i progetti in corso e le scuole già all’opera.
Questo libro, insomma, primo nel suo genere in Italia, vuole colmare una lacuna, riempire un vuoto, riconoscere una storia e un presente e anche augurare un futuro all’educazione libertaria e democratica, affinché al centro del progetto educativo vi siano veramente i bambini e i ragazzi, la libertà e l’autonomia, la riscoperta del vero significato di educare. Questo lavoro non ha, però, alcuna pretesa di esaurire il tema, anzi! Si propone piuttosto come uno stimolo per insegnanti, educatori, genitori ma, soprattutto, per i ragazzi e le ragazze che desiderano sperimentare e inventare un’educazione libertaria e realizzare una scuola diversa. Non è facile nel nostro paese pensare e progettare un’uscita dal sistema di istruzione statale e burocratico, per favorire la nascita di una scuola comunitaria e pluralistica, a-confessionale e aperta al mondo. Ma è, forse, l’unica strada percorribile per garantire fin da ora a noi stessi e ai nostri figli un mondo un po’ più giusto e libero.
Questo testo ha la potenzialità di accender discussioni, sviluppare nuove ricerche, porre interrogativi, insomma poter costituire uno strumento per portare questi temi al centro di un comune sentire.

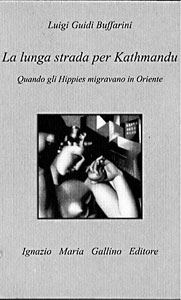 Con mezzi Con mezzi
improvvisati
La lunga strada per Kathmandu. Quando gli hippies migravano in Oriente (Gallino editore, Milano 2011, pp. 220, euro 12.50) di Luigi Guidi Buffarini è la storia, non troppo romanzata (il che non guasta) del viaggio da lui compiuto assieme ad un gruppo di italiani verso la mitica città di Kathmandu, luogo d’approdo ricercato sulla via delle indie, riscoperta dagli hippies dell’occidente, alla ricerca della spiritualità negata e vilipesa dal capitalismo consumista e materialista. Una spiritualità interiore che andava ritrovata, a partire dallo sviluppo delle proprie facoltà psichiche, con l’aiuto di sostanze stupefacenti di cui si diceva, in parte a ragione, che il viaggio e la permanenza in quella città avrebbe favorito.
L’autore riprende in mano il suo vecchio taccuino di viaggio per riproporlo come documento di un periodo che fotografa, alla fine degli anni sessanta e all’inizio dei settanta del secolo scorso, l’andata verso quei luoghi di una parte, sociologicamente rilevante, del movimento giovanile che stava contestando le cosiddette società del benessere, quelle neocapitalistiche per usare un termine caro alla saggistica di quegli anni. Erano gli hippies, originariamente nati in America nella seconda metà degli anni sessanta, sull’onda delle lotte studentesche contro la guerra del Vietnam e della rivolta dei neri degli Stati Uniti. La società andava cambiata a partire dall’adozione di stili di vita alternativi, da praticare immediatamente. Ciò comportò una sorta di secessione dalla società corrente, attraverso la creazione di comunità giovanili che adottavano stili di vita alternativi. La “fuga” dal modello occidentale comportò anche la ricerca di mondi nuovi, di uomini e donne appartenenti a società diverse. Così in quegli anni un discreto flusso di giovani viaggiatori con mezzi improvvisati, si avventurarono via terra verso la Turchia, l’Iran, il Pakistan, fino all’India. Stessa cosa fecero i “nostri” italiani qui descritti. A bordo di un Ford transit di seconda mano affrontarono un viaggio di migliaia e migliaia di chilometri incontrando inevitabili imprevisti e una umanità varia di occidentali che si muovevano, come loro, su quella rotta intersecando le loro vite e le loro mentalità con quelle delle popolazioni locali che contattavano inevitabilmente durante il viaggio.
Senza mai cedere al richiamo di farne un romanzo, il libro mantiene sempre il tono di un taccuino di viaggio dove sono registrati fatti ed eventi inerenti la quotidianità vissuta durante il percorso. Le difficoltà e i problemi legati alla persona: la sete, le malattie intestinali, i pernottamenti in alberghi a basso prezzo e quindi con pessime condizioni igieniche, i nuovi compagni di viaggio, raccattati durante il percorso, quasi tutti con storie personali borderline. I non facili incontri con le popolazioni locali costrette al contatto con questi giovani occidentali, così diversi dai loro usi e costumi, le quali cercavano in tutti i modi di trarne qualche guadagno. Sullo sfondo, tra le righe, emerge prepotente la descrizione di paesaggi naturali stupefacenti, diversi da quelli europei, vissuti però, almeno nell’esperienza di chi racconta, col disincanto dovuto. Ad esempio, di fronte allo spettacolo estetico rappresentato da un deserto o da una notte stellata, egli afferma che in alcune situazioni, lo avrebbe scambiato con una bottiglia di acqua minerale fresca e pulita.
Allo stesso modo la vita sociale e politica dei vari paesi che attraversano resta sulla sfondo, certo empiricamente vedono l’ingiustizia, la miseria, la fame, il degrado dei costumi civili, almeno secondo i parametri occidentali. Il viaggio è descritto con ricchezza di particolari, senza farne però un mito, come non sono mitizzati i protagonisti, colti nelle loro debolezze e difficoltà, e neanche le popolazioni locali. Non si concede nulla al mito del “buon selvaggio”, della società primitiva e incontaminata. Se mai si tende a misurare la distanza che li separa da quei luoghi e da quelle civiltà. In fondo il loro scopo è il viaggio, è raggiungere Kathmandu. Obiettivo non tradito, neanche dal Ford transit che, a parte alcuni prevedibili guasti riparabili, mantiene fede alle buone referenze tecniche di cui gode e li porta nella città. L’autore non trae grandi conclusioni e riflessioni sociologiche dal suo racconto. Ma chiunque voglia farlo non ha difficoltà a cimentarsi in quanto i fatti narrati già sono, di per sé, una documentazione sociale di prima mano.
 Diego Giachetti Diego Giachetti
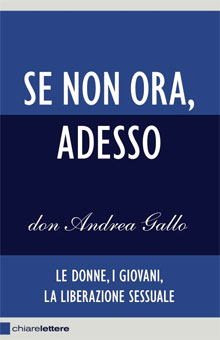 Don Gallo, profeta Don Gallo, profeta
dei nostri tempi
È recentemente uscito Se non ora, adesso (sottotitolo: “Le donne, i giovani, la liberazione sessuale”), ultimo libro di don Andrea Gallo. Il volume (Chiarelettere, Milano 2011) ha la prefazione di Moni Ovadia. Il prete Andrea e l'ebreo Moni, due persone che ci onoriamo di avere tra i nostri amici. Riproduciamo qui, con il suo titolo, la prefazione di Moni Ovadia..
Don Andrea Gallo, prete da marciapiede come lui stesso si definisce, è uno dei sacerdoti più noti e più amati che abitino il nostro disastrato paese. Centinaia di migliaia di persone lo sentono come un fratello, moltissimi fra costoro lo considerano una guida, un maestro, un compagno nell’accezione militante del termine, ma il Gallo è prima di tutto e soprattutto un essere umano autentico. In yiddish si dice «a mentsch».
La nostra nascita nel mondo come donne e uomini è un evento deciso da altri anche se la costruzione in noi del capolavoro che è un essere umano autentico dipende in gran parte dalle nostre scelte.
Il tratto saliente di questo percorso è l’apertura all’altro laddove si manifesta nella sua più intima e lancinante verità, ovvero nella sua dimensione di ultimo, sia egli l’oppresso, il relitto, il povero, l’emarginato, il disprezzato, l’escluso, il segregato, il diverso. L’apertura all’altro, sia chiaro, non si manifesta nel melenso atto caritativo che sazia la falsa coscienza e lascia l’ingiustizia integra e perversamente operante, ma si esprime nella lotta contro e ingiustizie, nell’impegno diuturno per la costruzione di una società di uguaglianza, di giustizia sociale, in una vibrante interazione di pensiero e prassi con una prospettiva tanto laicamente rivoluzionaria, quanto spiritualmente evangelica.
Il «Gallo» è radicalmente cristiano e sa che il messaggio di Gesù è un messaggio rivoluzionario, radicale e non moderato, ed è per questo che l’hanno messo in croce, per la destabilizzante radicalità del cammino che indicava. «Beati gli ultimi perché saranno i primi» non è un invito a bearsi in una permanente condizione di minorità per il compiacimento delle classi dominanti, ma è un’incitazione a mettersi in cammino per liberare l’umanità dalla violenza del potere, per redimerla con l’uguaglianza.
La parola ebraica ashrei, correntemente con beato, si traduce meno proditoriamente con in marcia, come propone il grandissimo traduttore delle scritture André Chouraqui. È questa consapevolezza che fa di don Gallo un profeta e non nell’accezione volgare e stereotipata con cui spesso si vuole sminuire o sbeffeggiare il ruolo di questa figura, ma nel senso più profondo di uomo che incarna la verità dei grandi pensieri ripetutamente e capziosamente pervertiti dai funzionari del potere, siano essi i soloni del regno terreno, siano essi i chierici del cosiddetto regno celeste.
 |
Don Andrea Gallo (foto Pino Bertelli) |
Questa è la ragione per la quale il profeta trasmette la parola del divino e il divino del monoteismo ha eletto come suo popolo lo schiavo e lo straniero, l’esule, lo sbandato, il fuoriuscito, il diverso, il meticcio avventizio perché tali erano gli ebrei e non un popolo etnicamente omogeneo come oggi vorrebbe uno sconcio delirio nazionalista.
In questa sua fondamentale opera che deve essere letta da chiunque voglia capire le parole illuminate di questo prete da marciapiede, Gallo ci ricorda che l’etica è più importante della fede, come il filosofo e grande pensatore dell’ebraismo Emmanuel Lévinas suggerisce nel suo saggio Amare la Torah più di Dio. Come già il profeta d’Israele Isaia dichiara con parole infiammate, il Signore stesso chiede agli uomini di praticare etica e giustizia perché disprezza la fede vuota e ipocrita dei baciapile:
Che mi importa dei vostri sacrifici senza numero. Sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso dei giovenchi. Il sangue di tori, di capri e di agnelli Io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi a me, chi richiede da voi che veniate a calpestare i Miei Atri? Smettete di presentare offerte inutili, l’incenso è un abominio, noviluni, sabati, assemblee sacre, non posso sopportare delitto e solennità. I vostri noviluni e le vostre feste io detesto, sono per me un peso, sono stanco di sopportarli. Quando stendete le mani, Io allontano gli occhi da voi. Anche se moltiplicate le preghiere, Io non ascolto. Le vostre mani grondano sangue. Lavatevi, purificatevi, togliete il male delle vostre azioni dalla mia vista. Cessate di fare il male, imparate a fare il bene, ricercate la giustizia, soccorrete l’oppresso, rendete giustizia all’orfano, difendete la causa della vedova.
Il profeta autentico non predice il futuro, non è una vox clamans nel deserto, è l’appassionata coscienza critica di una gente, di una comunità, di un’intera società, ed è questa coscienza che si incide nella prole perché le parole diventino fatti, azioni militanti a ogni livello della relazione interumana e per riconfluire in parole ancora più gravide di quella coscienza trasformatrice. Questo è a mio parere il senso che don Gallo attribuisce al primato della coscienza espresso mirabilmente nel documento conciliare Nostra Aetate uscito dal Concilio vaticano II voluto da Giovanni XXIII, il «papa buono», ma buono perché giusto. Con il poderoso strumento della sua coscienza cristiana, antifascista, critica, militante, laica ed evangelicamente rivoluzionaria, il prete cattolico Gallo riesce a confrontarsi con i temi socialmente più urgenti ed eticamente più scabrosi, smascherando moralismi, le rigidità dottrinarie, le ipocrisie che maldestramente travestono le intolleranze per indicare il cammino forte della fragilità umana come via per la liberazione.
Quest’ultima e intima verità dell’uomo, Andrea Gallo la conosce, la sente e la ritrova nelle parole più impegnative delle scritture perché istituiscono l’umanesimo monoteista, ma anche l’umanesimo tout court nella sua dirompente radicalità: «Ama il prossimo tuo come te stesso, ama lo straniero come te stesso, ciò che fai allo straniero lo fai a Me».
La passione per l’uomo, per la vita e per l’accoglienza dell’altro si coniugano in questo specialissimo uomo di fede con un folgorante humor che dissipa ogni esemplarità predicatoria per aprire la porta del dialogo fra pari a chiunque voglia entrare, cristiano o musulmano, ebreo o buddhista, credente o ateo. In don Gallo si compie il miracolo dell’ubiquità: lui è radicalmente cristiano e anche irriducibilmente cattolico, ma potrebbe anche essere uno tzaddik chassidico, così come è un militante antifascista e un laicissimo libero pensatore.
Per me il Gallo è un fratello, un amico, una guida certa, un imprescindibile e costante riferimento.
Per me personalmente, la speranza tiene fra le labbra un immancabile sigaro e ha il volto scanzonato di questo prete ribelle.  Moni Ovadia Moni Ovadia
|